Una lettura di: Yan Thomas, Il valore delle cose, Quodlibet [2002] 2022
In Appendice: Glosse e note a partire dalla lettura di Thomas, a margine dei seminari su Copyleft & Internauti pirati
Bernardo Prieto
English abstract
Sie sind Landvermesser und haben keine Landvermesserarbeit.
Franz Kafka, Das Schloss
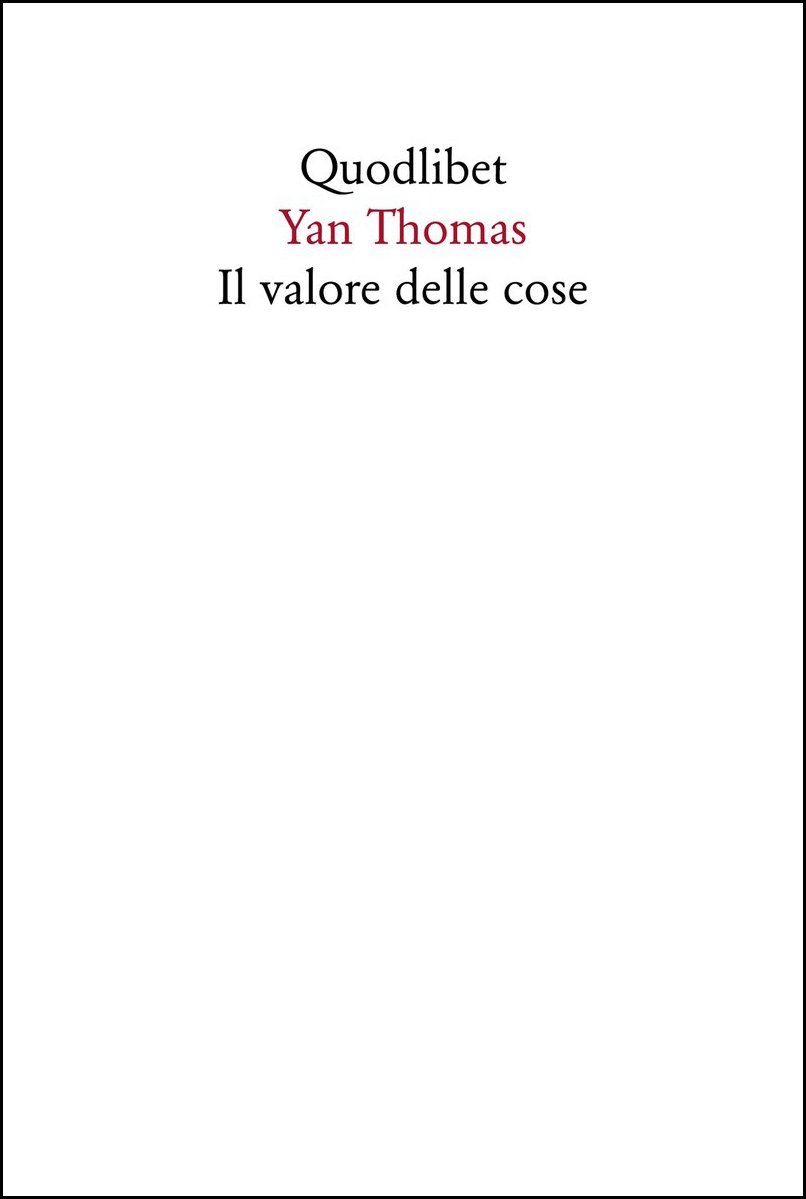
Questa nota si propone di presentare l’importante studio di Yan Thomas (Il valore delle cose) nella sua versione italiana. Il volume, pubblicato da Quodlibet in una prima edizione nel 2015 e riproposto in una nuova versione nel 2022, è accompagnato da un’introduzione di Giorgio Agamben (Tra il diritto e la vita), uno studio di Michele Spanò (Le parole e le cose [del diritto]) e una Appendice (L’artificio delle istituzioni), che è la traduzione di un testo, scritto originalmente in spagnolo dallo stesso Thomas come prefazione a un’antologia della sua opera. Lo studio centrale (La valeur des choses. Le droit romain hors la religion) nella sua prima versione si trova edito come parte delle “Annales de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales”, del 2002.
Stando alle parole di Yan Thomas: “La storia del diritto deve occuparsi, credo, degli oggetti molto più che delle idee” (così a p. 72 [tutti i riferimenti sono all’edizione Quodlibet del volume oggetto di questa lettura]). In queste righe cerchiamo di evidenziare quello che, dal nostro punto di vista, costituisce la struttura logica dell’argomentazione di Thomas e uno dei fondamenti più importanti dell’arte e della tecnica giuridica da lui usata: quella sorta di filologia giuridica che non si discosta mai dal testo e dagli esempi concretissimi e che evita, a ogni costo, di cadere nella “noia mortale delle generalità” (p. 70). E infatti Thomas ha definito il suo lavoro come una specie di archeologia, ovvero la decodificazione della storia materiale che “serve per fabbricare le ’cose’ istituzionali di cui sono fatte le organizzazioni sociali”, per trovare, al di là dell’opera o dell’autore studiato, quegli elementi minimi che costituiscono “una specie di continuo sottotesto” (p. 74): una sorta di pars pro toto della filologia giuridica. Thomas, in questo senso, tende a figurare il diritto come un vero e proprio artificio: un montaggio fatto di parole che ha come risultato la realizzazione di ciò che enuncia (p. 69); la tecnica corrispondente (ars iuris) si stabilisce come una forma di separazione procedurale o, nelle parole di Agamben, “funzionale e pragmatica” (p. 14) e mai come una sorta di definizione ontologica. Per questa stessa ragione, Michele Spanò può scrivere che “il diritto civile di Yan Thomas segnala perciò anche un’uscita dal teologico-politico” (p. 79).
L’ars iuris che Thomas identifica (e difende) è una sorta di arbitrarietà assunta che, soprattutto, ha a che fare con le decisioni e non con la conoscenza, e che ha come centro attivo la separazione: il legale dall’illegale, la legge dalla trasgressione e, in un ultimo ma decisivo movimento, il potere del soggetto (p. 72). L’identificazione successiva, tipica del diritto moderno, fa del soggetto, e non della causa o del processo, il centro della sua operazione giuridica originaria, trasformando o, meglio, confondendo “vita e diritto” (p. 12). Che lo spostamento dalle cose ai soggetti sia la caratteristica del diritto moderno non è solo sintomo di una sorta di trasformazione forse pericolosa, trasformazione che, per esempio, è evidente nella filosofia giuridica di Kelsen: infatti, l’astrazione dottrinale (cioè il diritto come semplice espressione formale di una dottrina giuridica superiore) è una trappola di natura ontologica che lega irrimediabilmente il “dover essere” come unica forma possibile del soggetto (che diventa appunto “soggetto di diritti”). La denuncia di Thomas contro la ricostruzione dogmatica del diritto romano somiglia alla sottile denuncia del filologo Giorgio Pasquali contro il pregiudizio dell’originalità dell’antigrafo; la supposta “dottrina giuridica” che, dal romanticismo tedesco in poi, si è cercato di ricostruire e che ha ispirato lo studio del diritto romano, è in verità inesistente o, meglio, la sua creazione concettuale risponde a un’esigenza ermeneutica (in molti casi superflua e banale) prodotta da una sorta di collatio di diverse fonti. La parità concettuale tra antigrafo e apografo fa della filologia (e quindi della filologia giuridica) una risposta procedurale, aperta e attenta alla ricostruzione materiale di tutti i testi possibili, dei quali, contrariamente alla tesi lachmanniana, non esistono archetipi.
Il diritto, almeno il diritto romano nella prospettiva di Yan Thomas, non ha nulla a che vedere con i soggetti né con le idee, ma con le cose che esistono solo e in quanto vengono menzionate all’interno di un processo: è così che, per esempio, quando il giovanissimo Mozart riesce a trascrivere, dopo averlo ascoltato una sola volta, il celebre Miserere di Gregorio Allegri, permettendone grazie alla sua ‘copia pirata’ la diffusione in tutta Europa, questa famosa trascrizione (e non la melodia in sé) è la cosa che viene restituita al commercio delle cose profane (quella trascrizione costituisce dunque la ‘cosa’ del diritto). Dove appunto tanto il soggetto causante (Mozart) si trova solo temporaneamente legato (come per un breve tempo l’attore alla sua maschera) alla stessa causa. Infatti, l’approccio “ontologico” presenta molti problemi tecnici. L’importante studio di Thomas fa emergere le origini di questa finzione – il valore nella sua natura giuridica – da cui dipendono, nella sua oscura versione ipostatica, le nostre istituzioni moderne. Un addendum ultimo e marginale: Giorgio Agamben, nel suo saggio introduttivo, consiglia di leggere Il diritto di non nascere di Yan Thomas e Oliver Cayla insieme al testo di Marcel Mauss La nozione di persona; se ci è permesso operare un’armonizzazione cromatica a Il valore delle cose, consigliamo di leggere questo testo insieme a Kapitalismus als Religion di Walter Benjamin (1921), all’introduzione di Geschichte des römischen Münzwesens di Theodor Mommsen (1860), e a The Denationalisation of Money di Friedrich Hayek (1976).
Appendice | Glosse e note a partire dalla lettura di Yan Thomas, a margine dei seminari su Copyleft & Internauti pirati
Bernardo Prieto
Presentazione a cura di Filippo Perfetti
Pubblichiamo qui le Glosse e note che l’autore ha composto a partire dalla lettura del saggio di Yan Thomas, e a margine dei seminari tenutisi presso il centro studi classicA dell’Università Iuav di Venezia, in preparazione di questo numero di Engramma (28 ottobre 2024; 7 gennaio 2025; 4 febbraio 2025). Ad anticiparele è una nota sullo stile di queste glosse e sulla lingua dell’autore, che non è stata polita rispetto alle asperità di un italofono non madre-lingua
Tradursi è un furto | Scrivere in una lingua che non è la propria è come appropriarsi di un tesoro altrui. Lo si dovrebbe fare con circospezione, evitando di fare troppo rumore. Evitando che le parole che ci si porta in testa cozzino con quelle messe in tasca della refurtiva. Tuttavia, una volta prese le altrui parole, non è detto che le si possa o le si sappia usare. Spesso ci si trova con quelle che già si aveva, mascherate, come per gioco, nelle altre. Eppure, mascherare le parole, è già dar loro un altro senso, un’altra accezione; il difficile, però, è che esso coincida con quello dell’altra lingua. Costringere qualcuno a leggerti in un’altra lingua – peggio se la sua – è come renderlo complice del furto. Si potrebbe finire entrambi arrestati: uno nel non capire se stesso, l’altro nel non capire più la sua lingua. Con la beffa che a essere defraudato potresti essere tu, ladro o pirata, avendo perso la cosa che volevi dire, nel giro di una frase voltata da una lingua all’altra.
* * *
Adversaria anthropologica | Che tutto sia interpretazione è indiscutibile, così come lo è il fatto che alcune interpretazioni siano più aberranti di altre. La violenza testuale, infatti, si manifesta in una sottile forma di gesuitismo: il lassismo morale – o testuale – non è certo utile per leggere i testi con delicatezza. Occorre evitare che i nostri limiti cognitivi si trasformino in principi teorici o, peggio ancora, in articoli. In questo senso, Yan Thomas rifiuta le letture antropologiche del diritto romano perché confondono le istituzioni con strutture mentali, non riuscendo a cogliere davvero la finzione giuridica come la tecnica operazionale, o meglio processuale, propria del diritto. In altre parole, adattano i fatti alla teoria, proprio come i cattivi gesuiti adattano la morale alle circostanze. Pasolini diceva che la colpa dei padri, nel teatro greco, gli sembrava un’idea antropologicamente ingenua (sebbene l'abbia poi scoperta spaventosamente vera). Noi allora procediamo come gesuiti, attraverso serie di note o di glosse, descrivendo non tanto i complessi meccanismi formali, quanto le strutture mentali e le loro idiosincrasie. A dispetto di Diderot o Pascal, seguiamo un metodo gesuitico leggendo Thomas, solo per scoprire, in un campo estraneo alla sua raffinata arte ermeneutica, che gli ingenui – proprio come è stato Pasolini – siamo noi.
Appunti e segreti | Dobbiamo alla curiosa iniziativa di Charles Bally e Albert Sechehaye la raccolta e l’edizione del famoso Cours de linguistique générale di Saussure. Un libro che, oltre a essere una raccolta delle sue lezioni, è al contempo la pietra angolare della linguistica moderna. Gli appunti degli studenti costituiscono un genere a sé stante: quella forma di scrittura, spesso poco rigorosa e piena di entusiasmo, che, come chi ascolta una melodia per la prima e unica volta, cerca di trascriverla affidandosi alla memoria e alla propria abilità tecnica, catturando la voce negli angosciosi ma duraturi grámmata. L’edizione di tali testi, proprio per questo, è un vero problema filologico che, tuttavia, è stato risolto attraverso un criterio musicale. Il montaggio degli appunti risponde a un modello compositivo in cui devono essere inseriti forzatamente diversi temi e le relative esposizioni. La nostra tradizione occidentale è colma di libri importanti (Hegel e le sue diverse Lezioni, Aristotele e la Poetica, l’Opus postumum di Kant, ecc.), i quali, almeno in origine, non erano altro che appunti presi dagli studenti per non dimenticare (o per dimenticare più facilmente, seguendo il Platone del Fedro) le parole dei maestri. Le note (al di là di qualsiasi elaborata edizione) ci ricordano quella oralità essenziale e primigenia, oralità dalla quale Derrida ha preteso di ribellarsi. Senza tali note, forse, la nostra tradizione sarebbe più vicina ai misteri eleusini che alla comune pettegolezza di paese.
Forma e contenuto | Senza nemmeno dover cercare troppo, si possono acquistare gli appunti (in base al professore, all’anno e alla materia) delle diverse lezioni universitarie e così, senza aver effettivamente frequentato i corsi, studiarne il contenuto. Il problema non risiede nel prodotto in sé o nell’operato di questa sorta di zelanti amanuensi che, con l’ausilio dei loro cellulari e di Chat-GPT, creano queste simpatiche summae, bensì nel loro successivo commercio. Il commercio di tali appunti non ha nulla a che vedere, ad esempio, con la preservazione della memoria del maestro o con una semplice solidarietà corporativista (gli studenti sono forse la corporazione più vasta), ma si configura piuttosto come la risposta diretta e sensata (sensata nei limiti della stupidità e della pragmaticità) di chi desidera superare un esame. L’esame è dunque il primum movens immobile che provoca questa sorta di tradimento e oscuro commercio. Il fatto definito da Yan Thomas, secondo cui il sacro e il pubblico (che si trovano fuori dal commercio delle cose) si legittimano in quanto il luogo (un tempo determinato dalla figura dell’agrimensore romano) è stato dichiarato pubblico o sacro e, proprio per questo, tutto ciò che gli appartiene (anche se solo temporaneamente) non può essere messo sul mercato, ci illumina per converso sulla nostra triste realtà. Le università (forse tra i pochi luoghi pubblici per eccellenza) sembrano aver perso la loro natura di veri luoghi pubblici, entrando nel gioco legalistico della conoscenza e nelle ridicole regolamentazioni burocratiche del sapere. Questo è solo uno dei tanti problemi che questa “ontologia giuridica” ci ha lasciato in eredità, cercando ostinatamente di definire la forma e il contenuto del sapere.
Dictum | Non perché si può scrivere si deve pubblicare, non perché si può pensare si deve scrivere. Ci sono melodie che, dopo essere state canticchiate, dovrebbero rimanere nella pura potenza, cioè in ciò che chiamiamo oblio.
Ladro che ruba a ladro | Borges, nel saggio intitolato La flor de Coleridge, ci ricorda come Oscar Wilde fosse solito regalare argomenti affinché altri scrittori ne scrivessero le storie; una tale generosità sembra legarsi a un’interpretazione impersonale dell’arte e della conoscenza. Contro la noetica tomista, si potrebbe dire che la storia della letteratura, dell’arte o, meglio ancora, del pensiero, sembra svilupparsi in termini averroisti. O, almeno, così agiscono coloro che confondono “lo scrittore con la letteratura” e devotamente “citano senza virgolette”. La copia è sempre un elogio (timido o capriccioso). Il furto è un’appropriazione dolosa di ciò che si ama, forse disordinatamente. Nessuno raccoglie ciò che disprezza, né custodisce ciò che considera spazzatura. O, in una formulazione cinica: ognuno apprezza una spazzatura diversa, o, il che è lo stesso, ognuno si distingue per i suoi specifici disprezzi.
Furtum illud pirorum | La psicoanalisi, che è un’estensione virulenta della teologia agostiniana, ci ricorda il piacere (quasi inarrestabile) della trasgressione. Quello che si è chiamato inconscio non è altro che una forma secolarizzata del peccato originale (non per nulla Agostino ricorda che, come frutto del peccato, sebbene possiamo disporre a volontà di quasi tutte le parti del nostro corpo, non siamo totalmente in grado di controllare – indovinate quale – una in particolare). Ora, per restare in ambito teologico, l’ignoranza attenua la colpa, ma non toglie la pena. Chi pecca per ignoranza, pecca comunque. E tutti coloro che hanno letto o scaricato un libro o un articolo ‘pirata’ godono non solo perché finalmente hanno nelle loro mani qualcosa che ritenevano imprescindibile, ma anche perché hanno risparmiato un po’ (o molto) denaro. La trasgressione insaporisce il loro piacere momentaneo. Le biblioteche pubbliche che vogliono essere ancora rilevanti dovrebbero promuovere (contro ogni trasgressione) una sorta di sacramento purificatore: rendere accessibili in libertà i frutti della sapienza umana. E, come veri fantasmi, in una nostra particolare damnatio memoriae, nessun professore serio e nessuno studente timido sembrerebbe disposto a dichiarare pubblicamente di usare e leggere fonti ‘pirata’. Dato che, in un’operazione complessa, abbiamo legato la lettura alla colpa, allora chi potrà liberarci da questo piacere?
Sola scriptura | Il modo di leggere di Lutero presuppone, in modo interessante, un originale, il quale è accessibile secondo grazia o per intelligenza. Questo modo di leggere è una passione monotematica. La tradizione cattolica, invece, conosce l’originale solo attraverso qualcosa che chiama tradizione. Ogni epoca, nella sua reinvenzione, traduce nel proprio linguaggio il tesoro del Vangelo.
Manuzio come eroe | Il diritto d’autore, secondo la legislazione italiana, è sancito nella Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), la quale, nei suoi 206 articoli, tutela le opere d’ingegno, che si trovano, quasi fossero reliquie, sotto la sua vigile protezione. Tuttavia, all’art. 6 si manifesta, come avviene nel diritto moderno, la necessità di stabilire quel soggetto di diritti (poiché non esistono più cose, ma solo soggetti: attori irrimediabilmente legati alla loro maschera) a cui associare le cose. Un esame sommario della legge mostra le difficoltà, in molti punti, nel determinare la proprietà intellettuale. Per esempio, l’art. 7 è cristallino nella sua ambiguità: “È considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa. È considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro”. Per comprendere tutte e ciascuna di queste prescrizioni metafisiche – perché cosa significa limiti del lavoro? – si rende necessaria una regolamentazione: è lì che si svolge il vero e oscuro gioco del diritto. Non nella legge in sé, ma nella sua interpretazione positiva. Soffermiamoci ora sugli articoli tredicesimo e quattordicesimo della legge. Il primo recita: “Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma […]” (art. 13). Questo articolo e la sua regolamentazione potrebbero benissimo accompagnarsi a un seminario sul celebre e postumo (in senso nietzschiano) saggio di Walter Benjamin sull’opera d’arte. L’articolo successivo è senza dubbio ancora più interessante: “Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l’uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell’articolo precedente” (art. 14). In questo caso, il concetto di trascrizione è strettamente legato a quello di riproduzione, poiché, sebbene la legge abbia separato i due casi (artificialmente, come sostiene Thomas), da un altro punto di vista sono esattamente la stessa cosa. Mi soffermo su queste importantissime minuzie (dal punto di vista formale) perché credo che esse mostrino come il diritto abbia invaso ogni ambito della nostra vita, quasi fosse un oscuro esoscheletro. Ha prodotto una sorta di malessere che, mentre cerca di ordinare il mondo in modo maniacale, finisce per distruggerci con altrettanta forza. Una vita risolta nel diritto diventa una vita vuota. Un’esistenza in cui persino gli atti e le decisioni più intime sono regolati e tutelati permette la presenza costante della violenza legittima; in altre parole, la presenza permanente dello Stato. Così, più leggi significano più burocrazia, e più burocrazia significa più violenza. Il fatto che per vivere pienamente si debba diventare avvocati (o averne uno a disposizione) mostra semplicemente la miseria della nostra vita comunitaria. Per questo motivo, tornando al problema della riproduzione e della trascrizione, credo sia il momento giusto per recuperare Aldo Manuzio come eroe: quel titano dell’editoria, anche con la sua ardente pazienza, forse non avrebbe potuto portare a termine la sua impresa monumentale con le leggi attuali. Eppure i suoi libri, quei portatiles (che tanto prefigurano i nostri telefoni cellulari), rappresentano una sorta di verità materiale che il suo lavoro ci ha lasciato, come modello di libertà e di scienza.
Natural Kinds | Uno dei compiti archeologici più importanti della filosofia contemporanea è ricostruire la relazione tra il lessico proprio del diritto (la nozione di Legge legata all’essenzialismo ontologico) e la nascita della scienza moderna. Dupré e Cartwright sembrano aver intuito, per così dire, alcune delle conseguenze descritte da Thomas in un ambito che sembra lontano dalle sue preoccupazioni epistemologiche (ma che, grazie alla “legge del buon vicinato” warburghiana, sappiamo non essere così). Il fatto che il linguaggio della scienza sia invaso dalla tassonomia giuridica moderna è forse uno dei problemi più rilevanti che, ricordando Walter Benjamin, ci porterebbe a comprendere meglio il vero problema del nostro tempo: “la scienza come religione” (ovvero il scientismo nella lingua di Hayek).
Morte a Pasolini e altri eccessi | Il miglior modo di leggere Pasolini è in un’edizione pirata, o meglio: in un’edizione pirata ottenuta illegalmente. Qualsiasi edizione rubata a una biblioteca è persino superiore. Nessuno ha autorità se non colui che non la chiede o, come Giacobbe nella Genesi, colui che la ruba. Nessuno è padrone di una lingua, il poeta è dunque il miglior saccheggiatore. Il miglior modo di leggere Walter Benjamin è in traduzione. Il peggiore è in ebraico. In un grande archeologo e filologo esiste una pulsione corsara (latente o manifesta). Freud è un archeologo, Lacan un filologo. L’antitesi della trasgressione è il dovere, così come quella del ladro è il poliziotto. Solo l’uomo libero, cioè l’uomo rivestito di grazia, come un ballerino evita le linee tracciate dall’agrimensore; come un bambino che gioca, non ha nulla a che fare con la compulsione o il peccato, ma con l’amore che lo trasforma e lo illumina. Una cosa è immaginarsi corsaro. Un’altra è morire come un cane. Dietro ogni moralismo si sente la voce di Lutero.
Libri e biblioteche | La letteratura e la filosofia (ciò che chiamiamo storia delle idee) hanno una dipendenza materiale impossibile da negare. Solo la musica popolare, quella cantata senza sapere, sembrerebbe eludere questa dipendenza di cui parliamo, poiché essa si caratterizzerebbe per avere una vita nello spirito, ovvero per poter sorgere e persistere senza la necessità di un supporto materiale che la sostenga (una registrazione, una partitura, ecc.). Tuttavia, come è evidente, anche la musica della tradizione popolare ha bisogno di depositarsi in qualche vaso: il corpo di tutti i trovatori. Così, affinché la musica continui a vivere, come un segreto sussurrato, essa deve essere trasmessa di generazione in generazione. Proprio per questo, la musica non può essere generata una volta sola e per sempre, ma in ogni momento esige la sua costante nascita e il suo rinnovamento. In questo senso possiamo meglio comprendere il celebre incipit di Dante nella Vita Nuova: il libro della propria vita – la memoria – che custodisce in sé il segreto della felicità. Questa oscillazione tra il medesimo e il differente può essere percepita, in modo ancora più chiaro, nella riproduzione umana, dove la vita stessa, come la musica, ha bisogno di essere costantemente generata per continuare a esistere. Ma questa materialità, nella sua profusione, non sembra forse nascondere qualcosa di simile all’idea di un assoluto? Dietro il concetto di archetipo, abusato in modo interessato da Jung e Neumann, si trova l’idea propriamente iconologica che dietro ogni immagine vi sia un essere che sostiene e genera la pluralità del mondo. In questo senso, le innumerevoli biblioteche, con i loro infiniti e diversi volumi, sarebbero parte di un unico grande libro, che si genera perpetuamente. Libri e biblioteche sono immagini cosmologiche alla nostra portata, così come ogni musica è il sussurro della prima creazione.
Sigillo accademico | Non solo molte tesi di dottorato sono superficiali o, nel migliore dei casi, diligentemente inutili. Perché l’erudizione non può nascondere la stupidità. Quei futuri professori, a forza di accumulare citazioni, dimenticano che saper cucire è solo una parte del mestiere del sarto. O, meglio ancora, diciamoci la verità: tutti sappiamo che l’imperatore è nudo. Perché continuare a prendere misure?
Sui poeti mediocri (I) | Che il poeta sia un pirata l’abbiamo già detto: anche il poeta mediocre lo è. Il problema è che il poeta mediocre ostenta il suo ingegno corsaro e decide di farne (del suo ingegno) il proprio abito linguistico: l’estasi poetica come mimesi della creazione. Di estasi in estasi, il pensiero si esaurisce prima di raggiungere la vera illuminazione. O, meglio ancora, per questi poeti mediocri la fecondazione è secondaria rispetto a qualsiasi tipo di piacere. Sarà per questo che amano tanto il sadomasochismo?
Sui poeti mediocri (II) | Ai poeti mediocri bisogna chiedere lunghi discorsi su sé stessi. Infatti, in contrapposizione alla loro artificiosa brevità, si rivelano grandi filosofi quando dissertano sulle loro piccole questioni ontologiche, ovvero quando fanno sfoggio del loro stile. Celebrano così tanto la copia che non sono altro che fantasmi di sé stessi. E ne vanno fieri.
Fantasie adorniane | Il potenziale artistico dell’hip hop trova la sua articolazione più importante nell’arte del sampling. Il sampling può essere descritto come l’utilizzo di suoni preregistrati – che possono provenire da vecchie canzoni, conversazioni, rumori, ecc. – per creare una nuova canzone. Questo anacronismo deliberato diventa, adattando un’espressione di Didi-Huberman, un vero e proprio montaggio dialettico dei suoni. Tuttavia, proprio il sampling è l’elemento più criticato – e la punta di lancia – del disprezzo verso l’hip hop. Per molti, la presunta incapacità di creare nuove melodie o basi ritmiche fa sì che i DJ e i produttori decidano di realizzare qualcosa che, agli occhi di questi apocalittici, appare come un furto. Chiaramente, nei peggiori casi, il sampling può risultare in una sorta di pessimo pastiche, ma, nei migliori, diventa qualcosa di simile alla realizzazione dell’idea di Walter Benjamin (di Adorno, è importante dirlo) di eseguire un’opera fatta esclusivamente di citazioni.
Nichilismo e profanazione | Nel nostro mondo pieno di falsi idoli è necessaria la profanazione dei loro templi e il disprezzo dei loro sacerdoti. Nel nostro mondo pieno di falsi credi è necessario proprio un vero nichilismo. Restituire al luogo profano ciò che falsamente è stato considerato sacro. Se vogliamo ascoltare la verità, dobbiamo, innanzitutto, liberarci degli antichi spiriti che abitano la nostra casa. In questo caso, l’operazione filosofica per eccellenza non è, come spesso si pensa, tanto un esorcismo quanto un battesimo (che, di fatto, include un rito esorcistico), ovvero restituire alla filosofia la capacità di dare nome alle cose e di offrire, in un certo senso, una seconda vita a tutto il creato.
Deadline | Non rispettare una deadline è certamente un atto piratesco: in sostanza, rubare il tempo agli altri. Ma non si deve giocare con la fortuna né abusare delle buone intenzioni altrui. Certamente, il mestiere di pubblicare e scrivere è portato avanti (al di là di molti e falsi romanticismi) da dame e gentiluomini benintenzionati: dotti, spesso molto eruditi.
Consigli di lettura | Se, come scrisse Edith Stein correggendo l’angelologia di Tommaso, ogni essere umano è un genere a sé, allora ogni grande libro è, in modo simile, unico. Per questo motivo, il miglior modo di leggere un grande autore non dovrebbe prevedere il tentativo di risolvere (cioè sintetizzare, creare un archetipo) le sue apparenti o reali contraddizioni, perché è proprio in esse che risiede la sua peculiare forza cognitiva. E infatti, come monito davanti a ogni grande libro, dovremmo ricordare questi versi di Whitman: “Mi contraddico?/ Ebbene sì, mi contraddico/ (sono ampio, contengo moltitudini)”.
Principio di censura | Nessuno morde la mano che lo nutre. Fece bene Spinoza ad andare diritto per la sua strada e a continuare a guadagnarsi onestamente il pane, e Socrate ad accettare una condanna ingiusta. Non è forse la disonestà intellettuale una vergognosa forma di codardia?
In numerum Sanctorum referre | Bisogna fare molta attenzione nell’elevare con troppa facilità gli uomini (soprattutto contemporanei) agli altari. La storia di Barabba e di Gesù di fronte alla folla ci insegna i molteplici equivoci del nostro giudizio storico. E, soprattutto, ci mette in guardia contro il giudizio degli intellettuali che, seguendo le proprie ferree convinzioni, tendono a lavarsi le mani rapidamente dai loro stessi vari fanatismi. Elevare agli altari i pirati, anacronisticamente, può forse servire come immagine poetica, ma ogni immagine ha i suoi limiti. Non sia mai che in futuro celebreranno uomini particolarmente loschi, dico, nel futuro.
Forma Sonata | La forma sonata descrive una struttura più o meno rigorosa in cui il brano musicale da comporre si divide in tre sezioni ben distinte: esposizione, sviluppo, riesposizione. Nella prima parte vengono presentati i due temi principali, che verranno poi ripresi e sviluppati nella seconda. Tuttavia, ciò che qui risulta interessante è la definizione stessa di tema principale: l’identità di tale tema può risiedere in un motivo melodico, in un motivo ritmico, in una specifica sequenza armonica o persino nella relazione intrinseca tra alcuni di questi elementi (incluso il timbro o la dinamica). L’aspetto più rilevante è che, sebbene sia possibile riconoscere questi temi principali (così come le loro successive variazioni), non esiste, per così dire, una sostanza che li contenga; o meglio, il tema non è rappresentato come una semplice somma delle sue parti perché, semplicemente, non si trova completamente in nessuna di esse, ma in tutte. E qui è importante ricordarlo: la suddivisione degli elementi sopra descritti è una pura astrazione arbitraria. Ora, questo implica che una vera e propria copia (ciò che chiamiamo plagio è una decisione giuridica, ma non una categoria musicale codificata) possa esistere solo se tutti e ciascuno degli elementi vengono riprodotti esattamente nello stesso modo (armonico, melodico, timbrico, dinamico, ecc.). Infatti, se io scegliessi, come spesso accade, di copiare soltanto la melodia, non farei altro che estrarre un elemento che, nella sua singolarità, non appartiene a nessuno (nemmeno al brano stesso). Le diverse trasformazioni e i giochi interni alla forma sonata ci mostrano, in effetti, quanto siano complesse e aperte queste relazioni modulari.
Mare Liberum | Nel 1690 Grozio scrisse un breve trattato a favore della libera navigazione e del libero commercio. Contro le pretese portoghesi, Grozio negava tanto l’imperium quanto il dominium esercitato sull’oceano. E infatti, almeno dal Digesto fino agli scritti del grandissimo Francisco de Vitoria, vigeva il principio di commeandi commercandique libertas nel mare. Per questo motivo, secondo Grozio, poiché il mare era una sorta di bene pubblico, qualsiasi tipo di restrizione commerciale, così come qualsiasi tentativo di appropriazione del territorio navigabile, era un atto illegittimo e illegale. Fu solo in un opuscolo successivo, intitolato Defensio Capitis quinti Maris Liberi, in cui Grozio rispondeva agli attacchi di William Welwod, che troviamo un’esposizione più dettagliata e qualche aneddoto sui pirati. Ora, per Grozio la pirateria è un crimine diretto contro lo ius gentium (e dunque punibile da chiunque). Qualche riga dopo, Grozio racconta, parlando della possibilità giuridica di separare il mare dalle sue rive, che quando Gaio Giulio Cesare – essendo ancora un semplice cittadino privato – catturava e mandava a giudizio i pirati, il proconsole decise che non poteva punirli. Cesare tornò dunque in mare con i pirati catturati e lì furono crocifissi. Grozio ci dice che questo è possibile solo se, come risulta evidente all’interno di questa concezione topologica del diritto – sulla quale Yan Thomas insiste – il mare non era entrato nella giurisdizione romana; anzi, la disobbedienza a un ordine superiore da parte di Cesare sarebbe stato atto di lesa maestà contro il suo proconsole. Sebbene il punto di questa nota non sia analizzare nel dettaglio la logica giuridica di Grozio, da lui possiamo comunque apprendere alcune lezioni. E forse, come Grozio, dovremmo oggi difendere lo spazio pubblico con lo stesso rigore del grande giurista ed erudito, in quest’epoca di assolutismi statali e di corruzioni colluse. Dovremmo difendere la libertà dei diversi spazi cognitivi contro ogni moralismo benintenzionato, contro ogni censura “benigna” e rifiutare una tutela che è indegna di uomini liberi. Ma in un mondo in cui il pubblico è stato ridotto al sacro – nella religione di sacerdoti e burocrati, nel culto di esperti e potenti – e in cui, poco a poco, il diritto e le sue istituzioni confinano con la propria parodia, cosa ci resta da fare? Forse, attraverso i nostri umili mestieri, è giunto il momento di tracciare una nuova geografia cognitiva; come agrimensori che hanno dimenticato il proprio compito e che, proprio per questo, possono restituire il diritto (e i suoi amanuensi) al posto che gli spetta: riducendo, come ci ha insegnato Bucefalo, il diritto al suo studio.
Pirateria ultima e suprema | Una vera poetica corsara è sempre allusiva. Solo un lettore veramente attento, trasformandosi in silenzioso complice, può riconoscere che una profanazione è stata compiuta: non solo questo, ma conosce le ombre del bene appropriato e l’odore del santuario violato.
Copyright/Copyleft | “Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram: et praesit piscibus maris, et volatilibus caeli, et bestiis, universaeque terrae, omnique reptili, quod movetur in terra”.
English abstract
This note introduces the Italian edition of Yan Thomas’s Il valore delle cose [2002] (Macerata 2015, 2022) and interprets his ideas. According to the author, Thomas sees law as an artificial system centered on things, built on procedural distinctions rather than fixed definitions. He is portrayed as critical of modern law’s focus on the individual and rejecting dogmatic reconstructions of Roman law. His work, read through Giorgio Pasquali’s philological lens, explores how legal fictions shape institutions. Additionally, the note includes an appendix with reflections from seminars on Copyleft & Internauti pirati, playfully inspired by Thomas’s ideas and their broader humanistic implications.
keywords | Piracy; Roman Institutions; Yan Thomas; Giorgio Pasquali; Michele Spanò.
la revisione di questo contributo è stata affidata al comitato editoriale e all’international advisory board della rivista
Per citare questo articolo / To cite this article: Bernardo Prieto, Una lettura di: “Il valore delle cose” di Yan Thomas. In Appendice: Glosse e note a partire dalla lettura di Thomas, a margine dei seminari su Copyleft & Internauti pirati, “La Rivista di Engramma” n. 222, marzo 2025, pp. 117-127 | PDF