Storia e narrazione: retoriche della verità e strategie della finzione
Note a margine di due saggi di Carlo Ginzburg
Fabrizio Lollini, Giuseppe Cengiarotti, Daniele Pisani
§ Fabrizio Lollini, Note a margine di: Carlo Ginzburg, Indagini su Piero. Il Battesimo, il ciclo di Arezzo, la Flagellazione di Urbino, Einaudi, Torino [1981, 1982, 1994] 2001
§ Giuseppe Cengiarotti, Note a margine di: Carlo Ginzburg, Il filo e le tracce. Vero falso finto, Feltrinelli, Milano 2006
§ Daniele Pisani, Note a margine di: Carlo Ginzburg, Il filo e le tracce. Vero falso finto, Feltrinelli, Milano 2006
Fabrizio Lollini, Note a margine di: Carlo Ginzburg, Indagini su Piero. Il Battesimo, il ciclo di Arezzo, la Flagellazione di Urbino, Torino, Einaudi [1981, 1982, 1994] 2001
Capita ormai raramente, nell'editoria italiana, che un libro venga riproposto al mercato più volte, e che ogni apparizione, arricchita da nuove postille e precisazioni, susciti l'interesse degli specialisti della materia; è questo il caso del volume di Carlo Ginzburg Indagini su Piero. Il Battesimo. Il ciclo di Arezzo. La Flagellazione di Urbino, pubblicato dapprima nell'ormai lontano 1981, poi – con una diversa Prefazione, di grande rilevanza sia metodologica che di merito – nel 1982, in seguito ristampato senza modifiche e, infine, riedito nel 1994 con l'aggiunta di quattro appendici [1]. Un libro che, all'epoca, segnò l'inizio di accese e non sempre serene discussioni, di cui non è qui il caso di dare conto per esteso, sia perché vantano ormai un'amplissima e qualificata bibliografia, sia perché chi scrive ha già avuto modo di commentarle in altre sedi.
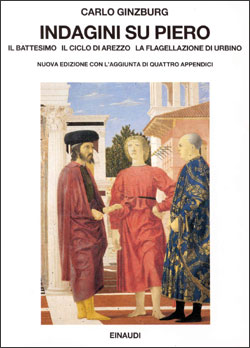 |
Solo per riassumere in due parole: le ipotesi principali dello studioso – principali si intende per il contesto bessarioneo – erano che nel prelato greco si potesse identificare da una parte il consulente iconografico (quasi il suggeritore) del ciclo della Leggenda della Vera Croce di Arezzo, e dall'altra uno dei personaggi raffigurati in primo piano nella Flagellazione di Urbino, fatto quest'ultimo che porrebbe il cardinale al centro di una fitta trama di rapporti politico-istituzionali gravitanti intorno alla corte feltresca. La più ricorrente accusa rivolta a Ginzburg ha invece insistito sulla sua inclinazione a considerare quasi esclusivamente i dati extrastilistici, non artistici, relativi alle opere prese in esame [2].
 |
In questa sede conviene forse subito analizzare, a mo' di recensione, come si presenta l'ultima edizione delle Indagini, tappa probabilmente definitiva (ma nulla è mai certo) di questo affascinante work in progress. Il volume si apre con due prefazioni: quella originale del 1981, ripresa senza modifiche, e una inedita in cui l'autore dà conto della storia editoriale delle sue ricerche e motiva l'inserimento delle nuove sezioni del libro; seguono, nel corpo del lavoro, i capitoli già noti dedicati alle opere sopra citate; in fine, quattro appendici. La I, già apparsa a stampa qualche anno fa, prende posizione sulla possibile acquisizione come ante quem per il ciclo di Arezzo di una predella di Giovanni di Francesco eseguita prima del 1459, anno della scomparsa del pittore.
 |
 |
Ginzburg accetta le per altro palesi somiglianze tra questa tavola e i dipinti murali di Piero, ma dimostra che l'autore della prima non è quel Giovanni di Francesco del Cervelliera di cui le fonti documentarie ci testimoniano la data di morte [3]. Nella II appendice, che in pratica sostituisce nel merito la prefazione scritta per la terza edizione del 1982, lo storico riconsidera alcuni punti della sua complessa esegesi della Flagellazione urbinate, giungendo a mettere in dubbio alcune delle sue stesse vecchie affermazioni [4]. Le ultime due appendici, III e IV (già edita), si indirizzano verso questioni, per così dire, collaterali ai temi qui trattati; si occupano rispettivamente della riscoperta dell'opera pierfrancescana nei primi decenni di questo secolo, tra Berenson, Gertrude Stein e Longhi, e della metodologia longhiana sulla cronologia [5]. Completa il volume una ricca serie di immagini fuori testo a colori e in bianco e nero, sia qualitativamente che quantitativamente più rilevante rispetto ai corredi iconografici inclusi nelle versioni del 1981 e del 1982.
Trascurando di analizzare o criticare in dettaglio le ipotesi già formulate nelle precedenti edizioni (che si considerano a questo punto ormai acquisite da parte del lettore), e i punti qui non pertinenti, vorrei parlare brevemente in questa sede dei nuovi passaggi in cui è chiamato in causa Bessarione, e di quanto le aggiunte e i cambiamenti apportati possano, nel caso, modificare il supposto ruolo del prelato greco nelle questioni pierfrancescane; per concludere con alcune osservazioni di metodo.
Nella sua inedita seconda appendice, dunque, Ginzburg inizia col riproporre ancora una volta la propria esegesi della tavola urbinate, e accentra il suo esame sulla fascia rossa che, presenza quasi inavvertibile, pende dalla spalla destra dal personaggio in abito giallo e blu.
 |
Questo indumento era già nelle versioni precedenti delle Indagini elemento decisivo per l'interpretazione della scena: lo studioso definiva l'avvenimento narrato in primo piano come la consegna delle insegne di principe della Chiesa – da parte di Giovanni Bacci – a Bessarione, a Costantinopoli, nel breve periodo in cui il prelato greco era ritornato in oriente alla conclusione definitiva del concilio per l'unione delle chiese; questo fatto, in qualche modo punto più alto della carriera pubblica di Bacci, sarebbe stato da lui scelto come tema circa diciannove anni più tardi, al momento dell'esecuzione del quadro, una sorta di incitamento – assieme suo e del cardinale – rivolto a Federico da Montefeltro per invitarlo a impegnarsi con gli altri principi italiani nella riconquista di quella Costantinopoli, presa dai Turchi, le cui sofferenze troverebbero adeguato simbolo nella flagellazione di Cristo; in un complesso reticolo di allusioni teologiche e dinastiche, pubbliche e private, in cui gran peso avrebbe il ricordo, nella figura del giovane al centro, di un figlio di Federico precocemente scomparso, Buonconte.
Una fascia rossa. E, come avviene nella letteratura poliziesca (non a caso: a un lessico – e a metodologie – da crime novel Ginzburg ricorre spesso, in questo e in altri suoi studi), ecco spuntare in un secondo dipinto di Piero lo stesso 'indizio': il medesimo indumento ricorre, in modo ancor più difficilmente avvertibile, nel cosiddetto San Gerolamo e Gerolamo Amadi delle Gallerie dell'Accademia a Venezia.
 |
La mancanza di insegne cardinalizie nel santo, spesso evidenziata dagli studiosi, viene allora a essere così interpretata da Ginzburg: dal momento che nel corso del '300 e del '400 ci si incominciava a interrogare sulla verosimiglianza e sulla liceità delle rappresentazioni di Gerolamo come cardinale (storicamente, in vero, del tutto infondate), e dal momento che sappiamo che, almeno nel XVI secolo, la famiglia Amadi propalava di vantare nella sua storia tre porporati mai esistiti, Piero avrebbe scelto, di concerto con il committente, “di ritrarlo nell'atto di consegnare a san Girolamo la fascia”, accoppiando così “le ambizioni di ascesa sociale di una famiglia di mercanti” e “la critica umanistica di una leggenda agiografica medioevale”. Ecco allora che, proprio come Amadi a Venezia offre la carica cardinalizia a Gerolamo, anche Bacci fa lo stesso a Urbino con Bessarione, dove Piero “trasferì a un personaggio secondario un particolare [...] che connotava il personaggio principale” (e per di più, anche uno degli angeli del Battesimo di Londra ha come fascia la tunica di Cristo); in questo modo si spiegherebbe quello che chi scrive ha voluto definire hapax, e non attraverso spunti esterni, bensì attraverso ricorrenze intrinseche allo svolgimento formale del pittore.
 |
Con grande onestà intellettuale, però, l'ultima parte di questa seconda appendice è diversa da come ci si poteva aspettare – una sorta di controfinale, tanto per tornare al poliziesco: Ginzburg avverte il lettore di aver trovato un’identica fascia rossa anche in contesti del tutto estranei a Piero e alle questioni relative al cardinalato. Conclusione: “Il mio tentativo di dimostrare che Giovanni Bacci, "nunzio a Cesare", era l'individuo che si recò a Costantinopoli a informare Bessarione della sua nomina a cardinale di Santa Romana Chiesa, era fallito. È chiaro che questo fallimento non coinvolge tutto ciò che ho scritto sulla Flagellazione. Le mie argomentazioni sulla data dalla tavola, su Giovanni Bacci in quanto possibile committente, su Bessarione in quanto possibile ispiratore e così via, possono essere sbagliate, ma in ogni caso sono del tutto indipendenti dalla fascia cardinalizia”.
Due osservazioni. Anche senza ritrovare una prova visiva, credo che l'inattendibilità dell'assunto potesse essere evidente. Mi pare impossibile che un mercante, quale appunto era Amadi, si autoarrogasse l'onore di essere ritratto come colui che aveva operato un'azione tanto rilevante, per quanto storicamente mai verificatasi: per lo meno, non credo esistano in pittura paralleli pertinenti; e perchè poi sempre affidare a dettagli quasi impercettibili, a capziose metonimie visive – stando alle ricerche di Ginzburg e ad altre recenti interpretazioni – non significati collaterali alla comprensione del dipinto, fatto già di per sé poco spiegabile, ma il vero 'messaggio' dell'opera, soprattutto in un quadro come quello di Venezia, evidentemente privato, e perciò non sottoponibile a censure? Ancora: per quanto Bessarione fosse un personaggio importante (e, fatto non evidenziato da Ginzburg, visivamente paragonabile, e paragonato da certe fonti, al santo), i contesti dei due dipinti sono distantissimi, e storicamente e come ambientazione.
Più in generale, e senza voler essere polemico, mi pare che lo studioso annetta troppo poca importanza a questa mancata dimostrazione (o, meglio, a questa smentita). L'interpretazione della fascia rossa nella Flagellazione non è solo uno dei tanti elementi su cui si fondava la sua lettura. Se scorriamo le pagine dell'introduzione all'edizione del 1982, quella soppressa nella versione più recente, leggiamo che ben cinque erano i problemi principali – e anzi imprescindibili – dell'esegesi ginzburghiana nella sua formulazione originaria, quella cioè che voleva collocare sia l'esecuzione del dipinto sia lo svolgimento del fatto narrato verso il 1459: l'età troppo giovanile mostrata nella tavola dal presunto Bessarione; la mancanza di contrassegni cardinalizi; l'evocazione nelle vesti di Pilato dell'imperatore Giovanni VIII, all'epoca ormai defunto; l'abito dello pseudo-Bacci, troppo lussuoso per quello che all'epoca era un privato cittadino; l'impossibilità di riconoscere Roma, unico luogo compatibile con la proposta dello studioso, nello sfondo del dipinto. Lasciando la realizzazione del dipinto allo scadere degli anni '50, ma sfasando di quasi venti anni all'indietro il racconto che vi viene narrato, ecco che tutto si scioglieva: e appunto la fascia rossa era il perno su cui far ruotare questa discrasia temporale, visto che dava la possibilità di fissare un momento fondamentale di tanti anni prima cui poter legare il supposto soggetto, e cioè la mai dimostrata (né tanto meno documentata) missione costantinopolitana del Bacci. Se si toglie questo passaggio, certo non tutto va perduto; ma bisogna rimotivare, almeno, gli stessi cinque punti che con questo brillante escamotage erano stati temporaneamente rimossi [6].
In questo caso, come si vede, il problema metodologico non è tanto quello di privilegiare la serie dei dati extrastilistici rispetto a quella dei dati stilistici, come volevano molte delle critiche rivolte a Ginzburg nelle occasioni precedenti; d'altra parte, è probabile che ormai nessuno si possa più scandalizzare se la storia dell'arte diviene compartecipe di tecniche di indagine derivate da altre discipline (cosa che, fino a qualche tempo fa, veniva forse vista come un attentato all'autonomia della materia, con fatica emancipatasi dalla sua condizione ancillare di ausiliaria della storia) [7].
Mi pare invece che non si insista abbastanza su quella che può essere definita “iperinterpretazione”: intendendo con questo termine la tendenza nella ricerca storico-artistica a sovraccaricare di significati, e quindi di letture, i dati che si riescono a recuperare nel corso dell'indagine – siano essi, per riprendere quanto detto sopra, stilistici o extrastilistici.
Tanto per rimanere a Piero: è un'iperinterpretazione extra-stilistica quella che annette così clamorosa importanza all'uso da parte del pittore di elementi lessicali quali, nella Flagellazione, l'idolo in cima alla colonna, di cui si trovano esempi del tutto simili in decine di altri dipinti dal XIV e del XV secolo, o la decorazione cardata del vestito del personaggio calvo, magari con conseguente identificazione in Ottaviano Ubaldini della Carda; ma anche quando ci si ostina a voler far coincidere tipologie fisionomiche evidentemente ricorrenti nell'opera dell’artista, esemplificazioni di carattere o se si vuole icone di un'umanità tacita e impassibile, con ritratti di personaggi più o meno noti – col bel risultato di passare da Bessarione a Ubaldini, da Ludovico Gonzaga a Guidantonio da Montefeltro (e, perchè no, Federico, o Oddantonio, o Buonconte) – o con entità di impressionante vaghezza mai testimoniate in pittura – dal “testimone celeste” al “giovane sensitivo”, per continuare con l'“atleta della Virtù” e la “personificazione del laico”, e concludere con l'“ideale raffigurazione di Guidantonio da Montefeltro neonato per come sarebbe divenuto una volta cresciuto”.
 |
 |
Prendiamo poi un caso clamoroso e recente: c'è chi ha contestato l'interpretazione antiebraica della tavola urbinate che avevo avanzato qualche anno fa sostenendo in modo lapidario che ebrei biondi non se ne sono mai visti; poi si è collegata l'immagine alla dotta esegesi di una serie di fonti bizantine (la Visio Danielis, gli Oracoli di Leone il Saggio, e altro ancora) per identificare nel personaggio l’emblema della “contaminazione tra la leggenda del re liberatore e le profezie sulle genti bionde”, con una valenza soteriologica nei confronti di Costantinopoli; in fine, senza citare peraltro la Flagellazione, si è scrutinata diffusamente la valenza della capigliatura bionda come segno distintivo di nobiltà, di derivazione franco-germanica, nella pittura e nella miniatura italiana del '400 [8].
Esistono però anche iperinterpretazioni stilistiche: quando per esempio, sino a qualche anno fa, si leggeva come pierfrancescano tutto ciò che di nuovo, in senso prospettico-spaziale di stampo centroitaliano, si riscontrava nella pittura in Emilia e in Veneto di metà '400, trascurando le ricadute locali della presenza di un Donatello, un Andrea del Castagno, o un Paolo Uccello; o, per correre attraverso i secoli assieme a Piero, di questo artista veniva data in determinati periodi storici (e di gusto) un'immagine di cubista ante litteram, o di antesignano di Cézanne.
Ho usato in altra sede, applicato alla Flagellazione, il termine di hapax, derivato dalla filologia letteraria. Mi pare, ma è cosa anche troppo banale da evidenziare, che a evitare quella che si è voluta chiamare iperinterpretazione, uno dei possibili elementi di controllo metodologico nella ricerca storico-artistica (soprattutto per quanto concerne l'aspetto iconografico, ma non solo) possa e debba essere il ricorso al concetto di “tradizione” e di “variante significativa” sulla base appunto della pratica filologica. In questo caso, per esempio, qualche singolo elemento lessicale della tavola urbinate che è stato fin troppo arricchito di complicate esegesi (la colonna con l'idolo pagano già citato, la doppia fonte luminosa, la scala nel fondo dello spazio coperto) potrebbe, credo, essere riassorbito tra le difformità morfologiche, esempio di varietas solo visiva e non portatrice di nuovi soggetti o allegorie, dopo un confronto il più possibile esaustivo con il corpus dei dipinti che mostrano il medesimo momento della passione di Cristo.
Ritengo prudente, insomma, essere il più possibile economici – lo stesso Ginzburg, varie volte, avverte d'altra parte che più passaggi intermedi vengono postulati, più ci allontana dalla probabilità di essere nel giusto; a parità di impossibilità di dimostrazione oggettiva, deve insomma essere privilegiata la tradizione visiva specifica (sia dal punto di vista iconografico che stilistico) e non, tanto per riprendere quanto detto sopra, la “serie extrastilistica” degli indizi storici. Tradizione visiva che ha in comune con quella scritta, oltre al concetto di hapax, a quello di “variante” ed altri ancora, pure quello di lectio facilior e difficilior.
Per passare da una pars destruens a una construens: allora, riprendiamo in due righe la questione – anche se dopo il diluvio bibliografico sull'argomento questo essere sbrigativi può forse sembrare provocatorio. Esiste una corrente decisamente minoritaria, alla quale appartiene anche chi scrive, che annette ai tre personaggi in primo piano nella Flagellazione di Piero una caratterizzazione giudaica, e che di conseguenza legge l'opera in chiave antiebraica. Il problema è: esiste una tradizione in questo senso? Scorrendo le tavole del libro di Ginzburg, o altre riproduzioni, vediamo che se nelle flagellazioni c'è un gruppo a latere, questo è sempre composto da ebrei, e sempre escluso dallo spazio in cui la scena viene fisicamente compiuta (e per questo secondo dato la motivazione viene da una fonte che non è difficile postulare come nota: i Vangeli). Non si dà altra possibilità: lì dove stanno i nostri tre uomini ci sta – verrebbe da dire ci deve stare – chi è responsabile dell'avvenimento.
Qualche volta l'identificazione è più facile, qualche volta è più difficile; in una versione questa lettura è fin troppo palese ed evidenziata, e sto parlando della Flagellazione del Prado attribuita al Fernandez, un dipinto che tutti ormai fanno derivare da quello di Urbino dal punto di vista compositivo e stilistico: e se facendo un ulteriore sforzo pensassimo lo stesso anche dal punto di vista tematico? Ginzburg dice che è forse “possibile intravedere nella tavoletta di Madrid una volontà di normalizzazione iconografica della Flagellazione di Piero”, ed elenca i dettagli lessicali che distaccano tra loro le due opere; ma una lectio facilior scritta deriva da un fraintendimento del testo: possibile che un pittore che con ogni verosimiglianza vide il quadro di Piero pochi anni dopo che fu dipinto non ne arrivi a capire il significato?
 |
Qui non si tratta della ripresa di uno schema dato in un contesto differente (una donna con un neonato in braccio da una Natività di Cristo ripresa come base compositiva per una Natività di Maria, tanto per dire), bensì del riuso del dettaglio – per quanto importante ed esibito – di un dipinto in un altro dipinto che ne condivide il soggetto. Certo, Piero è più difficile, è “non eloquente”. Ma chi scrutinasse i vestiti, le capigliature, le calzature e i piedi nudi o lo stare seduto su una sedia che caratterizzano il San Giuseppe e i pastori dell'Adorazione del Bambino di Londra, chi insomma ne valutasse solo le “varianti morfologiche” rispetto ai loro corrispondenti in tutte le altre Adorazioni, riuscirebbe a identificarli forse per quelli che sono [9]?
 |
Corsi e ricorsi della storia: il testo recensito in queste righe ha avuto una lunga vicenda editoriale, e più edizioni rimodulate. Ma anche la presente recensione – nel suo piccolo – vanta un iter su lunga distanza: scritta esattamente come viene proposta ora, risale al 1996; la realizzai poco dopo il convegno bessarioneo di Venezia, i cui atti, ai quali era destinata, non sono usciti (ma, anche qui, non si sa mai). La sua inclusione come uno dei pannelli di un trittico, oggi, vale forse poco rispetto alla sua ‘attualità’ intrinseca, ma a parere dei curatori di questo insieme serve soprattutto, bontà loro, dal punto di vista metodologico. Non sfugge a nessuno, però, che l’argomento trattato riacquisisce valore di cronaca rispetto al rifiorire di studi sulla Flagellazione di Piero della Francesca, soprattutto in riferimento alla pubblicazione del libro di Silvia Ronchey, L’enigma di Piero, recensito in questo stesso numero di Engramma. Credo però che alcune annotazioni siano valide, come potrebbe dire qualcuno, ‘a prescindere’. Ne elenco alcune, e altre ne aggiungo in breve. Dal punto di vista del metodo il problema è duplice; come scrivevo, una serie di dati visivi che fanno parte dei bagagli visivi dei pittori vengono iperinterpretati come specifiche volontà singole: ciò avviene nella Flagellazione sia in ambito iconografico (l’idolo sulla colonna, il cappello da Paleologo, la scala) sia in ambito stilistico (perchè una doppia fonte di luce? perchè la regolarità albertiana del muro di fondo?), per un motivo, e cioè che i protagonisti di queste indagini sono (quasi) sempre non-storici dell’arte, che tendono a sopravvalutare come eccezioni dati in realtà abbastanza ben spiegabili altrimenti dal punto di vista della loro repertorialità; inoltre, ogni disciplina tende a inglobare le altre e considera poco lo specifico altrui. Esiste poi il problema dell’economicità interpretativa: Michael Baxandall, in Forme dell’intenzione, liquida tutte le interpretazioni iconologiche del Battesimo di Piero, dandone una lettura che non ha bisogno di riferimenti esterni all’artista e al quadro; e per esempio dice dei sacerdoti in secondo piano che le loro “vesti bizantineggianti fanno parte dell’usuale coloritura orientale di Piero”. Inoltre, mi pare sia da precisare che il Rinascimento, inteso come riappropriazione di uno spettro ampio di polisemia interpretativa basata sul passato, come detentore di valori dall’allegoria facile, inizia dopo la caduta di Costantinopoli, non con la triade manualistica Brunelleschi-Masaccio-Donatello, e Piero negli anni 1455-60 circa non ci rientra facilmente (e peraltro, prima del Byzantine trend, la cronologia della Flagellazione era spesso posta subito dopo il Battesimo a inizio anni ’50, se non prima, cosa che a priori escluderebbe tante interpretazioni); ai tempi del nostro artista (almeno ai suoi tempi iniziali) quello che deve essere inteso deve essere visto, colto con facilità, letto, secondo una mentalità ancora tardomedioevale, non decriptato da pochi eletti come avverrà venti anni dopo (questo almeno è il mio sommesso parere, anche rispetto alla diffusione e alla diffondibilità di testi chiamati in causa nelle esegesi del dipinto). Bernhard Berenson, quando era ormai avanti negli anni, scrisse un librettino che si intitolava Piero della Francesca o dell’arte non-eloquente (un vero gioiello un po’ snob), in cui dice sostanzialmente, forzando un po' le sue parole, che a Piero non importava nulla né delle iconografie né del pathos né dell’espressività; le sue sono forme e basta, che non vogliono comunicare proprio niente, che hanno un racconto solo perchè lavorava nel XV secolo e un minimo di soggetto era obbligatorio: “Volete una Crocefissione? Bene, ve la faccio, ma non chiedetemi che sia pure commovente o che abbia specificità iconografiche”. Ora, la sua posizione è certo eccessiva: ma che Piero si intendesse principalmente di numeri e di solidi geometrici lo dicono le fonti e le sue opere, e nessuno in epoca coeva a lui o poco dopo ha mai speso una singola parola riguardo alle vicende storiche che ora vanno per la maggiore, e che se prendiamo per buone le letture degli ultimi trent’anni dovrebbero includere molta della sua produzione. Secondo me, il discorso è semplice; se uno ‘sta zitto’, cioè non dichiara, è ‘non-eloquente’, ‘non-espressivo’, insomma, è più facile mettergli in bocca delle parole. In ultimo, le interpretazioni della Flagellazione tendono sempre più a essere, in certo qual modo, assimilabili a dei ready made (e lo dico senza ironia, con tanto rispetto, e nel senso migliore e più filologico del termine): reimpiegano in modo intelligente e colto singole parti di strutture storiche e metodologiche che in precedenza avevano avuto una storia all’interno di entità più ampie del tutto difformi, da cui vengono staccate per essere assemblate con altre analoghe e creare qualcosa di autonomo: un progetto in qualche caso più artistico che esegetico.
Giuseppe Cengiarotti, Note a margine di: Carlo Ginzburg, Il filo e le tracce. Vero falso finto, Feltrinelli, Milano 2006
 |
Per l’editoria italiana questo recente periodo si sta rivelando ricco di pubblicazioni storiografiche importanti in quanto contribuiscono finalmente ad una riflessione approfondita sullo statuto della disciplina, rivelando una necessità da tempo presente negli studi storici, ma forse mai come ora apertamente affrontata. In contemporanea con la presente raccolta di saggi di Carlo Ginzburg occorre infatti menzionare alcune pubblicazioni di rilievo, non solo l’impegnativa raccolta di Giuseppe Ricuperati, Apologia di un mestiere difficile. Problemi, insegnamenti e responsabilità della storia , ma anche l’edizione italiana di alcune delle opere di Michel de Certeau e in particolare Storia e psicoanalisi. Tra scienza e finzione (in cui si ritrovano molti dei temi oggetto di interesse per Ginzburg, dal rapporto tra storia e fonte letteraria, a quello tra storia e finzione e tra storia e struttura) o la riedizione di Ioan Petru Coulianu, Eros e magia nel Rinascimento da tempo scomparso dalla circolazione.
La scrittura stessa di Carlo Ginzburg tradisce l’urgenza di confrontarsi con taluni nodi relativi al rapporto tra realtà e finzione, che per la verità già erano emersi in un precedente importante volume, Rapporti di forza. Storia, retorica, prova. Ginzburg, che insiste nel dichiarare il proprio debito nei confronti delle concezioni di Arnaldo Momigliano, ha scelto nella presente raccolta la forma del saggio per discutere nel vivo, sul piano della ricerca sul campo, in primo luogo l’ardua questione della prova – nelle diverse accezioni di proof ed evidence – nel mestiere di storico. Il bersaglio è il linguistic turn che fa capo a Metahistory di Hayden White (sia sulla differenza tra i due termini sia su questo punto specifico rimando a Rapporti di forza). Il volume si compone di quindici saggi già precedentemente pubblicati più l’importante appendice intitolata Prove e possibilità, nata come postfazione al volume di Natalie Zemon Davis, Il ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia identità nella Francia del Cinquecento.
Ginzburg riprende anche le posizioni di Lawrence Stone in tema di narratives, “contro la tendenza dello scetticismo postmoderno a sfumare il confine tra narrazioni di finzione e narrazioni storiche” per sviluppare in Descrizione e citazione una ricerca alla luce dell’asserzione che “se l’enargeia era lo scopo dell’ekphrasis, la verità era l’effetto dell’enargeia” per cui “possiamo immaginare una sequenza di questo genere: narrazione storica-descrizione-vividezza-verità”. Tutto ciò verrà ricostruito in vari luoghi del volume, per esempio nelle riletture cinquecentesche di Sesto Empirico da parte del Robortello o nel Dialogo della Istoria di Sperone Speroni, se “allorché paragonava le orazioni degli storici ai dipinti che adornano i palazzi” avrà pensato agli affreschi della villa palladiana di Maser dove “di fronte alle immagini del Veronese, che ingannano per un attimo l’occhio dello spettatore con la loro splendida, illusoria evidenza, Speroni potrebbe aver evocato l’enargeia, la vividezza della retorica antica”. Questi riferimenti puntano ad antidatare al Cinquecento la nascita della storiografia moderna rispetto alla collocazione fissata da Momigliano in Storia antica e antiquaria (1950).
Il dibattito non è mai astrattamente metodologico o teorico, ma sempre articolato in preziose proposizioni di questioni storiche (manca lo spazio per inventariarle qui tutte), come nel caso di Montaigne, i cannibali e le grotte, in cui in modo penetrante Ginzburg (che sembra fare il controcanto al saggio su Les Cannibals di de Certeau, pubblicato in Le lieu de l’autre. Histoire religieuse et mystique) ci accompagna, con sotto braccio le Notti attiche di Aulo Gellio, a cogliere il nuovo “ordine rustico” in Giulio Romano a Palazzo Te, per ritrovarlo nel Serlio e nello stile di Montaigne. Certa è l’appartenenza di Montaigne alla nuova sensibilità antiquaria, per cui l’autore giunge a concludere che “nel saggio sui cannibali Montaigne portò alla luce le implicazioni morali e intellettuali della Wunderkammer.” In una scrittura come sempre brillante, Carlo Ginzburg si è dunque soffermato su taluni tratti di style rustique ravvisabili nell’autore degli Essais, evocando stilemi manieristici e riprendendo le citazioni galileiane su Ariosto, Tasso e le Wunderkammern del celebre saggio di Panosfky. Infatti, “voglio che mi si veda qui nel mio modo d’essere semplice, naturale e consueto, senza affettazione né artificio: perché è me stesso che dipingo”. Ginzburg ci ricorda che in un altro passo Montaigne paragona i Saggi a grottesche, assai di moda in seguito alla scoperta tardo quattrocentesca degli affreschi che decoravano la Domus Aurea, “che sono pitture fantastiche le quali non hanno altro merito che la loro varietà e stranezza. Che cosa sono anche questi, in verità, se non grottesche e corpi mostruosi, messi insieme come membra diverse, senza una figura determinata, senz’altro ordine né legame né proporzione se non casuale?”. A testimoniarne la diffusione Ginzburg ricorda La métamorphose d’Ovide figurée, un’edizione lionese del 1557, in cui l’età dell’oro viene raffigurata “Sans loy, force, ou contrainte/ On meintenoit la foy, le droit, l’honneur”.
 |
Ancora più interessante un’indagine successiva in cui, prendendo il Journal de voyage en Italie, viene discusso il giudizio dello scrittore su Vitruvio: “La frase ironica di Montaigne sul gergo degli architetti moderni non implicava affatto una mancanza d’interesse per l’architettura”; e riprende i giudizi entusiasti sulla Villa Medici a Pratolino, vicino a Firenze, per constatare “una convergenza ispirata da un gusto comune” condensato nel Serlio che si scusa per essersi allontanato (ma “non troppo”) da Vitruvio: “L’entusiasmo di Montaigne per Pratolino, Bagnaia e Caprarola, registrato nel Journal de voyage en Italie, faceva parte di un gusto che potrebbe aiutare a capire meglio la struttura e lo stile dei Saggi. È una possibilità che va indagata”.
Ma il rapporto tra storia e finzione viene individuato anche attraverso Paolo Giovio oppure seguendo le vicende dell’Adversus mathematicos di Sesto Empirico ripreso in Francesco Robortello alla metà del Cinquecento. Se Sesto Empirico “obiettò che la storia non ha metodo: non è una techne (in latino, ars) ma un semplice accumulo di fatti, irrilevanti, incerti o favolosi”, lo studioso udinese “cercò di dimostrare, contro di lui, l’esistenza di una ars historica” e “con occhio sicuro sceglieva nell’opera di Tucidide una pagina (VI, 54-55) che faceva al caso suo: un ragionamento che trasformava un’epigrafe frammentaria in una prova”. Tra i tanti esempi troviamo appunto gli Elogia virorum bellica virtute illustrium e gli Elogia virorum litteris illustrium di Paolo Giovio (su cui Ginzburg ricorda il bel saggio di Chabod). Tratteggiando i caratteri di un Montaigne ‘antiquario’ – ma solo dopo averci detto di una sua “vera passione per la poesia” – lo scrittore francese ci viene mostrato in occasione di una sua visita alla Biblioteca Vaticana dove data un manoscritto di Virgilio (il Vergilius Romanus Vat. Lat. 3867) per asserire che i suoi “erano i temi affrontati dagli antiquari, e sistematicamente ignorati dagli storici”.
 |
Lo stesso Ginzburg ci ricorda anche, sempre sulla scorta del Journal de voyage en Italie, che “nei suoi scritti storici Giovio guardò con molta attenzione all’impero ottomano”. Lo ricordo perché in un altro contesto (Gli europei scoprono (o riscoprono) gli sciamani) produce un impensato accostamento 'orientale' tra il Niebuhr e Jan Potocki, l’autore del Manoscritto trovato a Saragozza, in relazione ad un passo del quarto libro di Erodoto sulle usanze delle popolazioni nomadi dell’Asia centrale, cosa che consente di toccare un'altra dimensione che caratterizza gli ultimi interessi di Ginzburg, ossia il tema del rapporto fecondo tra il romanziere e lo storico, la fonte letteraria e quella documentaria e che trova anche in questo volume altre importanti elaborazioni, come ne L’aspra verità. Una sfida di Stendhal agli storici. Ritengo opportuno accostare la riflessione di Ginzburg a quella parallela di Francesco Orlando, che ne Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura. Rovine, reliquie, rarità, luoghi inabitati e tesori nascosti aveva sostenuto la rilevanza della fonte letteraria per la storia e che ha condiviso con Ginzburg la presenza ne La crisi della ragione. Nuovi modelli nel rapporto tra sapere e attività umane (volume in cui era stato inserito Spie. Radici di un paradigma indiziario).
In un altro saggio di questa raccolta, Sulle orme di Israël Bertuccio, l’autore si richiama anche a Eric Hobsbawm, laddove l’illustre storico inglese individua nel corso degli anni Settanta una svolta nel panorama degli studi storici destinato a invertire la modernizzazione della storiografia in senso storico sociale, per giungere ad affrontare la questione del rapporto storia-struttura e pervenire al suo giudizio critico sulla “microstoria”, che lo storico inglese vede prefigurarsi già ne Il formaggio e i vermi (1975). Se è comune la battaglia dei due storici contro lo scetticismo, diverso è il loro giudizio su quest’ultima. Facendolo risalire alla sua lettura dei Rois Thaumaturges di Marc Bloch, Ginzburg dichiara che la questione del rapporto tra storia e struttura gli si è posto a lungo “come un dilemma” (Streghe e sciamani) e che solo dopo aver scritto Storia notturna. Una decifrazione del sabba diventa consapevole del fatto che “storia e morfologia non sono giustapposte […] ma intrecciate: due voci che si alternano, discutono, infine cercano un accordo”.
Ebbene, è alla luce di questa prospettiva che si può forse sviluppare un confronto produttivo in merito a quanto afferma Ginzburg a proposito del significato della fonte storica:
“Le fonti non sono né finestre spalancate, come credono i positivisti, né muri che ostruiscono lo sguardo, come credono gli scettici: semmai, potremmo paragonarle a vetri deformanti. L'analisi della distorsione specifica di ogni fonte implica già un elemento costruttivo. Ma la costruzione, come cerco di mostrare nelle pagine che seguono, non è incompatibile con la prova; la proiezione del desiderio, senza cui non si dà ricerca, non è incompatibile con le smentite inflitte dal principio di realtà. La conoscenza (anche la conoscenza storica) è possibile”.
Così scriveva lo stesso Ginzburg, in Rapporti di forza. Storia, retorica, prova:
"Molti anni fa Lucien Febvre osservò che le fonti storiche non parlano da sole, ma soltanto se interrogate in maniera appropriata. Oggi questo ci appare ovvio. Meno ovvia è l'osservazione che le domande dello storico sono poste sempre, direttamente o indirettamente, in forme (sottolineo il plurale) narrative. Queste narrazioni provvisorie delimitano un ambito di possibilità che spesso vengono modificate, o addirittura scartate, nel corso del processo di ricerca. Possiamo paragonare queste narrazioni a istanze mediatrici tra domande e fonti, che influiscono profondamente (anche se non in maniera esclusiva) sui modi in cui i dati storici vengono raccolti, eliminati, interpretati - e infine, naturalmente, narrati".
Le pubblicazioni citate all’inizio della presente riflessione indicano che è forse finalmente giunto il momento di riprendere una discussione su queste questioni cruciali.
Daniele Pisani, Note a margine di: Carlo Ginzburg, Il filo e le tracce. Vero falso finto, Feltrinelli, Milano 2006
Come denuncia il sottotitolo (Vero falso finto) il tema intorno a cui si organizza Il filo e le tracce, la raccolta di alcuni dei più recenti saggi di Carlo Ginzburg, è quello della "verità" nella storia, accanto a quello – ad esso correlato – della storia come narrazione. In questo, Il filo e le tracce si pone in continuità con opere recenti del medesimo autore come Occhiacci di legno e Rapporti di forza.
Il bersaglio polemico è dichiarato: Ginzburg prende di mira le teorie storiografiche, come quella di Hayden White, improntate a ‘scetticismo’ che, negli ultimi decenni, hanno messo in discussione la peculiarità che alla narrazione storica è garantita dal suo privilegiato rapporto con la “verità”, e hanno, così, consentito una perfetta equiparazione della storia alle altre forme di narrazione, aprendo la strada (potenzialmente o effettivamente) a relativismi e negazionismi (tra tutte, assunta come modello polemico esemplare, la tesi di Robert Faurisson secondo cui i campi di sterminio nazisti non sarebbero mai esistiti). La storia, sostiene Ginzburg, è sì narrazione, e in quanto tale può essere accomunata alle altre forme di narrazione (“Un’affermazione falsa, un’affermazione vera e un’affermazione inventata non presentano, dal punto di vista formale, alcuna differenza”); ma una volta ammessa la pertinenza della storia al genere narrativo si tratta di definirla nella sua specificità. La posta in gioco è ben più di una polemica disciplinare: a venir toccato è un tema assolutamente cruciale (il rapporto delle scienze umane con la “verità”) che investe un ambito molto più vasto della storiografia e che possiede di per sé “implicazioni morali e politiche, oltre che cognitive”.
Come sua consuetudine, Carlo Ginzburg sceglie di affidare l’illustrazione della propria posizione non a un testo teorico unitario ma a una serie di saggi che affrontano temi disparati: “la maggior parte dei temi che avevo affrontato – afferma nell’Introduzione – non erano illustrazioni o esempi riferiti a una norma preesistente, bensì casi; storie in miniatura che [...] pongono una domanda senza fornire la risposta, segnalando una difficoltà irrisolta”. Ginzburg mette dunque alla prova la sua ipotesi teorica su casi specifici; i casi, proprio in forza della loro specificità, risultano tuttavia disponibili alla riduzione esemplificativa e non si lasciano trattare come mere illustrazioni di una tesi; ciascuno di essi, infatti, pone “una domanda senza fornire la risposta”.
Si ha l’impressione che proprio perché, da bravo storico, persegue tenacemente la libertà e l’autonomia degli esiti delle sue ricerche, Ginzburg finisce per vanificare la possibilità – che egli stesso propugna – di affrontare e di confutare con argomentazioni puntuali le tesi della storiografia ‘scettica’: i casi che danno materia alle diverse ricerche condotte in saggi nati per occasioni, esigenze e spunti diversi risultano infatti eterogenei e irriducibili a un unico filo conduttore. In ultima istanza lo storico si rifiuta di manipolare gli esiti delle proprie ricerche al fine di farli forzatamente rientrare nella cornice ermeneutica in cui, pure, li inserisce: convocati come testimoni, i singoli casi non si comportano come convincenti verifiche della teoria generale, alla quale vorrebbe ricondurli (ma, a quanto pare, a posteriori) la cornice, teorica e polemica, del libro. Già a questo livello si evidenzia così una contraddizione che attraversa in profondità Il filo e le tracce (ma anche Occhiacci di legno e Rapporti di forza).
Il filo e le tracce si ripropone dunque, con ambizione e coraggio, di offrire un modello alternativo di storia rispetto a quello teoricamente elaborato e articolato da Hayden White (che a tale riguardo Ginzburg accomuna a Barthes e de Certeau), e che si fonda – afferma lo storico citando Eric Hobsbawm – sulla “convinzione che ‘la mia verità vale quanto la tua, indipendentemente dalla prove addotte’”, ossia sul “fatto”, per dirla con le parole dello stesso White, “che nella documentazione storica non troviamo nessun elemento che ci induca a costruirne il significato in un senso anziché in un altro”.
Una forte intenzione polemica motiva dunque il lavoro ginzburgiano, ma i temi affrontati nei diversi saggi non possono essere chiamati in causa, a quanto sostiene lo stesso autore, come “illustrazioni o esempi riferiti a una norma preesistente”. Ginzburg, per ottime ragioni di prudenza metodologica, è più che restio a supportare la sua teoria con ‘casi’ ridotti a exempla, ed è ben attento a mettere in guardia – se stesso e il lettore – contro il pericolo di un circolo vizioso che chiuderebbe la singolarità degli eventi in una griglia teorica preconfezionata, finendo per ridurre la ricerca a un recupero di tasselli e di ‘prove’ della teoria generale che lo storico è impegnato a confermare. Tuttavia, proprio nella contraddizione tra intento teoretico fortemente connotato e verifica della teoria nella pratica della ricerca storica risiede, non da ultimo, l’urgenza e l’attualità delle questioni che Ginzburg solleva.
La contraddizione che abita nella forma de Il filo e le tracce – libro a tema o raccolta di saggi? – è in relazione con un’altra, fondamentale, ambiguità teoretica che si riscontra nei saggi più strettamente raccordati alla tesi generale del libro, in particolare in Unus testis. Lo sterminio degli ebrei e il principio di realtà e in Microstoria: due o tre cose che so di lei. Nel primo Ginzburg si cimenta direttamente nella confutazione della tesi di Hayden White, mettendone in discussione la proposta di ridurre il “vero” storiografico a quanto è 'efficace' a seconda di una specifica tesi narrativa, ossia di un determinato punto di vista. A questa posizione Ginzburg oppone un’idea di “verità” che, attingibile grazie al mestiere dello storico e alle sue armi disciplinari, viene posta come l’obiettivo epistemico della ricerca storica. Contro il presupposto – metafisico quando non addirittura fideistico – di una dimensione di “verità” e di “realtà” che lo storico sarebbe chiamato a recuperare sta però la neutralità del documento.
È lo stesso Ginzburg a citare per due volte nel volume un passaggio di Renato Serra del 1912:
“C’è della gente che s’immagina in buona fede che un documento possa essere un’espressione della realtà [...]. Come se un documento potesse esprimere qualche cosa di diverso da se stesso [...]. Un documento è un fatto [...]. Ogni testimonianza testimonia soltanto di se stessa: del proprio momento, della propria origine, del proprio fine, e di nient’altro”.
Ha ragione Ginzburg nell’osservare come “Serra sapeva bene che qualunque documento [...] ha sempre un rapporto altamente problematico con la realtà”; tuttavia, proseguendo il suo ragionamento, Ginzburg stesso opera una lettura semplificata del passo affermando che, comunque, secondo Serra “la realtà (“la cosa in sé”) esiste”. Serra sembra invece mettere in discussione proprio l’attingibilità della “realtà” mediante il documento, e quindi la presunta oggettività del dato come elemento primario della ricostruzione storica.
Presupporre l’esistenza di una “verità” e di una “realtà” e soprattutto la loro attingibilità trascende, d’altro canto, l’ambito delle discipline storiche e investe un ambito di speculazione squisitamente teoretico. In che senso, dunque, la storia può (forse: deve) occuparsi di “realtà” e di “verità”? Può la storia appurare il vero, o forse si limita esclusivamente a escludere il falso? Può la “verità” appurata dalla storia essere assolutamente indipendente dalle convenzioni narrative stabilite tra l’autore e il lettore? A quel punto si può ancora trattare di “verità”? E, anche nei casi in cui lo storico appuri il vero – riconoscendo, ad esempio, che un tale evento si è svolto in un determinato momento piuttosto che in un altro – può, la storia, anche soltanto pretendere di dimostrare, prove alla mano, i ‘veri’ moventi delle res gestae? Non sa forse lo storico, meglio di chiunque altro, che spesso le ragioni dell’agire sfuggono allo stesso attore? Per dirla con le bellissime parole di Agostino Mascardi citate ne Il filo e le tracce:
“Incaminano [...] i Princi i loro affari con segretezza sì grande che il penetrargli fino al midollo è assai più malagevole che non fu la dichiaratione dell’enimma posto dalla Sfinge”.
Non si insinua allora, nel tessuto della ricostruzione storica, un’ineliminabile forma di “finzione”, nel momento stesso in cui lo storico si accinge a porre in relazione i fatti appurati, ossia a tessere i fili in una qualsivoglia trama secondo un proprio disegno interpretativo? E se, poi, i fili vanno a disegnare trame diverse? come decidere tra ipotesi alternative se accade (come spesso accade) che il trattamento degli stessi documenti da parte di storici diversi componga disegni interpretativi diversi? Esistono “verità” e “realtà” parallele che possono venire alla luce dell’espressione a seconda dell’intenzione ermeneutica di uno storico rispetto a un altro?
Questi alcuni dei principali interrogativi che la lettura di Ginzburg sollecita. Con la storia la “verità” ha certamente un rapporto decisivo e fondante – proprio come riconosce Ginzburg versus White – ma, tuttavia, più complesso di quanto non si evinca dalle pagine de Il filo e le tracce. Quella storica è una narrazione. Al contrario però di altre narrazioni (ad esempio a differenza della ‘finzione’ letteraria o teatrale) essa ha faticosamente tentato di dotarsi di strumenti verificabili secondo un codice condiviso e procedure certe, distinguendosi proprio in virtù di questo sforzo dalle altre narrazioni (e qui sarebbe il caso, forse, di applicare anche alla narrazione storica la differenza tra le categorie del fictum e falsum). Tanto il codice quanto le procedure, occorre però ricordarlo, sono pur sempre a loro volta storicamente determinate. Solo una volta che si assuma questa condizione come premessa, l’insistenza sulla "realtà" può evitare di ricadere nel “positivismo ingenuo”; senza tener conto della relazione complessa che intercorre tra storia e “realtà”/“verità” si rischia, infatti, di ricadere in semplificazioni forse altrettanto perniciose, sul piano ermeneutico, dello scetticismo ‘relativistico’ e, al limite, ‘negazionista’.
Lo storico, proprio per la fiducia che è tenuto per mestiere a professare nei confronti del valore della dimensione storica, deve infatti avere piena coscienza del fatto che il suo pensiero opera in un contesto determinato: deve perciò mettere in conto che non può sottrarsi dal deformare ciò che sottopone a indagine; grazie alla consapevolezza che acquisisce a tale riguardo può però giungere a controllare questa stessa deformazione, conscio del fatto che essa è ineliminabile e che trascurarne, o peggio negarne, l’esistenza in nome di una astratta neutralità sarebbe il miglior modo per restarne prigionieri. Come ben sa il pensiero storiografico occidentale a partire almeno da fine Ottocento (in reazione all’imperante positivismo), la storia è, infatti, essenzialmente una ‘costruzione’. Dopo Benjamin, lo storico – e in primis uno storico del rango di Ginzburg – sa bene che non è più possibile prestar fede alla pretesa di restituire, come aveva affermato Ranke, il passato “come esso è veramente stato” ("wie es eigentlich gewesen"). Lo storico è costretto a dubitare dei fondamenti del proprio operare: tanto delle tecniche che adotta quanto degli oggetti su cui appunta lo sguardo. Nutrire dei dubbi, operare sulla propria prassi una critica continua, tuttavia, non significa necessariamente essere scettici ed eticamente indifferenti. Spesso, anzi, è proprio la presunzione di aderire alla "verità" – che comporta il rischio ermeneutico di regredire all’epoca della storiografia che precede la critica alla concezione positivistica della storia – a risultare il più infido attentato alla verità stessa.
Entra qui in gioco la responsabilità etica della ricerca storiografica, una responsabilità da intendersi in due diversi aspetti. In primo luogo la responsabilità riguarda la fase della ricerca in cui lo storico è chiamato ad operare secondo onestà deontologica: non forzare né manipolare dati e documenti, ma trattarli in modo il più possibile corretto e trasparente, specie quando il vaglio e il controllo non sia agevole per chiunque voglia sottoporre a verifica gli stessi dati o documenti, o riutilizzarli per una ricostruzione ulteriore. In secondo luogo la responsabilità riguarda la valenza ‘etica’, e gli eventuali riflessi ideologici, della ricostruzione che lo storico propone al pubblico. Una doppia responsabilità che denuncia come vi sia ben altro, oltre alla “realtà” e alla “verità”, a orbitare nel campo della riflessione della storia su se stessa e che caratterizza problematicamente la deontologia dello storico. Proprio Ginzburg, del resto, rivendica il diritto di rifiutare le posizioni di White per ragioni di natura ‘etica’: la deriva revisionista e negazionista del relativismo storiografico applicato al Novecento assume infatti, inevitabilmente, un pericoloso colorito ideologico. Ma – viene da chiedersi – come conciliare le due responsabilità? Appellandosi ai valori di un’etica, che saranno, come lo studioso ben sa, anch’essi connotati in senso storico, lo storico non finirà per rinunciare alla libertà della sua ricerca, o ad operare illecite deformazioni? La prospettiva da cui lo storico inquadra il campo visivo – la “realtà” – non sarà fortemente deformata dal pregiudizio etico? E non sarà preclusa la possibilità di cogliere un’altra parte del campo visivo? In caso contrario, tuttavia, rinunciando cioè ad assumere una posizione eticamente connotata, non rischierà lo storico di abdicare al suo ruolo intellettuale?
Tutto questo, Ginzburg, senza dubbio uno dei maggiori storici italiani di oggi, ovviamente lo sa bene. Parlando del proprio passato e della propria opzione per la microstoria, Ginzburg stesso osserva, nel saggio sulla microstoria, come
“l’atteggiamento sperimentale che ha coagulato, alla fine degli anni Settanta, il gruppo degli studiosi italiani di microstoria [...] era basato sull’acuta consapevolezza che tutte le fasi che scandiscono la ricerca sono costruite, e non date. Tutte: l’identificazione dell’oggetto e della sua rilevanza; l’elaborazione delle categorie attraverso cui viene analizzato; i criteri di prova; i moduli stilistici e narrativi attraverso cui i risultati vengono trasmessi al lettore”.
Ne Il filo e le tracce Ginzburg, in armi contro le derive dello scetticismo storiografico e intento a riportare l’accento sui fatti contro il relativismo dell’interpretazione, sembra però troppo cauto nel trarre le giuste conseguenze dalla sua stessa lezione di metodo. Eppure dalla lettura di questi saggi vengono proficuamente suscitate le domande che, in qualche misura, attraversano e quasi costituiscono il mestiere dello storico: in base a quali criteri è possibile operare una costruzione, evitando di ridurre la storia a una inutile – e impossibile – enumerazione di fatti? Come è d'altro canto possibile operare una costruzione tale da lasciar parlare i fatti, senza che sia invece lo storico ad essere parlato dalle categorie che consapevolmente o inconsapevolmente lo condizionano? In che modo è che la storia si definisce, attraverso la costruzione che attua, come un’operazione intellettuale? Tali le cruciali domande che Il filo e le tracce consegna al lettore.
Per citare questo articolo / To cite this article: F. Lollini, G. Cengiarotti, D. Pisani, Storia e narrazione: retoriche della verità e strategie della finzione. Note a margine di due saggi di Carlo Ginzburg, “La Rivista di Engramma” n. 52, novembre 2006, pp. 25-48 | PDF of the article