Sara Copio Sullam a dialogo con gli intellettuali del suo tempo
Baldassare Bonifacio, Ansaldo Cebà e l’Accademia degli Incogniti
Monica Centanni, Anna Ghiraldini
English abstract
Sara, la “bella Hebrea”
“Bella Hebrea” così si autodefinisce in un suo sonetto, Sara Copio Sullam, giovane poetessa vissuta a Venezia nella prima metà del Seicento. E non solo bella, ma anche coltissima, generosa, libera: il ritratto di signora veneziana che ci viene dalle fonti contemporanee dipinge una donna di precoce intelligenza, sapiente in teologia, filosofia, storia, musica e letteratura; poliglotta, fiera della propria appartenenza alla comunità ebraica, ma libera anche nella declinazione, tutta personale, di quella appartenenza; protagonista di dibattiti e dispute filosofiche e letterarie; impegnata nella rottura del cerchio di isolamento che pregiudizialmente caratterizza le comunità ebraiche ma che a Venezia, anche grazie a intellettuali “gentili” di larghe vedute, si presenta in forme del tutto diverse rispetto ad altre realtà.
Leon Modena, teologo e intellettuale, rabbino dallo spirito indipendente, suo amico e precettore, a Sara dedicò la tragedia Ester (Venezia 1619), identificando lo spirito della bionda signora veneziana con quello dell’eroina biblica. Proprio con Leon Modena Sara è coinvolta nei circoli culturali più prestigiosi del tempo ed è al centro di un vivace salotto di liberi spiriti, i particolare la straordinaria Accademia degli Incogniti, costituita negli anni '30 da Francesco Loredan; lei stessa è animatrice di un salotto filosofico e letterario, aperto a Ebrei e a Gentili, nella casa del marito – Giacobbe Sullam – in Ghetto Vecchio.
Non sono molte però le tracce letterarie sopravvissute: le opere attribuite con certezza a Sara – che presentiamo qui analizzate e trascritte – sono alcuni sonetti contenuti nell’epistolario che intrattenne per quattro anni con il letterato genovese Ansaldo Cebà (nella cui edizione del 1623 mancano purtroppo le lettere della veneziana), e soprattutto il Manifesto di Sarra Copia Sulam Hebrea. Nel quale è da lei riprovata, e detestata l’opinione negante l’immortalità dell’Anima (Venezia, 1621) – l’unica opera che l’autrice consegna alle stampe: si tratta di una risposta all’attacco di uno dei partecipanti all’Accademia degli Incogniti, il vescovo di Capodistria Baldassare Bonifacio, che l’aveva accusata di non credere all’immortalità dell’anima (sul Manifesto si veda la trascrizione e il contributo di Anna Ghiraldini in questo stesso numero di Engramma).
Sara Copio Sullam fu al centro di un'altra diatriba – più di un ragggiro e accusa di plagio a dire il vero – mossale dai suoi stessi ospiti letterati: si narra infatti di una raccolta di satire contro di lei, Sarreide, ora perduta. Di questi eventi resta traccia in un manoscritto inedito, conservato alla Biblioteca del Museo Correr (Ms Cicogna n. 270), il cosiddetto “Codice di Giulia Soliga”: Avviso in Parnaso è una pièce paradrammaturgica in cui, in Parnaso, si inscena un processo contro Numidio Paluzzi, il maestro e detratttore di Sara. Avvocati dell’intellettuale ebrea sono nientemeno che le poetesse più illustri del passato antico e prossimo – Saffo, Corinna, Vittoria Colonna, Veronica Gambara – mentre il giudice, che la scagionerà completamente, è Pietro Aretino. Non si può parlare di scritto autografo, sebbene il nome dell’autrice “Giulia Soliga” o “Solinga” abbia tutta l’aria di essere uno pseudonimo, se non un nome collettivo: su questa traccia, e sul nome “Soliga pro Solinga” si apre una nuova pista di ricerca che potrebbe portare all’attribuzione a Sara, in parte o in tutto, di questa sapida operetta (si veda il contributo di Anna Ghiraldini in questo stesso numero di Engramma).
Gli studi sulla figura di Sara Copio Sullam, di cui nemmeno si sa con certezza la data di nascita (stando all’atto di morte del 1641 la data di nascita potrebbe essere spostata dal 1590 a ridosso del 1600, cfr.Busetto 1981, Busetto 1983), fanno principalmente riferimento alle ricerche d’archivio compiute da Carla Boccato (Boccato 1973, 1974a, 1974b, 1980, 1986). Il profilo biografico resta quello proposto da Giorgio Busetto nel “Dizionario Biografico degli Italiani” (Busetto 1983), mentre la figura e l’opera dell’intellettuale sono inserite nel panorama della produzione letteraria femminile del XVII secolo in due interessanti dissertazioni dottorali (Fonseca-Wollheim 2000; Westwater 2003). Alcuni contributi significativi sono venuti inoltre dalle ricerche sugli aspetti stilistici della produzione poetica di Sara – soprattutto i Sonetti, ma anche la raffinata e vivacissima prosa del Manifesto (vedi soprattutto Fortis 2003) – e da un importante e recente contributo che evidenzia i legami tra Sara, l’Accademia degli Incogniti e il circolo libertino stretto attorno alla figura di Giovanni Francesco Loredan (Adelman 2015).
Il Manifesto dell’immortalità dell’anima, in risposta a Baldassare Bonifacio (Venezia, 1621)
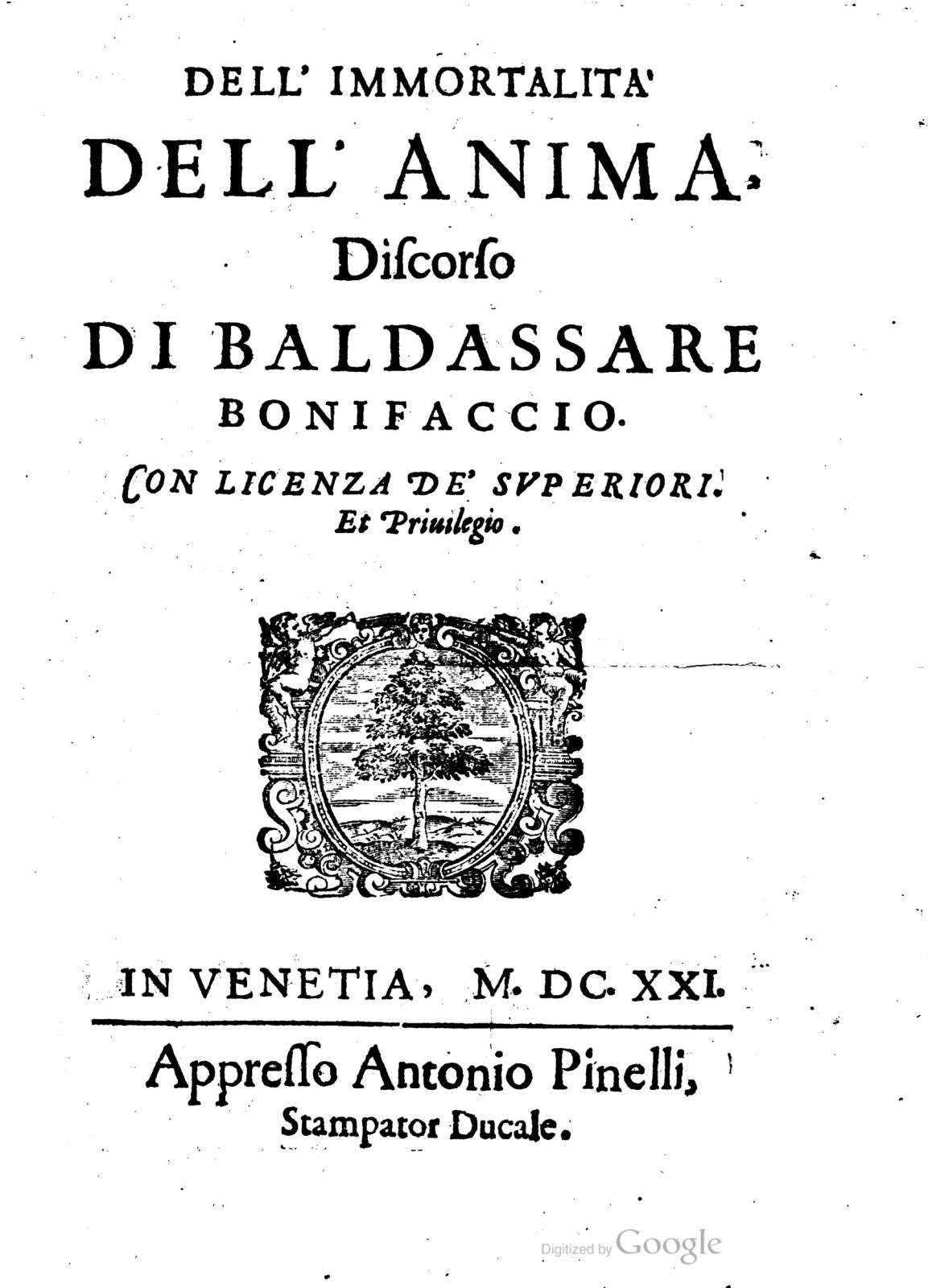
Frontespizio del Trattato sull’immortalità dell’anima di Baldassarre Bonifacio. Oggetto del libro a stampa è l’accusa, che lui muove a Sara, di non credere nell’immortalità dell’anima
Nel 1621, Baldassare Bonifacio, vescovo di Capodistria, dà alle stampe il volume Dell’immortalità dell’anima, Discorso di Baldassarre Bonifacio: oggetto del pamphlet è un attacco mirato a Sara Copio Sullam, la brillante intellettuale protagonista della vita culturale veneziana del tempo, accusata dal vescovo di non credere nella dottrina dell’anima immortale. Essendo la fede nell’immortalità – argomenta l’alto prelato – considerata fondamentale sia per l’ebraismo sia per il cristianesimo, la sua negazione espone la pensatrice ebrea al pericolo di persecuzioni per eresia sia da parte delle autorità ebraiche che da parte di quelle cristiane. Il trattato è concepito come una risposta a una lettera che la Copio aveva indirizzato a Bonifacio in cui esponeva al vescovo – frequentatore come Sara degli stessi salotti intellettuali veneziani – alcune sue perplessità sull’immortalità dell’anima. Si trattava – replicherà Sara – di un puro esercizio di speculazione filosofica che era stato dal vescovo affatto frainteso: Sara si interroga circa l’eternità della materia, e non sulla corruttibilità dell’anima, e circa la transitorietà dell’uomo, che è una funzione del numero e quindi del movimento.
Bonifacio apre il suo libello con un riconoscimento della straordinaria caratura intellettuale della sua interlocutrice. l’appartenenza al genere femminile, anziché penalizzare l’autorevolezza della sua parola, suggerisce un'immediata assimilazione di Sara con la Diotima di Platone, in questo senso Sara è la “Luna delle filosofesse”:
Io mi pregio di haver trovato così dotta maestra, come voi sete; né mi sdegno di imparare da femina, perché ne gli intelletti non è distinzione di sesso. E se non si vergognò Platone, che Diotima gli aprisse alcun secreto della scienza naturale, perché mi renderò schifo io, tanto inferiore a Platone, di esser disciplinato da voi, tanto superiore a Diotima? A gran torto Lucretio disse che Epicuro era il Sole de' Filosofi: & io dirò con molta ragione che voi sete la Luna delle Filosofesse (Immortalità, p. 5).
Fisicamente e spiritualmente, Sara è bella e luminosa come la luna; ma è proprio la bellezza destinata a svanire, una delle differenze con l’anima immortale:
Cotesti vostri occhi brillanti diverranno cispi, non ci inganniamo; vizze diverranno le poppe, e grinze le carni. Diverrà cadavere il corpo, e rimarrà finalmente putredine, e fango. Non così l’anima, la quale si prova esser incorruttibile non solamente per le ragioni accennate, ma per molti altri argomenti, e demostrationi (Immortalità, p. 11).
Rivolgendosi all’intellettuale ebrea, Bonifacio fa ostentazione della sua conoscenza della lingua dell’Antico Testamento e dei suoi conseguenti esercizi di ermeneutica semantica:
Vorre dunque sapere, quando l’anima dell’huomo sia caduca, e s’estingua insieme col corpo, qual fosse quello spiracolo di vita, che Iddio di sua propria bocca, per così dire, soffiò nella faccia di Adamo? [...] Quello spiracolo di vita, e quell’animo ragionevole, che infuse Iddio nell’huomo, la divina Scrittura lo chiama Nesciamah. l’anima sensitiva de bruti è chiamata Nephes e non è spirata da Dio, ma prodotta da gli elementi; perché si cava dalla potenza della materia. Però dice la Scrittura: Producano le acque, e produca la terra l’anima (Nephes) delle fiere,e de pesci. [...] Vengo dunque alle ragioni. E prima distruggo i fondamenti c'havete gittati, per fabricar l’edificio mio sù le ruine del vostro (Immortalità, p. 7)
Ma poi, rivolgendosi alla Sara filosofa, piuttosto che fare riferimento a testi teologici, oltre ad argomenti di logica, di etica, Bonifacio richiama soprattutto l’auctoritas di filosofi e poeti greci e latini, alla quale sa che la sua dotta interlocutrice sarà sensibile, che a grande maggioranza sono a favore dell’immortalità dell’anima, fatta eccezione di Alessandro d’Afrodisia e dei “porci” epicurei:
Tutti i Platonici, e tutti gli Aristotelici hanno sempre tenuta e difesa la immortalità dell’anima, eccettuato l’Afrodiseo [i.e. : Alessandro d’Afrodisia], con alcuni altri porci della greggia d’Epicuro (Immortalità, p. 12)
In sostanza, nel pensiero antico la tesi dell’immortalità dell’anima è tutt'affatto maggioritaria. Importante è il collegamento con il pensiero aristotelico sul primum movens:
L’intelletto non ha parti, perche è individuo, dunque immobile. Ovvero: ciò che si move parte è nel termine a quo, parte nel termine ad quem. La mente humana, essendo indivisibile, non ha parti; e sempre è tutta ovunque ella sia. Dunque immobile. Ancora: il movente primo non è mosso, altrimenti non si potrebbe dir primo: anzi, prima di lui ci farebbe un altro movitor del movente. E così senza fine. l’intelletto nell’huomo è movente primo (Immortalità, p. 43)
Bonifacio adotta un argomento estetico di matrice aristotelica, giocato in opposizione all’estetica empedoclea:
Le operationi di genere diverso deono farsi con organo diverso. Il sentire e l’intendere sono operationi di genere diverso dunque deono farsi con organi diversi. Ancora: non è possibile che un’organo stesso serva al senso ed all’intelletto. Tutto il corpo è organo del tatto, dunque tutto il corpo non può esser organo dell’intelletto. Se già non volessimo delirar con Empedocle, il quale stimò che il sentire e l’intendere fossero una cosa medesima e che l’una e l’altra di queste due facoltà, così la sensitiva come l’intellettiva fosse corporea. Ma s'è provato di sopra che sono distinte e che l’intellettiva è del tutto incorporea (Immortalità, p. 51)
Bonifacio fa riferimento soprattutto al pensiero neoplatonico, convocato esplicitamente e incrociato allusivamente con il motto-simbolo della filosofia socratica:
Può senza dubbio l’intelletto humano, illuminato da raggio divino, conoscer sé stesso (Immortalità, p. 56)
l’obiettivo però non è tanto la vittoria dialettica o teoretica sulle posizioni di Sara, quanto piuttosto la conquista della sua anima alla fede cristiana, che va strappata alla “abiettissima Sinagoga”:
Là onde io, che son Christiano, vorrei dichiararmi Giudeo, se l’anima nostra fosse caduca. Ma, perché ella è certissimamente perpetua, voi, che sete Hebrea, vi dichiarerete Christiana. Sì sì vi libererete dalla fervità di cotesta abiettistima Sinagoga e verificherete il vostro honorato nome di SARA, divenendo Signora e padrona di voi medesima (Immortalità, p. 58).
Anche le allusioni alle figure del mito antico sono usate da Bonifacio come argomenti di seduzione intellettuale, nella dialettica di un gioco erudito che il vescovo sa condiviso:
Voglio che diventiate una Progne, una Medea e se volete alcuna delle vostre, una Maria d’Eleazaro. Svenate i vostri affetti, smembrate le vostre passioni, trucidate i vostri figliuoli, che sono i vostri peccati. Felice voi, fortunata voi, ben'aventurata voi, generosa e magnanima voi più di Delbora e di Giuditta, se strozzerete questi vostri figlioli. Nol credete a me, credetelo al vostro maggior Profeta: Beato chi calterisce i suoi pargoletti alla pietra. La pietra è GIESÙ, quella pietra angolare che fa di due uno, congiungendo il vecchio col novo Testamento. Schiacciate i vostri pargoletti con questa pietra ma tosto: affrettatevi perché vanno crescendo. Uccideteli prima che nascano, acciò che nascendo come viperini non uccidano voi (Immortalità, p. 60).
La diatriba è presentata come un “corpo a corpo” o meglio “anima con anima”: una psicomachia, nella quale soltanto l’anima di Sara potrà soccombere, perché è lei a credere che l’anima sia mortale, la maschera che Bonifacio assume per sè è quella di un “novello Orfeo” che si muove “ad entrare in questo abisso profondo [...] solamente per cavar voi bella Euridice dal baratro dell’Inferno” (Immortalità, p. 6).
La stessa impresa di Sara – che impariamo qui essere la formica – viene interpretata come l’allegoria di una preparazione alla vita eterna:
Mentre tengo in mano la vostra lettera e ci vedo l’impronte đella formica, la quale voi portate scolpita nel vostro suggello [...]. La formica prevede la futura tempesta: voi dovete prevedere l’horrendo giudicio di Dio. La formica nel tempo estivo repone la vettovaglia per la invernata: voi nella vita presente dovete raccoglier la messe dell’opere buone, per la ventura (Immortalità, p. 58; un altra allusione alla formica è a p. 59).



Tomba di Sara Copio Sullam al Cimitero ebraico del Lido di Venezia
Dettaglio dello stemma della famiglia Copio Sullam (con paronomasia Copio/scorpio, Sullam/scala) scolpito sulla lapide di Sara
Dettaglio della formica scolpita sulla lapide di Sara
Il pamphlet si chiude con un Sonetto a cui Bonifacio affida l’ultimo richiamo alla dissonanza tra la bellezza esteriore di Sara, per definizione caduca e fugace, e la “tomba dell’anima” che quella stessa bellezza nasconde e che le fa rischiare la perdizione:
Sara, la tua beltà cotanto audace,
Che sdegna tra le prime esser feconda,
E però più caduca assai che fronda,
E però più che vento assai fugace.
Е, se potessi dir, ma con tua pace,
Ciò che la tua bellezza in sé nasconda,
Io direi ch'ella è tomba, ou' alma, immonda
Di colpa original, sepolta giace.
Questa è la colpa, onde quel colpo uscio,
Che la forma immortal di vita priva,
E corrompe l’imagine di DIO.
Corri, corri al lavacro, ond'hor deriva
La vita: CHRISTO è quell’angel sì pio,
Che col sangue i morti figli avviva.
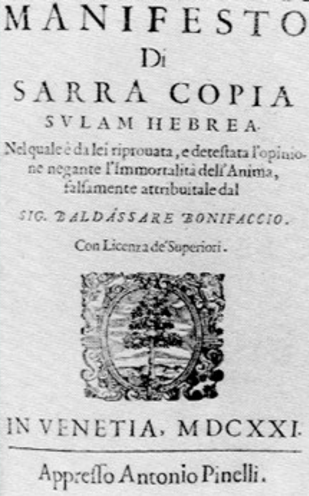
Frontespizio del Manifesto di Sara in risposta al libello infamante di Baldassarre Bonifacio (unica opera a stampa di Sara). Riproduzione integrale on-line dell’edizione Venezia 1621
In risposta al libello di Bonifacio, Sara scrive un pamphlet che intitola Manifesto di Sarra Copia Sulam Hebrea. Nel quale è da lei riprovata, e detestata l’opinione negante l’immortalità dell’Anima, falsamente attribuitale dal Sig. Baldassare Bonifaccio. Lo pubblica presso Antonio Pinelli nel 1621 e sarà l’unica opera che Sara darà alle stampe. Proprio nel Manifesto Sara dà conto della sua cifra di elegante discrezione, che si oppone alla moda corrente di “correre alle stampe” con qualunque pensierino uno abbia buttato su carta – così Sara, dando una bella prova di, rinascimentale, sprezzatura:
[...] altro non vi ha indotto a far sì longa e vana fatica se non quella vana ambitioncella che vi fa correr volentieri alle stampe credendo che la fama consista in haver di molti volumi fuori, senza haver consideratione alla stima che ne fa il mondo, il qualche credo sappiate per esperienza quanto mal di sottisfaccia di cose mediocremente buone, non che le dozinali e scioccamente composte (Manifesto, p. 21-22)
Sara dedica l’opera all’amato padre, Simon Sullam che “ha fatto passaggio da questa mortal vita”, “come caparra dell’affetto immenso” della sua diletta figlia; ma, rivolgendosi all’anima del padre nell’Aldilà, fa anche una prima mossa dialetticamente efficace:
[...] accioché gl’effetti stessi corrispondessero a quel che nell’opera affermo esattamente l’essere immortale dell’anime.
Il Manifesto, afferma Sara, le è costato “la breve fatica di due giorni” (p. 11), ma il testo mostra, o più spesso lascia intravedere in filigrana, un reticolo impressionante di riferimenti alle fonti più varie: da Aristotele a Dante, dal Vecchio al Nuovo Testamento.
Respingendo, fin dalle prime battute, l’accusa del vescovo, Sara dichiara tutto il suo stupore per il fatto che l’opera sia a lei indirizzata. Sara ribadisce l’intonazione tutta filosofica della questione che aveva posto, aprendo con una chiara rivendicazione della libertà della professione intellettuale che deve essere concessa “ad ogni persona che professi studii, non che ad una donna, a donna Hebrea”:
Se pure in alcun discorso io vi ho promossa alcuna difficoltà filosofica o teologica, ciò non è stato per dubio o vacillamento che io habbia mai havuto nella mia fede, ma solo per curiosità d’intender da voi, con la soluzione de miei argomenti, qualche curiosa e peregrina dottrina, stimando ciò esser concesso ad ogni persona che professi studii, non che ad una donna, a donna Hebrea, la quale continuamente vien posta in questi discorsi da persone che si affaticano di ridurla, come vuoi sapete, alla Christiana fede (Manifesto, p. 10).
Non sfugga il fastidio con cui Sara stigmatizza le continue sollecitazioni e insistenze alla conversione al cristianesimo a cui è sottoposta; anzi, fieramente ribadisce che il suo stesso “preservarsi Hebrea” garantisce della sua fede nell’immortalità dell’anima.
A rimover ogni dubio della mia opinione in questo dovrebbe bastare il mio preservarmi Hebrea, perché quando io credessi, come voi dite, e non temessi di perder la felicità dell’altra vita, non mi sarebbono mancate occasioni, col cangiar legge, di migliorar il mio stato, cosa nota a persone di molta autorità, che l’hanno istantemente procurato e tentato (Manifesto, p. 12).
Fin dall’inizio del trattatello la postura dialettica che Sara adotta è improntata a una sontuosa superbia dispiegata nei confronti del suo interlocutore il quale affronta un tale argomento senza essere “né filosofo né teologo” (p. 14):
La pietà della mia legge mi fa pietosa della vostra simplicità, la quale vi ha fatto credere di farvi immortale di fama, con trattar dell’immortalità dell’anima e, non havendone alcuna pronta occasione, ve l’havete finta da voi stesso (Manifesto, p. 11).
Di Bonifacio viene stigmatizzata l’arroganza con cui il vescovo si è intestato la missione di interloquire con Sara dell’immortalità dell’anima per conto dello stesso Dio:
Ditemi dunque, di gratia, Signor Baldassarre, che cosa vi ha mosso a far quel trattato, a stamparlo et ad imbrogliarvi il mio nome. Voi dite con i versi di Virgilio che Dio vi ha eletto a questo: grand’arroganza veramente. Dunque non haveva il Signor Iddio per materia sì sublime e sì importante un ingegno più elevato et un ministro più dotto di voi, Voi solo ha scielto fra la schiera di tutti i litterati per atto a trattar sì degno soggetto: se l’immortalità dovesse esser inserta ne gl’animi, non con altra forza che d’humane ragioni, mal fornita al sicuro si trovarebbe se non havesse altre ragioni che le vostre che, benché da voi siano state cavate da dotti Autori, sono però state male intese e peggio riportate & il trattar debolmente materie tanto importanti è un invigorire le ragioni averse. Potreste dirmi che spesso Dio si serve di mezi bassi e vili ad oprar cose grandi per maggiormente far costare la sua onnipotenza e che fino all’asino di Balaam una volta parlò: è vero, ma in tali casi gl’effetti stessi sono apparsi divini e la viltà de gl’istrumenti non ha loro punto pregiudicato. Voi che scioccamente havete preteso di profetar da voi stesso senza altra inspiratione che di una troppa arroganza, havete mostrato ne gl’effetti la vostra crassissima ignoranza più tosto che alcuna maravigliosa virtù divina (Manifesto, pp. 12-13).
Il biblico asino parlante di Balaam (Nm 22) è un efficace esempio del fatto che Dio si può servire di qualsiasi creatura per far sentire la sua voce; ma nella lingua e nelle argomentazioni il vescovo si dimostra più bestia dell’asino del racconto. Sara si schernisce del titolo di “filosofessa” che Bonifacio le riconosce e però stigmatizza che la laurea in legge di cui il vescovo si fregia (“iuris utriusque Doctor”) non è un requisito sufficiente per poter trattare della questione dell’immortalità dell’anima. Inoltre, nella gamma delle varie e diverse ignoranze attribuite all’interlocutore, Sara evidenzia la scarsa conoscenza non già dei testi ebraici (fra i quali il “classico” Giuseppe Flavio) ma la misconoscenza dello stesso Vangelo che invece lei sa citare puntualmente e a proposito:
Io per me non vi parlo in questa guisa per far la maestra o la filosofessa in insegnarvi come voi per ischerno mi dite nel medemo tempo, che venite a farmi il pedante, poiché confesso di esser assai più ignorante di voi in queste scienza, ma per riferirvi quello che odo da tutti coloro che vedono il vostro libro. Altro ci vuole, Signor mio, che il titolo di Iuris utriusque Doctor, per trattare dell’immortalità dell’anima: ma per farvi accorgere della poca pratica che havete, si’ delle scritture spettanti al Teologo come delle ragioni spettanti al Filosofo, basti rammentarvi l’istessa calunnia che a me date nel principio, nella quale, supposto falsamente che io neghi l’immortalità, dite che io, sola tra gl’Hebrei dopo tanti migliaia d’anni, sono trascorsa in tal errore, nel che se pur non havete vedute le altre scritture, e Gioseffo Flavio Historico che le varie opinioni dell’Hebraica Natione riferisce, vi scuso: ma non vi scuso già che non habbiate a mente l’Evangelio della vostra Fede, poiché vi sareste ricordato che in San Mattheo, al cap. 22, li Saducei, una fetta di Hebrei che negava l’immortalità, andorono a promoverne anco difficultà a Christo, dal quale fu saviamente sodisfatto e posto silentio alle loro interrogationi (Manifesto, pp. 16-17).
Lo stesso Dio, secondo Bonifacio, avrebbe “scritto di sua mano” la verità dell’immortalità dell’anima; Sara smonta l’argomento della “chirografia” d'eccezione con una arguta e spiritosa risposta in cui chiede ragione della fonte:
Soggiungete anco che io nego fede all’infallibil chirografo che scrisse Dio di sua mano: io non so che altro chirografo si trovi nella Sacra Scrittura dalla mano di Dio scritto che il Decalogo, al quale io non solo aderisco con la fede ma anco con le opere, per quanto posso. Se voi havesti alcun’altra scrittura fatta dalla mano di Dio in proposito dell’immortalità, haverei caro di vederla (Manifesto, pp. 17-18).
Filologica e puntigliosa, Sara smonta la presunzione di una conoscenza linguistica, per quanto di base, della lingua ebraica che il suo accusatore ostenta:
Ma veggiamo quanto bene e con quanta pratica della lingua e della scrittura Hebraica vi siate anco valuto della voce Ruach per formarne argomento a vostro proposito. Dite che nella Sacra Scrittura significa propriamente questa voce, la mente Humana, l’Angelica e la Divina: io qui potrete richiedervi strettissimo conto di sì fatta interpretatione, se haveste parlato di vostro sentimento. Ma perché so che voi non havete mai veduta lingua Hebraica e che da altri è stato soffiato nella vostra ciarbottana, dirovvi solo che da questo fate conoscere chiaramente che anco le altre cose tutte che havete dette vi siete assicurato a dirle senza intenderle. Almeno in questo particolare, parlando voi con una Hebrea dovevate farvi imboccare da chi meglio intendesse la proprietà della lingua poiché Ruach altro di sua proprietà non significa che l’aria, il vento et il fiato col quale noi respiriamo, onde si può vedere quanto bene calzi la vostra conseguenza mentre pretendete per tal voce provare che l’anima sia assolutamente incorporea et immateriale (Manifesto, p. 18).
Dalla stigmatizzazione dello “scherzo insipido” di una sua denominazione come “Luna delle filosofesse”, Sara passa a demolire gli argomenti più squisitamente filosofici del suo interlocutore:
Delle ragioni poi spettanti al filosofo quanto siate intelligente, veggasi nell’istesso bel principio: dove dite che Lucretio chiama a torto “sole de’ filosofi” Epicuro, il quale negava l’immortalità dell’anima, et a me che voi stimate dell’istessa opinione, dite che conviene a ragione il nome di “luna delle filosofesse” e qual sia la proportione di questa ragione, lasci considerarlo a chi legge, benché io credo che quella comparatione sia stata da voi posta per occasione di scherzare insipidamente come in altro luogo quando affermate che la corruttione non si fa senza moto, cosa altretanto pregiudicante alla gravità della materia che si tratta quanto alla modestia conveniente alla vostra condizione et alla professione che fate di Religioso (Manifesto, p.19).
Ma non risparmia neppure una nota di acuto sarcasmo sull’eccesso di “affetto per la vita“ che muove atti e parole di colui che si professerebbe l’alfiere dell’immortalità dell’anima:
Né posso contenermi di notare anco un altro luogo appresso me tanto degno di riso, quanto voi lo fate di compassione et a carte dieci del vostro Libro nel fine, dove dite “Piacesse a Dio che più tosto da burla che la buon senno si morisse”, modo di parlare che esprime il vostro desiderio, il quale sarebbe di non morire, ancorché crediate l’anima immortale! Eh, Signor Bonifaccio, a che giuoco giochiamo? Credete fermamente quel che predicate o no? Se l’anima con la separatione dal corpo acquista meglior conditione di essere, come voi provate e come è certo, perché dunque posponete mal volentieri questo stato a quello donde deriva il vostro affetto più alla presente che all’altra vita? È pur vostro argomento a carte num. 14 che la morte, secondo la retta ragione, è alcuna volta da desiderarsi e preporsi alla vita, massime per le operationi di fortezza e di altre virtù, come voi ne apportate gl’esempi e l’autorità di Aristotele avvertite che questo contradirsi è cattivo segno (Manifesto, pp.19-20).
E pure sotto il profilo stilistico, dalle scelte linguistiche e sintattiche fino alla malfatta bozzatura del testo (che nessuno può continuare a leggerla senza “dar qualche titolo al compositore”), nulla si salva della requisitoria del vescovo nella spietata analisi di Sara:
Se non fusse per me digressione, mostrerei tante di queste sciocchezze e luoghi contradittorii che non resterebbe alcuna vostra propositione intatta; [...] oltre che mostrare i difetti et imperfettioni della vostra scrittura, altro volume vi bisognerebbe che di un breve foglio, non havendo ella altro di buono che la causa che difendete: nel resto, è così piena di false intelligenze di termini, di storti e mal intesi sentimenti di scrittura, di false forme di sillogismi, di cattive connessioni e strani passaggi da una in altra materia, di sproposite citazioni di autori e finalmente di errori di lingua, che nessuno può continuare a leggerla senza dar qualche titolo al compositore (Manifesto, pp. 19-20).
Resta oscura, agli occhi della attenta lettrice, la ragione che ha spinto Bonifacio a metter mano all’opera. Non può essere malignità, perché Sara di Bonifacio conosce la “amicizia e piacevolezza” di natura. Sarà la vanagloria che si esprime nella paradossale ostentazione pubblica di quanto uno meno sa fare:
La cagione che vi ha potuto movere ad intraprendere sì notabile impresa [...] non posso credere esser stata malignità, poiché di questa pare che mi assicuri la vostra amicizia e la piacevolezza della vostra natura. Potrebbe forse dirsi esser stato l’istesso non sapere, atteso che mi ricordo haver letto nel Galateo che, tra l’inciviltà che commettono gli huomini, una è il voler far ostentatione di se stessi in quello in che manco vagliono e però, dice egli, si trovano molti li quali non sapendo cantare o havendo cattiva voce prorompono sempre in qualche cantilena mentre sono nelle conversationi; e chi non sa ballare vuol sempre far lo snello et il leggiardo ne’ movimenti, il che si può crder che facciano per esser tenuti scientifici in quello in che fanno di esser più ignoranti, e non si accorgono che non solo accrescono il concetto della lor ignoranza ma disgustano la conversatione, al qual proposito può applicarsi anco l’esempio di coloro li quali havendo qualche parte difettosa cercano sempre adornarla di vestimenti vaghi, come alcuno che havendo le gambe storte procura portarvi sempre calze de vaghi colori quasi per fare che la bellezza esterna compensi il difetto interno e non si avvede che in tal guisa fa maggiormente riguardevole esso difetto et alletta gl’occhi de’ riguardanti a considerarlo. Se da tal movimento havesse havuto origine la vostra opra, Signor Baldassare, faccio giudice voi stesso se sarebbe da sottoporre alla disciplina del Galateo (Manifesto, pp. 21-22).
O forse, nota beffarda Sara, è ancora quella bramosia di “correre alle stampe” con tutto quello cha a uno capita di buttare su carta:
Horsù senza più andar affaticando il pensiero per investigare altre ragioni, a me da l’animo d’indovinar la vera questa volta e so che voi il confesserete alla libera: altro non vi ha indotto a far sì longa e vana fatica se non quella vana che vi fa correr volentieri alle stampe credendo che la fama consista in haver di molti volumi fuori, senza haver consideratione alla stima che ne fa il mondo, il qualche credo sappiate per esperienza quanto mal di sottisfaccia di cose mediocremente buone, non che le dozinali e scioccamente composte e però a non correr così facilmente alla stampa (Manifesto, pp. 22-23).
È dunque la brama di gloria che ha spinto Bonifacio a entrare in campo contro Sara, donna ed Ebrea, credendosi all’altezza di sfidare “gl’Empedocli, gl’Anassagori, gl’Epicuri, gl’Aristoteli, gl’Alessandri Anfrodisei, gl’Averroi”:
Bisognava per mostrarsi intrepido e valoroso sfidar gl’Empedocli, gl’Anassagori, gl’Epicuri, gl’Aristoteli, gl’Alessandri Anfrodisei, gl’Averroi e poiché a loro non è conceduto venire dove campeggiate voi, andarli a trovare ne’ loro steccati medemi, che con altretanta facilità haverebbono forse rintuzzato il vostro orgoglio, con quanta poca modestia voi sparlate di alcuni di loro con titolo anco di porci. Ma, per quel che vedo, voi havete voluto fare, come si suol dire, il bravo in credenza, poiché non solo siete comparso in isteccato dove non è chi contradica alla vostra querela, ma dove, quando anco haveste contradittore, che non credo, non è conceduto il campo franco (Manifesto, p. 24)
Sprezzante e sempre più beffarda questa Sara che descrive il suo detrattore nell’atto di cantarsi da solo la vittoria di una battaglia che lei non aveva intenzione di combattere, mentre lei stessa si ritira, elegantemente, per non sprecare più oltre il suo tempo ed evitare l’esibizione “al mondo delle stampe“ che va in contrasto con la sua discrezione:
[...] di modo che, o valoroso sfidatore delle donne, il campo è tutto vostro: passeggiate in esso pur altiero, vibrando i colpi all’aria, o valoroso campione, o generoso guerriero, e senza che si oda altro strepito che della vostra rauca tromba, gridate pur da voi stesso: “vittoria, vittoria!” e, benché al suono di queste mie brevi parole vi parrà forse di haver trovato qualche incontro da poter intraprender nuova giostra, vi replico, come di sopra vi ho dichiarato, che questo non è cartello di risposta alla vostra sfida, ma un semplice manifesto per iscusarmi del mio non comparire, non essendo cagion di combattimento dove non è contrarietà di pareri, né in detti né in fatti, sì che per me potete deporre affatto l’armi che ancorché mi provocaste di nuovo con mille ingiurie, non sono più per contraporvi alcuna replica per non consumare inutilmente il tempo, massime essendo io così nemica di sottopormi a gl’occhi del mondo nelle stampe, come voi ve ne mostrate vago, vivete lieto, e sperate per voi giovevole quell’immortalità che predicate e se viverete così osservatore della vostra Christiana legge come io professo di essere della mia Hebrea (Manifesto, pp. 24-25).
E se Bonifacio si proponeva come un Orfeo, Sara rispondendo per le rime al suo Sonetto di chiusura, non è un'Euridice da salvare da nessun inferno, dato che lei abita il mondo della luce:
Hora, poiché voi per terminare con piacevolezza e diletto il vostro discorso, vi aggiungete la cantilena di un Sonetto per mostrarvi in effetto con la cetra in mano quell’Orfeo, che nell’opera stessa presumete di essere sufficiente a cavare una novella Euridice dall’Inferno, io, per comparire in scena con questa parte che voi mi date, terrò contrapunto al vostro canto, senza però darvi briga di andare al Regno dell’Ombre, poiché mi trovate in quello della luce (Manifesto, p. 25).
A Bonifacio, annientato dalla dialettica e dalla preparazione della superba signora, non resterà che passare dall’accusa di eresia a quella di plagio, denigrando l’originalità del lavoro di Sara. Ma per dirla con una splendida battuta del Manifesto: a che gioco giochiamo, signor vescovo?
Le Lettere di Ansaldo Cebà (Genova, 1623)
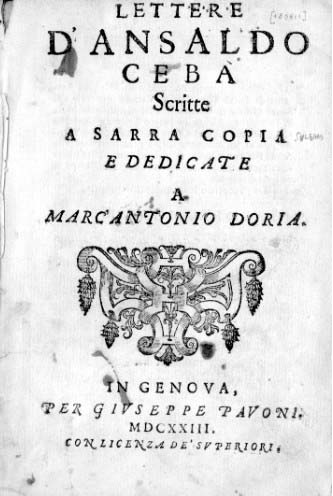
Frontespizio della collazione di lettere di Ansaldo Cebà a Sara Copio Sullam. Attraverso questa raccolta, sono giunti a noi alcuni sonetti autografi della poetessa
Con il letterato genovese Ansaldo Cebà, autore de La Reina Ester (Genova 1615), intrattiene un carteggio che dura per quattro anni (dal 19 maggio 1618 al 30 aprile 1622) di cui ci sono pervenute 53 missive – tutte di mano del Cebà e dallo stesso autore date alle stampe nel 1624. In queste missive sono riportati alcuni sonetti donati dalla poetessa all’amico. Dopo il Manifesto, gli scritti di Cebà sono la seconda fonte più importante per ricostruire il profilo, il carattere intellettuale e poetico, di Sara. Si tratta di un epistolario di stampo squisitamente letterario, che racconta la storia di un amore platonico, non privo però di accenti di autentica passione da parte dell’anziano erudito nei confronti della bella signora veneziana. Cebà è rapito dalle virtù spirituali, morali e fisiche di Sara che, secondo il canone dell’amore a distanza, conosce soltanto indirettamente – dalla sua fama, dai suoi scritti, dalle sue stesse lettere, dai doni che la giovane donna manda al suo lontano ammiratore.
Nella prima lettera dell’epistolario è contenuto un sonetto in cui Cebà ammette che, così come Ester aveva ispirato la sua opera drammatica, allo stesso modo la bella veneziana ispira ora il suo “fervore”. E, nella fantasia poetica, Sara viene assimilata, spiritualmente e fisicamente, all’eroina biblica:
Mosse l’antica Esther le voci ardenti,
Ond’io ritrassi in carte i suoi splendori:
Movi tu, nova Sarra, i miei fervori
A farti luminosa in fra le genti.
Nobil, cred’io, sei tu; tu rappresenti
De la Sposa d’Abram gli antichi honori;
E forse ancor col nome, i bei colori
De la sua guancia a gli occhi altrui rammenti.
Ma tu porti però su gli occhi un velo,
Che ravvisar ti toglie il gran Pianeta,
Onde il vero amor ferisce il telo.
Tu feconda di gratie hai l’alme elieta;
Ma non t’avvedi, oime, ch’errante zelo
Miseramente il passo al Ciel ti vieta.
Prende il via così lo scambio epistolare in cui la “bella Hebrea” non si sottrae alle appassionate profferte del suo corteggiatore. Anzi: Sara si mostra lusingata dalle attenzioni che le rivolge il colto intellettuale e solletica la passione che da lontano Ansaldo ha concepito per lei, anche in considerazione dell’impulso che Amore darà alla vena poetante e, di conseguenza, alla gloria poetica di Cebà: una gloria che mette a tacere la gloria stessa di Apollo. Così Sara risponde per le rime al suo interlocutore nel sonetto che lo stesso Cebà riporta nel volume delle Lettere:
La bella Hebrea, che con devoti accenti
Gratia impetrò da più sublimi chori,
Sì che fra stelle in ciel ne i sacri ardori,
Felice gode le superne menti:
Al suon, che l’alme da i maggior tormenti
Sottragge ANSALDO onde te stesso honori,
Spiegar sentendo i suoi più casti amori
I mondi tiene a le tue rime intenti.
Quindi l’immortal Dio, che nacque in Delo
A la tua gloria, la sua gloria acqueta,
Né la consumerà caldo, né gelo.
Colei ancor, che già ti fè Poeta
Reggendo questa, da l’empireo Cielo
Darà per sempre a i carmi tuoi la meta.
Ansaldo è ben consapevole che la differenza di età e la distanza impediscono una realizzazione fisica dell’amore:
Voi, per quanto intendo, siete giovane e bella, & io, per quel che vi può essere stato detto, non son ne l’uno ne l’altro (Lettera II, 10 giugno 1618).
Le vostre lettere nondimeno mi costringono a dimenticarmi delle mie sciagure; & a persuadermi ancora di non essere cosi del tutto da gittar a cani, poiché voi, che siete una giovane così leggiadra, havete sofferto di darmi il titolo di vostro Sole (Lettera XX, 15 febbraio 1620).
Ma quel desiderio che non potrà concretizzarsi trova un'altra forma di espressione. In una delle prime missive, mentre Cebà registra l’interessa della bella veneziana per la sua opera poetica, già si profila un tema che diverrà centrale nelle lettere di Ansaldo – l’ansia di convertire Sara alla fede cristiana:
Io v’amo, Signora Sarra, e vi riverisco quanto, e dalla mia, e dalla vostra legge, honorevolmente m’è conceduto: e, poiché voi non vi siete sdegnata di passionarvi dell’amore del mio Poema, voglio ancora, che vi contentiate, ch’io m’invaghisca del disiderio della vostra gratia; della quale io sono ambitioso, perché credo, c’habbite l’animo innamorato di cose grandi, e perché spero, che dobbiate anche un giorno raffinarlo nella fornace della charità Christiana. Così piaccia a Dio di darvene efficacemente la gratia (Lettera I, 19 maggio 1618).
Ansaldo è tutto dedito a lei, e Sara è perfetta in tutto; le manca soltanto la visione del vero Dio:
Ogni qualità mi piace in voi sommamente, fuori che l’esser Giudea (Lettera XXV, 9 maggio 1920)
Son sollecito all’amarvi; e farò anche pronto a servirvi, se da voi me ne sarà data occasione. Intanto prego Dio, che, con tant’altre gratie, che v’ha donate, vi metta anche per la strada, onde s’arriva a vederlo (Lettera V, 1 dicembre 1618).
La conversione di Sara diventa per Ansaldo una vera e propria missione che incombe sul suo animo:
Questa durezza, della quale, in tutto il rimanente dell’Hebraismo, la charità di Christo m’insegna ad haver compassione, nella persona vostra, Signora Sarra, confesso che mi passa l’anima: perch’io certamente v’amo, e vi stimo assai più che non posso esprimermi con le parole; e pesami fuor di modo, che voi, che vedete tanto dove, per virtù di modestia, vi pare di veder nulla, vediate così poco dove, per eccesso di confidenza, vi sembra d’haver gli occhi di Lince (Lettera II, 10 giugno 1618).
Soltanto l’abbraccio della fede cristiana, per altro, secondo Cebà potrà dare a Sara il passaporto per essere annoverata fra le più importanti “Dame d'Italia”:
Piaccia a Dio di stabilire gli occhi si efficacemente, ch’io vi vegga, prima che muoia, rinascere nel fonte del Sacro Battesimo, e risplendere nel numero delle maggiori Dame d’Italia (Lettera III, 23 giugno 1618).
Una missione, quella della conversione di Sara alla fede cristiana, che diventa, via via, una vera ossessione:
Tra le mie tribolationi, la vostra perseveranza nel giudaismo è una delle maggiori (Lettera XVII, 18 ottobre 1619).
Ma dalle lettere di Cebà intravvediamo quanto Sara sia tenace, ostinata contro le lusinghe di una conversione che, ormai, Cebà considera l’ordalia dell’amore:
Una Giudea cortesissima, e gratiosissima nelle parole, ma tanto schizzinosa, e dispettosa ne’ fatti, che mi fa disperare d’ottener da lei quel che maggiormente desidero. Ma di gratia non parlate con la persona mia si gratiosamente, e contro la vostra si pertinacemente. Voi mi date, ben m’avvegg’io, delle parole, per haver delle parole: & io ve n’ho dato, e ve ne darò più che non ne vorrete: ma, per amor di Dio, non mi negate ancora qualche fatto. Il più grande fatto che desideri da voi, è che vi facciate Christiana; al quale però perché non vi sento per hora disposta, la miglior parola, che possiate darmi, è di progar Dio, che vi ci disponga (Lettera XIX, 23 settembre 1619)
Da quanto le risponde Ansaldo, ricaviamo che Sara scrive che “si specchia conforme al consiglio di Platone”, Lettera X), laddove se si rimirasse “nello specchio, non di Platone, che non è senza macchia, ma in quello di Christo, che è limpidissimo, voi rimarreste innamorata di voi medesima” (Lettera IX). Sara insiste a “citare Aristotele in materia di fede” (Lettera XII), quando “Aristotele fu cieco – se havesse avuto notizia della fede Christiana, havrebbe sententiato con più ritegno” (Lettera XI). Pur avendo letto il Nuovo Testamento, Sara “non vuole riconoscere il nostro Salvator per vero figliuol di Dio” (Lettera II). Orgogliosa, Sara ribadisce “d’esser Hebrea, e non Gentile, & innalzata la dignità della sua legge” (Lettera XIV).
Cebà persiste nella sua ossessione, ma Sara impone che “le preghiere per la conversione” saranno rifiutate “salvo che siano reciproche” (Lettra XVI). Ed ecco che il gioco, nel segno della seduzione, si fa perverso e, per Cebà, rischioso:
Debbo io venire a Venetia per circoncidermi, o voi dovete venir a Genova per battezzarvi? (Lettera XXIV, 2 maggio 1620).
La climax del desiderio è al culmine e Ansaldo, accetta la sfida di una conversione incrociata, come succedaneo di un vero, impraticabile, erotismo:
Nuovo modo per certo di far l’amore è quello nostro, mentre noi ricerchiamo cose tanto diverse. Io vi vorrei Christiana, e voi mi vorreste Idolatra. Per amore di Dio, quel che volete far, fate presto; perché la mia vita minaccia rovina, e la vostra non è senza pericolo (Lettera XVI, 31 agosto 1619).
Ma rischia lui stesso di perdere la partita:
Hebrea fu la madre di Dio, che tengo in Cielo per avvocata; Hebrea era la Reina Esther, che presi per soggetto del mio Poema; Hebrea siete voi stella, c’ho fatta padrona delle mie voglie; onde, senza lasciar d’essere Christiano, voi potete con buona ragione giudicarmi Hebreissimo (Lettera XII, 11 maggio 1619).
Alla fine Ansaldo capirà che è la partita per lui è tutta in perdita e inizia a desistere, denunciando la sua incapacità a impersonare qualsiasi ruolo in un teatro in cui è Sara a dettare la sceneggiatura:
Per sostenere la persona d’amante, io sono vecchio, & infermo; per pratticar quella di padre, voi siete saggia, e prudente; e, per essercitar quella di servo, noi siamo divisi e lontani: per modo che, non potendo appellarmi con niuno di questi nomi, non so che cagione mi resti di fastidirvi con lettere (Lettera XII, 10 aprile 1620).
Per mia fè, Signora Sarra, che s’io non fossi Christiano, e canuto, mi fareste venir voglia di far la’more con voi da davero, tanto dolci son le parole, che mi venite scrivendo: ma la professione in fatti, e l’età mia m’ammoniscono di pensar ad altro (Lettera XXXVIII, 9 gennaio 1621).
Dall’epistolario di Cebà ricaviamo anche la preziosa notizia di un ritratto che Sara, fra gli altri doni, avrebbe fatto fare e inviare al suo corteggiatore. Nonostante un discutibile tentativo di identificazione, allo stato delle ricerche l’opera risulta purtroppo dispersa (Boccato 1986; Fortis 2003) ma del ritratto possediamo una ekphrasis che la stessa Sara compone nel sonetto di accompagnamento della sua raffigurazione (Lettera XXII, 18 aprile 1620):

Pubblichiamo l’oramai celebre “presunto ritratto di Sara Copio Sullam” che, a nostro avviso, non è la vera immagine della poetessa
Della Signora Sarra Copia
L’imago è quella di colei ch’al core
Porta l’imago tua sola scolpita
Che con la mano al seno al mondo addita
Qui porto l’Idol mio ciascun l’ardore.
Sostien con la sinistra arme d’amore
Che fur tuoi carmi, il loco ov’è ferita
La destra accenna, e pallida, e smarrita
Dice ANSALDO il mio cor per te si more.
Pregioniera se’n vien a te davante
Chiedendo aita, & a te porge quella
Catena ond’è’l mio amor fido, e costante.
Deh l’ombra accogli di tua fida Ancella
E goda almeno il finto mio sembiante
Quel che nega a quest’occhi iniqua stella.
Dalla descrizione di Sara ricaviamo questi elementi presenti nel suo “finto sembiante”: la donna è raffigurata con una mano al seno che insegna al mondo come racchiuda nel cuore l’“idolo del suo amore”; nella mano sinistra la figura impugna “arme d'amore che fur tuoi carmi”: si tratta evidentemente di un volume con componimenti poetici di Cebà; la mano destra che, come abbiamo visto più sopra, è posata sul cuore, mostra così il punto in cui Amore ha colpito. Ma l’attributo iconografico più importante è una catena che la donna porge come simbolo di un “amor fido e costante“ (proprio questo elemento, indicato in modo preciso e inequivoco, esclude l’identificazione con l’opera che è stata richiamata, sempre per altro con molte cautele, dalla critica come “ritratto di Sara” – opera in cui la catena è assente).
Nella stessa lettera, Ansaldo riporta anche la sua risposta per le rime al sonetto di Sara sul ritratto.
Felice Bella a l’infelice ardore,
Ch’a vedermi da presso il cor t’invita,
La tua da la mia vista ha dipartita,
E chiusa la mia notte al tuo splendore.
Tu sei de sgli anni tuoi sul più bel fiore,
Et hai la guancia ardente, e colorita;
Io sono sul terminare de la mia vita,
Et ho le fiamme dentro, e ‘l ghiaccio fuore.
Che, se pur luminosa, e sfavillante
La voce mia da lunge, e la favella
Ti sembra risonar per l’aria errante,
Tu sei la fiamma, o Sarra, e la facella,
Onde s’accende in me la lingua amante,
Mentre che solo il tuo bel nome appella.
Ansaldo considera un grande privilegio aver avuto il ritratto dell’amata, dato che – dice –“so benissimo, ch’ogn’altro, che facesse l’amore con voi da lontano, come fo io, non perderebbe si buona occasione di domandarvi la vostra immagine” (Lettera XVII). Rispetto alla ekphrasis di Sara, dai versi di Cebà non ricaviamo elementi ulteriori sul ritratto, se non la sottolineatura della bellezza della figura rappresentata: la donna e “sul più bel fiore” dei suoi anni, un colorito acceso rende “ardente” la sua guancia, in constrasto con l’algido pallore che Ansaldo ravvede nel proprio volto, a segnalare una volta di più la senilità che allontana la realizzazione del desiderio che pur dentro di lui arde (“et ho le fiamme dentro e il ghiaccio fuore”). Allo stesso ritratto fa per altro riferimento in un'altra lettera, dove ritorna la menzione della catena che però non corrisponde al significato del suo simbolo, dato che su Sara, che pure si era detta sua “fida Ancella”, Cebà non riesce a esercitare l’autorità che la catena prometterebbe;
Ma come stimolato dall’inchinatione, ch’io ho alla generosità dell’animo vostro, mi par di bramarla con tanta sete, che, se voi l’arrivaste a penetrare, per certo che vi sentireste stringere all’amor mio con più poderosa catena, di quella, che mi mostrate nel vostro ritratto; la quale con tutto ciò non nego io, che non sia per me honorevole, ma ben veggo, che mi dà poca autorità per disporre della persona vostra in quel che mi bisognerebbe haverla grandissima (Lettera XXI, 11 aprile 1620).
In realtà è Ansaldo si sente l’anima “tiranneggiata per si gratiosa Padrona” (Lettera XXVII), e alla fine resta soltanto l’ossessione di salvarla dell’“Hebraico errore” (Lettera XXIX) e di conquistare la sua anima alla fede cristiana. Si tratta di una vera e propria, dichiarata, trasfigurazione del corteggiamento erotico in corteggiamento religioso:
Prendiamo il tempo quando viene, Signora Sarra, e facciamo l’amor di proposito. [... Ma] dubito bene con tutto ciò, che’l Signor Giacob vostro marito non vegga troppo volentieri questo nostro traffico di lettere: non perché curi gli assalti di un amanete vecchio, ma perché tema gli assedj di un buon Christiano (Lettera XXXV, 10 ottobre 1620).
È una vera e propria “crociata” in cui Ansaldo chiede alla Donna che lo onori “di una croce” perché possa essere riconosciuto come “un cavaliero del vostr’ordine”, Lettera XXXII). Su quest'altro piano di seduzione, Cebà prova a sostenere con Sara che “anche Esther fu cristiana” (Lettera XXX); e intanto le suggerisce una facile via di fuga concettuale dato che non è “vitio” il suo perché non ha scelto di nascere ebrea:
Vitio non tengo io nella persona vostra, che siate nata Giudea; perché dove non è elettione, non può esser vitio: credo ben, che non habbiate scusa di non divenir Christiana (Lettera XXXIII 12 settembre 1620).
Insiste Ansaldo, sostenendo che “morire Giudea è come condannarsi a non vivere“ (Lettera XLV); produce per lei esempi da imitare e dona a Sara un suo nuovo lavoro in cui la protagonista è una principessa spagnola dalla grande forza spirituale (Lettera XLVI ).
Ma, dopo essersi augurato ripetutamente di avere “da Dio la grazia di sapere Sara convertita prima di morire” (Lettera XIL), persa ogni speranza anche su qesto fronte, alla fine Cebà desiste e così le scrive nell’ultima lettera:
Se non pensate di convertirvi, sospendete la vostra penna; perché, senza questa cagione, non penso d’adoperare la mia (Lettera LIII, 30 aprile 1622)-
Tenace, Sara, indeffettibile. Ma, a quanto pare più per superbo orgoglio, per altera dignità che per sentita fede. Non fede religiosa, ma fedeltà alla sua nascita, per questo Sara si ripromette:
Di voler la tomba dov’hebbe la cuna, cioè, che, com’era nata Hebrea, così voleva morir Hebrea (dalla “Formula di cortesia al lettore”, premessa alle Lettere).
Sara Copio nell’Accademia degli Incogniti (Venezia, 1631-1637)

Sull’impresa dell’Accademia degli Incogniti campeggia la scritta “ex ignoto notus” sotto il monte sconosciuto da dove ha origine il Nilo “che rende fecondo l’Egitto e mette molte foci nel Mediterraneo”.
Negli stessi anni in cui Sara è impegnata a gestire il suo salotto in casa Sullam al Ghetto, ed è coinvolta nell’epistolario con Cebà e nella disputa con Bonifacio, per iniziativa del giovanissimo mecenate Giovanni Francesco Loredan si costituisce a Venezia l’Accademia degli Incogniti, un circolo culturale tra i più attivi e vivaci del Seicento italiano. Loredan aveva studiato a Padova con il filosofo aristotelico Cesare Cremonini (1550-1631), che propugnava l’idea dell’eternità del cosmo e della mortalità dell’anima, contro l’idea – condivisa dalle diverse religioni monoteiste – della creazione ex nihilo e dell’immortalità dell’anima individuale: il tema del destino dell’anima (su cui Sara e Baldassare incrociano le armi dialettiche e teoretiche) era al centro del dibattito filosofico e culturale contemporaneo.
l’Accademia, formata da un gruppo di discepoli di Cremonini, si costituisce già alla fine degli anni '20, ma la sua attività riprende con nuovo impulso di rinascita nel 1631, dopo la fine della peste che aveva devastato l’Italia tra il 1629 e il 1630 e che aveva decimato anche la popolazione della Serenissima.
Dietro la maschera che gli Incogniti utilizzano per i loro incontri – ogni lunedì, a Palazzo Loredan a Santa Maria Formosa – si celano i volti degli esponenti delle famiglie patrizie di Venezia e di intellettuali provenienti da diverse città italiane ed europee – uomini e donne di qualsiasi ceto e credo. l’Accademia promuove dibattiti, esegesi di testi sacri e profani, discussioni filosofiche, ma anche la raccolta di manoscritti e pubblicazioni rare, ricercati presso biblioteche e vari stampatori in giro per l’Europa, nonché l’invenzione di nuovi generi musicali e teatrali (fra i quali il melodramma di Claudio Monteverdi). Ma, soprattutto, l’Accademia si dota di una casa editrice di riferimento in città – l’impresa di Giacomo Sarzina – che diventa il primo veicolo di diffusione di saggi filosofici, trattati, pamphlet, opere letterarie e libretti teatrali, pubblicati spesso in forma anonima, o meglio come opera collettiva degli “Ignoti”.
Nonostante molti accademici occupino posizioni nelle gerarchie della Chiesa di Roma, diversi aspetti delle loro attività intellettuali, come lo studio di testi cabalistici e dei vangeli apocrifi, la diffusione di una ideologia libertina e l’attuazione di pratiche come la libertà sessuale, la vicinanza alla filosofia aristotelica e il dibattito vivace contro l’immortalità dell’anima, li pongono in forte antitesi rispetto al pensiero cattolico.
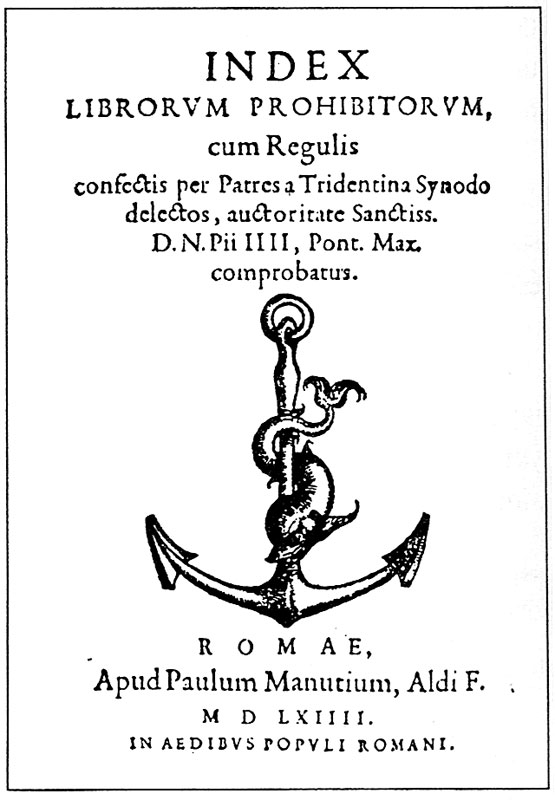
Licet ab initio. Frontespizio della bolla papale che rende noto l’elenco dei libri all’indice, qui nella versione a stampa del 1564 di Paolo Manuzio, figlio di Aldo
Tema ricorrente nei loro scritti è l’esaltazione della grandezza della Repubblica di Venezia, affiancato dall’intolleranza verso ogni forma di governo assoluto, compreso quello del Papa, e dal disprezzo per Roma vista come capitale della corruzione: al centro la fiducia nella nobiltà di spirito derivante non dalla genealogia, ma dalla nobiltà di cultura e la propaganda per una totale libertà di stampa (del 1542 è la bolla “Licet ab initio” con cui è istituita ufficialmente da Paolo III l’Inquisizione).
Dato il prestigio e il ruolo dei suoi promotori (Giovanni Francesco Loredan era senatore, “avogador de Comun”, capo del Consiglio dei Dieci, e Inquisitore di Stato per la Serenissima) gli Incogniti godono però di ampi margini di libertà di espressione. Nel clima di libertà e di superamento delle convenzioni etiche, sociali e religiose che gli Incogniti praticavano, il Loredan si fa anche difensore degli Ebrei in Gran Consiglio, sottolineando il vantaggio economico che procurano a Venezia le attività degli Ebrei, ma anche sotto un profilo più generale, sostiene che “per esser buon Cattolico Cristian, è necessario essere perfettamente Hebreo” (Adelman 2016, 312).
Fra i membri dell’Accademia, il monaco eretico Ferrante Pallavicino, autore del Divorzio celeste un libello feroce che inscenava il ripudio della Chiesa da parte di Cristo. Per il suo impegno letterario, Ferrante Pallavicino sarà condannato dal pontefice e decapitato ad Avignone nel 1644, a 29 anni. Le gerarchie della Chiesa di Roma non identificarono in Pallavicino l’autore dell’opera, ma la attribuirono a Giovanni Francesco Loredan, che del resto, in assenza dell’amico, aveva probabilmente curato la pubblicazione del libro. Così si legge in un passaggio del Divorzio a proposito della censura:
Diverse sono state sempre le cagioni per le quali Roma costumò di proibir i libri. Le più antiche erano il zelo della religione e il desiderio che la vita de’ cristiani si conservasse lontana da quella contaminazione che può recar l’insegnamento d’un autore malvagio; le più moderne sono l’avversione che si ha di sentir rimproverati li propri vizi e la tirannide con che si pretende che le altrui opinioni giamai dissentino dai voleri dei Grandi. Altra più rilevante urgenza di salute io non scorgo che abbia introdotto nella Cristianità tale costume, poiché, non essendo la lettura de’ libri proibiti se non una tentazione all’anima, io non ritrovo che Cristo abbia giamai proibite le tentazioni, ma bensì l’assenso a quelle; e se la carne e il Demonio giornalmente ci tentano, non è gran cosa che anche un libro possa tentarci. […] Si legge che Cristo ha illuminato i ciechi, ma non si legge che abbia accecato alcuno per condurlo in Paradiso, né giamai l’eterna salute fu additata all’uomo per la via della cecità.
Nel trentennio di attività dell’Accademia, che godrà sempre di un ampio raggio di azione grazie alla protezione delle più alte cariche veneziane, sono dati alle stampe molti testi sconvenienti, madrigali polifonici concepiti su armonie spesso dissonanti, spregiudicati nel soggetto e nello stile.

Frontespizio di Le glorie degli Incogniti di Giovanni Francesco Loredan che riporta, alla stregua di un registro, nomi e volti dei membri Incogniti al 1623
Un ambiente libero e all’avanguardia nel pensiero e nelle arti:
Punto di ritrovo per penne malediche, nobili irrequieti e chierici a disagio, il cui unico trait d’union era il naturalismo radicale che Cesare Cremonini (1550-1631), il principe degli aristotelici padovani, aveva inculcato loro sui banchi dello Studio, l’Accademia rifletteva ed esasperava le tendenze culturali in atto nella Serenissima: l’ambiguo rapporto con Roma da una parte, l’ansia di ricerca formale, e insomma un certo “avanguardismo” letterario, dall’altra. [...]. All’ombra del mecenatismo di Loredan crebbe così, a cavallo tra gli anni trenta e quaranta del secolo, un ginepraio di testi audaci, puntualmente messi all’Indice. Si trattava di opere concepite su spartiti polifonici, a voci plurime e talvolta dissonanti, montate per frammenti tra loro autonomi; l’obiettivo era la “maraviglia” del lettore, cui concorrevano, oltre alle bizzarrie dello stile, i soggetti scomodi e pruriginosi, e in particolare un erotismo a tinte forti, con più di un piede nella sfera del macabro (Metlica 2011, 5-6).
L’Accademia degli Incogniti, con la sua e intensa vita, è un bell’esperimento del clima di scambio e curiosità intellettuale che, in quel torno d’anni, era il cielo sopra Venezia e coinvolgeva gli spiriti più liberi: donne e uomini, credenti e materialisti, cristiani ed ebrei:
Questi scambi reciproci [...] evidenziano la profondità e la complessità dei rapporti che su estendevano anche fuori dal Ghetto. Quantomeno sulle questioni di natura intellettuale e culturale, più che vedere il Ghetto chiuso tra rigidi confini, va notata piuttosto una certa fluidità soprattutto nell’ambito destinato a reciproche interazioni e interessi condivisi. Non erano monolitiche né la Comunità ebraica né quella cristiana, e neppure si possono schematizzare le loro esperienze, tanto meno considerandole solamente in termini di oppressione degli Ebrei nel Ghetto. La storia dei Ghetti di Venezia e quella della popolazione veneziana e dei popoli d’Europa è fatta di scambi culturali. L’istituzione del Ghetto non fu un evento a sé stante, ma piuttosto una storia di connessioni, di reti e di relazioni (Adelman 2016, 313).
L’Accademia degli Incogniti vive nella Venezia degli anni '30 e '40 del XVII secolo, in una congiuntura storica, geografica, culturale e fisolofica, molto speciale. Tra i membri degli Incogniti: il fondatore Giovanni Francesco Loredan, autore degli Scherzi geniali e delle Novelle amorose; il filosofo Cesare Cremonini, che sulla sua lastra tombale, lasciando inciso su pietra il motto del suo materialismo, volle scritto HIC IACET TOTUS CREMONINUS; il rabbino Leon Modena, le cui prediche in sinagoga erano seguite da un pubblico internazionale e multiconfessionale; il duca Enrico di Rohan, leader dei protestanti francesi; Claudio Monteverdi; Baldassarre Bonifacio, l’accusatore di Sara sul tema dell’immortalità dell’anima; il genovese Ansaldo Cebà, autore de La Reina Esther e interlocutore di Sara nell’epistolario; Ferrante Pallavicino, vittima della ferocia dell’Inquisizione. E in questa ricca, complessa e intellettualmente coraggiosa rete di relazioni e di scambi, troviamo come una fiera protagonista anche la nostra “bella hebrea”, Sara Copio Sullam.
Bibliografia
- Adelman 1993
H.T. Adelman, Educational and Literary Activities of Jewish Women in Italy during the Renaissance and the Counter Reformation, Tel Aviv, 1993. - Adelman 1999
H.T. Adelman, The Literacy of Jewish Women in Early Modern Italy, in Barbara J. Whitehead (ed), Women’s Education in Early Modern Europe: A History, 1500–1800, New York 1999. - Adelman 2016
H.T. Adelman, Leon Modena, Sarra Copio Sullam and l’Accademia degli Incogniti, in Venezia, gli Ebrei, l’Europa. 1516-2016, a cura di D. Calabi, Venezia 2016, 310-313. - Boccato 1973
C. Boccato, Un episodio della vita di Sara Copio Sullam: il Manifesto sull’Immortalità dell’anima, “La rassegna mensile di Israel”, vol. 39, n. 11 (1973), 633-646. - Boccato 1974a
C. Boccato, Lettere di Ansaldo Cebà, genovese, a Sara Copio Sullam, poetessa del Ghetto di Venezia, “La rassegna mensile di Israel”, vol. 40, n.4 (1974), 169-191. - Boccato 1974b
C. Boccato, Un altro documento inedito su Sara Copio Sullam: il Codice di Giulia Soliga, “La rassegna mensile di Israel”, vol. 40, nn. 7-8 (1974), 303-316. - Boccato 1980
C. Boccato, Nuove testimonianze su Sara Copio Sullam, “La rassegna mensile di Israel”, vol. 46, nn. 9-10 (1980), 272-287. - Boccato 1986
C. Boccato, Il presunto ritratto di Sara Copio Sullam, “La rassegna mensile di Israel”, vol. 52, n. 1 (1986), 191-204. - Busetto 1981
G. Busetto, La leggenda erudita di Sara Copio Sullam, letterata del Ghetto di Venezia, in Il gran secolo di Angelico Aprosio, Ventimiglia 1981, 45-66. - Busetto 1983
G. Busetto, Sara Copio, in “Dizionario biografico degli Italiani”, vol. 28, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1983. - Carminati 2005
C. Carminati, Giovan Francesco Loredan, in “Dizionario biografico degli italiani”, vol. 65, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2005. - Cicogna 1864
A. Cicogna, Notizie intorno a Sara Copia Sulam coltissima ebrea veneziana del secolo XVII, “Memorie dell’I. R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti”, vol. 12, Venezia, 1864, 228–246. - Fonseca-Wollheim 2000
C. Fonseca-Wollheim, Faith and Fame in the Life and Works of the Venetian Jewish Poet Sara Copio Sullam, Ph.D dissertation, University of Cambridge, 2000. - Fortis 2003
Umberto Fortis, La “Bella Ebrea”. Sara Copio Sullam, poetessa nel Ghetto di Venezia del ’600, Torino, 2003. - Harrán 1996
Don Harrán, Doubly Tainted, Doubly Talented: The Jewish Poet Sara Copia (d. 1641) as a Heroic Singer, in Musica franca: Essays in Honor of Frank A. D’Accone, New York, eds. I. Alm et alii Stuyvesant 1996, 367–422. - Infelise 2014
Mario Infelise, Ferrante Pallavicino, in “Dizionario biografico degli Italiani”, vol. 80, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2014. - Langiano 2014
A. Langiano, Dal romanzo alla scena: G. F. Busenello e l’Accademia degli Incogniti, in La letteratura degli italiani 4. I letterati e la scena, Atti del XVI Congresso Nazionale Adi, Sassari-Alghero, 19-22 settembre 2012, a cura di G. Baldassarri, V. Di Iasio, P. Pecci, E. Pietrobon e F. Tomasi, Roma 2014, 1–13. - Leneman 1986
H. Leneman, The Venetian Ghetto of the 17th century ; its place in Jewish history, and one of its most unique products: Sara Coppio Sullam, Master thesis at Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion, Los Angeles, Edgar F. Magnin School of Graduate Studies, 1986. - Metlica 2011
Alessandro Metlica, Ferrante Pallavicino, Libelli antipapali: la Baccinata e il Divorzio celeste, in G. Baldassarri e C. Sensi, (a cura di), Manierismo e Barocco, Alessandria 2011. - Miato 1998
M. Miato, L’Accademia degli Incogniti di Giovan Francesco Loredan (1630-1661), Firenze 1998. - Poppi 1993
A. Poppi, Cremonini, Galilei, e gli inquisitori del Santo a Padova, Padova, 1993. - Schmitt 1984
C.B. Schmitt, Cesare Cremonini, in “Dizionario biografico degli Italiani”, vol. 30, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1984. - Spini 1985
G. Spini, Ricerca dei libertini. La teoria dell’impostura delle religioni nel Seicento italiano, Firenze, 1985. - Tiraboschi 1824
G. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, vol. XI, tomo VII, Milano 1824, 641-644. - Ultsch 2000
L. J. Ultsch, Sara Copio Sullam: A Jewish Woman of Letters in 17th-Century Venice, “Italian Culture” 18, 2000, 73–85. - Veltri 2009
G. Veltri, Body of conversion and immortality of the soul: Sara Copio Sullam, the beautiful Jewess, in Renaissance Philosophy in Jewish Garb: Jewish Thought and Philosophy on the Eve of Modernity, Leiden 2009. - Veltri 2016
G. Veltri, La filosofia ebraica nel Ghetto: Simone Luzzatto e Sara Copio Sullam, in in Venezia, gli Ebrei, l’Europa. 1516-2016, a cura di D. Calabi, Venezia 2016,306-309. - Westwater 2003
L.L. Westwater, Sara Copio Sullam: Life and Family and Sara Copio Sullam: Litterary Life and Works, in The Disquieting voice: Women's Writing and Antifeminism in Seventeenth Century Venice, Ph.D. dissertation, University of Chicago, 2003. - Zanon 2006
S. Zanon, Lo Spettacolo di Giacomo Torelli al Teatro Novissimo, Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Padova, 2006.
English abstract
Sara Copio Sullam, who defined herself “the beautiful Hebrea” (“the beautiful Jewess”), was an intellectual and poet who lived in the Ghetto Vecchio (“Old Ghetto”) in Venice, in 17th Century. Baldassare Bonifacio, Archbishop of Capodistria, accused her of not believing in the immortality of the soul: she replicated by writing a book (her only published one, Venice 1621) and openly addressing him in the dedication. This publication is a highly cultivated and brilliant pamphlet: Manifesto di Sarra Copia Silam Hebrea. Nel quale è da lei riprovata, e detestata l’opinione negante l’immortalità dell’Anima, falsamente attribuitale dal Sig. Baldassare Bonifaccio.
Ansaldo Cebà, a Genoese intellectual, author of La Reina Esther, exchanges letters with Sara in which he professes his “platonic” long-distance chivalrous love to the brilliant Venetian lady; but soon, his worry of conquering the soul of the young intellectual woman prevails on his erotic desire, in order to convert her from the “Hebraico errore” to the Christian faith. Cebà exchanged fifty-three letters with Sara (Lettere di Ansaldo Cebà, published in Genoa in 1623); all Sara's letters have gone lost, but Cebà transcribes some of the poetess’ sonnets in his volume.
Sara, as Bonifacio himself, was member of the “Accademia degli Incogniti” (“Academy of the Unknown2), a Venice-based libertine group of people gathered together by Giovanni Francesco Loredan. This paper focuses on the intellectual, philosophical and poetic profile of Sara Copio Sullam, in relation with the Venetian cultural scene of the early 17th Century.
keywords | Venice; Venetian Jewish community; Ghetto; Sara Copio Sullam; Poetry; Baldassare Bonifacio; Ansaldo Cebà; Academy of the Unknown.
Testi di e su Sara Copio Sullam in questo stesso numero di Engramma:
§ prima edizione on line del Manifesto di Sarra Copia Sulam Hebrea (vedi in rete la riproduzione digitale dell’edizione Venezia 1621)
§ Il Codice di Giulia Solinga (BMCVe, ms Cicogna 270). Il processo in Parnaso in difesa di Sara Copio Sullam
Per citare questo articolo: Monica Centanni, Anna Ghiraldini, Sara Copio Sullam a dialogo con gli intellettuali del suo tempo. Baldassare Bonifacio, Ansaldo Cebà e l’Accademia degli Incogniti, “La Rivista di Engramma” n. 136, giugno/luglio 2016, pp. 189-217. | PDF dell’articolo