1. Tecnofilm e Grande Trasformazione

Fotogrammi dal film-documentario Le vie del petrolio di Bernardo Bertolucci, 1967.
All’inizio degli anni Cinquanta nascono le sezioni foto-cinematografiche di molte aziende italiane. In un momento di grande sviluppo dell’economia nazionale, e ancor prima della nascita della televisione pubblica, il cinema consente originali forme di comunicazione aziendale, capaci di raggiungere spettatori molto diversificati. L’intenzione di sostenere politiche promozionali al passo coi tempi definisce una pluralità di prodotti filmici, per i quali non sempre è evidente l’obiettivo. Il problema statutario del film industriale investe infatti una molteplicità di possibili fruitori, sui quali tarare documentari stilisticamente differenti: dalle maestranze interne alla fabbrica (film tecnico-professionali), al pubblico di sala (film di divulgazione o di prestigio) sino ai possibili acquirenti dei beni prodotti (film pubblicitari o promozionali). Molti industriali comprendono la valenza comunicativa del cinema ma forti rimangono paure e pregiudizi: negli anni Cinquanta il film industriale viene ancora gestito dai vertici aziendali, scavalcando spesso i neonati settori comunicazione e marketing (anche perché il film è considerato una ‘porta sull’arte’, in grado di solleticare ambizioni e indurre controlli diretti).
Si tratta di film che, in quegli anni, arricchiscono una produzione documentaria quantitativamente rilevante ma, aldilà di precisi casi autoriali, di forte omogeneizzazione stilistica e stringente controllo istituzionale. Dal 1947-48, e sino al 1951, la più potente strategia comunicativa attiva in Italia è messa a punto dal Piano Marshall. I film prodotti dallo European Recovery Program (ERP) investono il nostro paese quale principale teatro europeo di propaganda (Ellwood 1996). Attraverso l’evidenza della visione documentaria, il fiume di aiuti americani cerca di promuovere una non ingenua iniezione di fiducia. Invertire le ataviche deprivazioni di un popolo stremato, fecondare nuove mentalità, innalzare il livello di speranza e, in prospettiva, garantire la tenuta dell’Italia quale paese del blocco Nato sono gli obiettivi di una intensa campagna propagandistica [1]. I documentari costituiscono la parte più ambiziosa del progetto anche perché, secondo gli strateghi dell’informazione americana, investono una naturale predisposizione del popolo italiano allo spettacolo cinematografico. L’idea è che in un paese con larghe sacche di analfabetismo solo le immagini animate riescano a garantire efficacia e persuasività necessarie alla grancassa del Piano per pubblicizzare i propri aiuti e diffondere un determinato modello di rinascita.
Come in Un pezzo di carbone (Giuliano Tomei, 1949), dove l’aiuto americano è espresso in maniera diretta, senza parabole, elencando cifre, mostrando utilizzi ed evidenziando carbonifere necessità per la ripresa dei processi produttivi nazionali. Fra l’incipit – una lezione sul carbone in una scuola americana – e l’epilogo – davanti a una stufetta, con un bambino curioso che chiede al nonno filoamericano ‘cos’è l’America?’, stanno immagini di chiara propaganda in cui processi estrattivi, spostamenti transatlantici, stoccaggi portuali ritmano una titanica epopea del benevolo aiuto. Anche in Paese senz’acqua (Giuliano Tomei, 1950 ca.), è solo grazie al piano Marshall che un paese circondato da desolate pietraie, e sino allora servito da una botticella a calesse, viene ricondotto a nuova vita: il fondo Lire ERP consente finalmente la posa dell’acquedotto, per portare nutrimento alla nuova fontana. Ecco la banda in piazza: una carrellata verso la fontana segue un bimbo correre verso l’acqua, sino a schizzare gli astanti. Con un repentino controcampo, il suo volto in primo piano illumina un gioioso happy end.
Nel 1951, mentre il piano Marshall entra nel suo quarto anno di vita e si appresta a lasciare all’Italia convalescente la propria completa guarigione, Alcide De Gasperi avvia il Centro documentazione della Presidenza del Consiglio. Un ex funzionario del Minculpop, Silvano Spinetti, viene chiamato a dirigere questa fondamentale struttura governativa dell’informazione. Oltre al sostegno ideologico, all’appoggio franco e leale de La Settimana Incom di Sandro Pallavicini, il governo sente cioè la necessità di comunicare direttamente con i cittadini attraverso una propria struttura organizzativa. La Presidenza del Consiglio investe importanti risorse promozionali nell’illustrare, fra l’altro, i successi della legge Fanfani (il cosiddetto Piano Ina-Casa): o, grazie al ‘Treno della rinascita’, le principali questioni inerenti la ricostruzione; o, ancora, la nuova collocazione internazionale del Paese, in film come Italia d’oggi (1951 ca.), Meglio di ieri (1952), L’Italia e il mondo (1953), tutti di Romolo Marcellini; o Come ci vede il mondo (Remigio del Grosso, 1952) e Made in Italy (Raimondo Musu, 1953) nei quali risulta evidente lo sforzo governativo di riflettere sulle specificità nazionali per diffondere l’idea di una nazione retta da istituzioni credibili, capaci di garantire quei passi necessari a tramutare in azioni concrete le grandi speranze per il futuro. Un buon esempio, prodotto proprio dal redivivo Luce, è Nuova vita sul mare (Francesco De Feo, 1952), panegirico della rinata marina mercantile italiana, attraverso l’operosità dei suoi cantieri e dei porti di Genova, Castellamare, Monfalcone, Palermo. Una scanzonata colonna sonora accompagna la descrizione delle mirabilie marittime e dei suoi protagonisti, ora formati in scuole professionali all’avanguardia: l’allestimento dell’Andrea Doria, consente di paragonare il comfort della vita di bordo a quello dei modelli dell’anteguerra, quali il mitico Rex e il Saturnia e di esaltarne i “Luminosi ed eleganti [...] ambienti di III classe. I sudici e deprimenti stanzoni stracolmi di emigranti non sono ormai che un ricordo del passato”.
Ma le grandi dinamizzatrici del documentario italiano del dopoguerra sono la legge del 1945 (che riserva al documentario il 3% dell’introito lordo degli spettacoli), e quella del 1949 (che aggiunge un ulteriore 2% ai cortometraggi di “eccezionale valore tecnico e culturale”). Si tratta di interventi legislativi che, se da un lato cercano di rilanciare il genere documentario, dall’altro garantiscono lauti guadagni ai produttori di cine-attualità e di cortometraggi. In termini produttivi il meccanismo funziona: solo nel 1955 vengono prodotti 1132 film cortometraggi, quasi tutti documentari. È qui che si consolida l’associazione automatica fra formato breve e film documentario, una semplificazione che segna ancora gli immaginari spettatoriali nazionali. Ma il sistema penalizza fortemente autori e produttori indipendenti e pochissime case di produzione – Astra, Corona, Documento Film, Edelweiss, Incom – si assicurano quasi l’ottanta per cento dei contributi statali. Lo ‘stile documentario’ si irrigidisce attraverso una voce narrante onnipresente – in qualche modo certa di un’unica, figurabile, realtà – con preziosità lessicali che risentono ancora di modelli letterari e colonne sonore spesso composte senza aver visto le immagini. Anche perché l’energia produttiva è spesa piuttosto per “oliare le commissioni ministeriali”, e avere la certezza dell’abbinamento con un film di successo o la garanzia del premio di qualità. Uno scandalo dominato da una sola logica, quella mercantile, sul quale interviene l’onorevole Emilio Sereni in un discorso pronunciato al Senato della Repubblica il 25 maggio 1949:
Bisogna notare, a questo proposito, la bassissima qualità tecnica ed artistica di buona parte della produzione nostra di documentari. Questo stato di cose è conseguenza del fatto che i noleggiatori americani e italiani acquistano spesso da privati produttori, a cifre bassissime, i documentari realizzati da questi ultimi, in condizioni di eccessiva economia, rilevando in pari tempo il diritto ai contributi di stato. I noleggiatori abbinano poi tali documentari a film di altro rendimento e riscuotono quindi dallo stato altissimi contributi (Sereni [1949] 1974).
2. L’età d’oro del Tecnofilm
Anche il film industriale risente di questo clima: spesso si tratta di opere guidate da un intento dichiaratamente didattico e semplificate strutture narrative. Come i documentari prodotti dalla Montecatini fra il 1952 e il 1959, una quindicina all’anno, in una sezione cinematografica molto attiva che
costituisce la punta di diamante della Pubbliche relazioni dell’impresa. Lo si deduce dalla quantità di personale stabilmente impiegato e di attrezzature tecniche acquistate, anche se il merito principale dell’iniziative è da attribuire ad un propagandista tecnico, Giovanni Cecchinato, alla Montecatini dal ’48 (Mosconi 1991, 69).
Anche la Carlo Erba organizza un proprio settore di produzione documentaria nel 1953 e lo affida al medico Mario Scolari. Dopo una difficile fase pionieristica, sia per il dilettantismo degli operatori che per effettive difficoltà pratiche nel filmare tecniche di laboratorio e operazioni chirurgiche, la produzione si specializza grazie all’aiuto di collaboratori esterni. Naturalmente, dopo una serie di esperienze ormai decennali, anche la Fiat organizza un proprio centro di produzione ufficiale. E, nel 1952, nasce CineFiat, con operatori dedicati e percorsi produttivi molteplici, consentiti dall’ampia gamma di prodotti immessi sul mercato nazionale e internazionale (Castronovo, Ceri, Rondolino, 1988).
Il genere è ormai avviato, la necessità condivisa, e le aziende che utilizzano il documentario si moltiplicano: l’Ilva, la Prealpina, la Sclavo, la Farmitalia… La strada al documentario industriale è aperta e dal 1957 – con il “Festival del documentario industriale e artigiano” di Monza – è un moltiplicarsi di possibilità mostrative, in festival, rassegne, convegni dedicati al ‘tecnofilm’. Il fervore dei primi anni è senza pari: l’ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini) fiuta l’affare e si propone “di dare il suo contributo per la creazione di adatti circuiti per la diffusione dei film industriali sia in Italia che all’estero”. Nel 1961, in occasione del II Festival Internazionale del Film Industriale di Torino, pubblica Il cinema al servizio dell’industria, una composita riflessione sul ‘tecnofilm’, nella quale compare anche un tentativo di classificazione in sette generi diversi.
In un panorama quanto mai dinamico i documentari prodotti da Adriano Olivetti esprimono al meglio la carica di rinnovamento di quegli anni. Per Olivetti si tratta di una naturale conseguenza della sua molteplice attività: industriale illuminato, fautore di una diffusione del moderno attraverso le arti e il design, consapevole promotore di piani urbanistico-territoriali in grado di governare le spinte propulsive della rinascita edilizia, si batte per una crescita dell’individuo e della comunità che non sia soltanto economica ma, soprattutto, etica e morale. “Senza una visione di questa necessità storica, niente di permanente, di stabile, di soddisfacente, potrebbe essere introdotto” (Olivetti 1957, 3). Nelle sue fabbriche si riduce l’orario di lavoro e si costruiscono quartieri per i dipendenti, con servizi sociali, biblioteche, mense, chiamando il fior fiore dei progettisti italiani – dallo studio Figini e Pollini a Ignazio Gardella, da Marco Zanuso a Luigi Cosenza. I prodotti della Olivetti vengono firmati da grandi designer del Novecento, come Marcello Nizzoli e Ettore Sottsass. Una consapevolezza estetica che coinvolge il cinema e lo inserisce in un più vasto progetto sociale: alcuni fra i migliori documentaristi italiani – Virgilio Sabel, Giorgio Ferroni, Michele Gandin, Nelo Risi – firmano per Olivetti opere che valicano lo scopo promozionale del film industriale per affermare una rinnovata consapevolezza dell’uomo. L’auspicio è che la fabbrica diventi “cellula operante rivolta alla giustizia di ognuno, sollecita al bene delle famiglie, pensosa dell’avvenire dei figli e partecipe infine della vita stessa del luogo” (Olivetti 2001, 100). Ed è in film come Una fabbrica e il suo ambiente (Michele Gandin, 1957) o Sud come Nord (Nelo Risi, 1957) che il paradigma olivettiano si esprime pienamente, coinvolgendo il documentario in una politica d’immagine coerente e articolata.
Nel film di Gandin, la voice over auspica che “i lavoratori non ricavino dalla fabbrica soltanto il salario o prestazioni di carattere assistenziale ma assimilino e diffondano un culto, un modo, un’esigenza di vita”. Una idea che si espande in Sud come Nord, negli stabilimenti di Pozzuoli, dove si cerca di convivere con le forme della tradizione: è qui che un dipendente ‘tipico’ diviene il personaggio principale, colui che, insieme alla famiglia e all’interno della comunità, può godere dei servizi offerti dalla buona organizzazione aziendale. Fra le aziende più citate in merito al ‘tecnofilm’, anche la Edisonvolta è fortemente impegnata a pubblicizzare le grandi opere necessarie a incrementare la produzione energetica del paese.
Fra il 1954 e il 1959, la troupe di dipendenti che affianca Ermanno Olmi nel Servizio cinematografico realizza circa cinquanta documentari, alcuni di pregevole fattura. In bilico fra sicumere industrialiste e ammirazione per le forze della natura, le opere di Olmi cercano di lasciare spazio alla processualità del lavoro, a un’umanità sconosciuta, alla feconda operosità di una industria ‘buona’. Ad esempio, Tre fili fino a Milano (1958) consente a Olmi di sperimentare una narrazione dove la voce narrante si acquieta per evidenziare una drammaturgia epica, legata all’elevazione dei tralicci, agli operai in bilico sui cavi d’acciaio, alla messa in tensione dei fili che porteranno luce sino a Milano. Proprio come sperimentato in Manon finestra 2 (1956), l’osservazione delle attività costruttive rende protagonista un’umanità sconosciuta, operai e valligiani compartecipi dei cambiamenti territoriali legati alla realizzazione di dighe e centrali idroelettriche. L’alternanza fra silenzi della natura ed esplosioni della dinamite, buio delle gallerie e luce del sole sui campi costituisce la vera partitura ritmica di Manon, un film ammirato anche da Roberto Rossellini (Mazzei 2000, 282-288; Bruni 2003, 119-131). Eppure, queste opere non tardano a celare le mitologie di un industrialismo che, nel volgere di pochi anni, porterà l’Italia al boom, consegnandola, congiuntamente, a una serie di ferite antropiche e ambientali ancora aperte. Ne Il racconto dello Stura (1955) il commento ricorda come il protagonista della storia sia “il fiume piegato alla volontà degli uomini” o come la diga diventi strumento per “trasformare il corso disordinato del fiume”. La natura indugia, la natura è da piegare: ma, paradossalmente, la metafora naturalistica viene reintrodotta per illustrare le meraviglie dell’ingegno umano. Ecco allora “carrelli elevatori come ragni pazienti”, oppure visioni di geometrie in calcestruzzo specchiarsi in un incontaminato laghetto alpino.
L’atteggiamento modernista è senza scampo: Venezia città moderna, sempre di Olmi (1957), illustra “l’atmosfera desolata delle lagune” prima dell’arrivo delle ciminiere di Marghera ed esalta le “terre strappate all’inutile indugio del mare”. Lode alla chimica dei fertilizzanti, magnificenza della plastica materia dell’uomo moderno, rassicuranti kitsch veneziani per gli operai: sul televisore nuovo di zecca sta una gondola in plastica con tanto di gondoliere, mentre il commento ricorda come gli abitanti della Venezia moderna non scordino la loro città antica. D’altronde, l’incipit del film parte proprio da Piazza San Marco, dal cui campanile uno stacco di montaggio introduce le ciminiere degli stabilimenti nei quali prodigiosa si attua l’opera dell’uomo: sino a un “arrivederci a Venezia, città antica, città moderna”, consolante saluto finale. Una visione fortemente industrialista dalla quale Olmi stesso, in anni recenti, cercherà di staccarsi, collocandola nel roboante desiderio di modernità che permeava la società italiana dell’epoca (Ciacci 2004, 47-48). Dunque il cinema industriale è attratto dal nuovo, dallo sviluppo, dal futuro ma vistosi occultamenti si riscontrano sin da subito. Per la tragedia mineraria di Marcinelle, in Belgio, dove muoiono 262 minatori, di cui 139 italiani, la Rai monta pochi minuti per il telegiornale. Siamo nell’agosto del 1956: la dozzina di bobine in 16 mm girate dal regista Massimo Sani, coi volti dei minatori coperti di nerofumo e la pelle bruciata, le interviste ai parenti accalcati sui cancelli, i cadaveri delle vittime fuori dai pozzi finiscono nel cestino delle sequenze perdute: “‘ma che Sani, non lo sai che quello che viene buttato nel cesto non lo vede più nessuno?’ Questa era la prassi in Rai. E mi venne detto anche che la Rai aveva un contratto con qualche ditta che recuperava l’argento della pellicola impressionata [...] Ecco, più disperato di così non potevo essere” (Sani 2006, 3). Anni in cui la CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio), appena costituita, facilita la partenza di decine di migliaia di operai per trovare lavoro nelle fabbriche e nelle miniere di Germania, Francia, Belgio: che le immagini di quella tragedia fossero troppo forti nel momento in cui la manodopera italiana stava invadendo i paesi vicini per contribuire alla Grande Trasformazione?
3. L’Eni e il caso de L’Italia non è un paese povero

Fotogrammi dal film L’Italia non è un paese povero di Joris Ivens, 1960.
In sintonia con altre grandi aziende italiane, anche l’Eni diventa produttore di film industriali. Fra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, dopo avere già promosso Le vie del metano (Ubaldo Magnaghi, 1952), l’azienda produce opere come Gela 1959: pozzi a mare (Vittorio De Seta e Franco Dodi, 1960), Il gigante di Ravenna e A Gela qualcosa di nuovo (Fernando Cerchio, 1960), Ritratto di una grande impresa (Giacomo Vaccari, 1962), Oro sul Mar Rosso, (Vittorio Gallo, 1962). Soprattutto, l’ente intraprende un progetto fortemente voluto dal suo presidente, Enrico Mattei, che avverte l’esigenza di volgere i ‘tecnofilm’ – in cui dominano aspetti tecnici, didattici e divulgativi – in film documentari per il grande pubblico. Per cambiare gli immaginari internazionali, legati a un’Italia vista essenzialmente quale paese agricolo e di rovine, servono grandi autori e Mattei si rivolge al celebre documentarista Joris Ivens. Le vicende del suo L’Italia non è un paese povero (1960), mai trasmesso nella versione integrale per la censura della RAI, come i successivi film di Gilbert Bovay (girati in Africa e in vicino oriente e segnati dal clima della decolonizzazione) e un film di prestigio come Le vie del petrolio (1966), di Bernardo Bertolucci, brillano oggi quali testimonianze di una gloriosa stagione del cinema d’impresa. Lavori in cui l’aspetto umano, le vite dei protagonisti, i rapporti fra la nostra cultura e quelle dei paesi produttori vengono osservati problematicamente. Film che, aldilà degli aspetti industriali, costituiscono un corpus di enorme interesse cinematografico e socio-culturale: specchio di politiche aziendali che, attraverso il cinema, non puntano solo all’autopromozione ma al più vasto racconto di un paese in rapida crescita (Frescani, 2014; Latini, 2011).
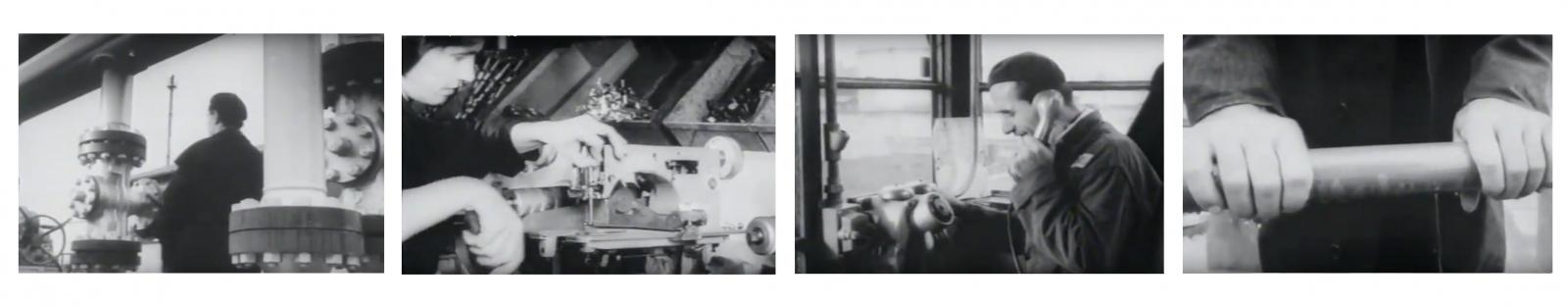
Fotogrammi dal film L’Italia non è un paese povero di Joris Ivens, 1960.
Nelle intenzioni di Mattei, L’Italia non è un paese povero dovrebbe sfatare il mito di un Paese arretrato, per promuoverne una visione moderna, anche grazie ai benefici della ricerca di idrocarburi. Mattei ha al suo servizio uno staff di intellettuali che lo indirizza verso un maestro del documentario come Ivens, per realizzare un’opera in cui “la celebrazione delle glorie aziendali e italiane fosse efficace senza scadere nella propaganda” (Perrone 2001, 63). Ma Mattei non è un industriale attento solo alle sorti del suo paese. La sua visione politica lo porta ad avere un ruolo fondamentale sulla scacchiera internazionale. La ridefinizione del sistema di sfruttamento petrolifero dei paesi del ‘terzo mondo’ significa aiutare i paesi produttori a intraprendere un percorso di progressiva autonomia, sia nella formazione di quadri tecnici locali che, in prospettiva, nella liberazione dalla sudditanza a un certo capitalismo imperialista. Ne esce un film faro della storia del documentario, concepito per la TV con tecniche innovative per l’Italia di quegli anni, come l’utilizzo della camera a mano e una diversa modulazione della velocità della pellicola. Al film lavorano intellettuali come Alberto Moravia e Corrado Sofia (al commento, letto da Enrico Maria Salerno) e i giovanissimi Tinto Brass, aiuto regista, Valentino Orsini e Paolo e Vittorio Taviani, sceneggiatori. Il documentario illustra la distribuzione del metano nella valle del Po, la storia di due alberi (un antico olivo e un tecnologico ‘albero di Natale’, l’attrezzatura che controlla l’imboccatura dei pozzi di petrolio), il matrimonio tra una ragazza siciliana e un uomo del nord Italia che lavora su una piattaforma off-shore. Ivens, un poeta del cinema militante sin dal film sul Borinage (Misère au Borinage, con Henri Storck, 1933) gira, fra l’altro, scene nei sassi di Matera dove si vedono bambini con le mosche sugli occhi, in una casa-grotta adibita a stalla.

Fotogrammi dal film L’Italia non è un paese povero di Joris Ivens, 1960.
E per questo la Rai si rifiuta di mandare in onda il film nella versione integrale: l’opera viene giudicata troppo cruda, e sottoposta a tagli di numerose sequenze. In particolare, devono essere eliminati: 1) i ‘Sassi’ di Matera: una donna – che parla in dialetto lucano – invita a entrare, mostra l’interno della sua grotta e illustra le misere condizioni di vita della sua famiglia; racconta di aver avuto quindici figli, di cui dieci morti, gli altri lì presenti; 2) fattura di una maga a un ammalato; 3) primo piano di un lattante abbandonato, l’‘ultimo nato’, disteso su una specie di amaca, infagottato di stracci, il viso coperto di mosche; 4) altre immagini di bambini tristi e miseri. Lo speaker commenta: “Eppure in questa rovina vive qualcuno”; 5) un’anziana coppia di contadini fa entrare l’asino nella stalla, che è anche la loro abitazione (Baldi 2003, 57-58). A nulla valgono le proteste di Ivens e i suoi reiterati appelli a Mattei che, nel frattempo, per ragioni di opportunità politica, abbandona il film al suo destino (Tosi 2002).
Sembra di rivivere l’epopea di pochi anni prima, dove un altro film ambientato a Matera subisce analoghe censure – anche se il finale risulta ben diverso – al fine di tutelare una presunta immagine pubblica nazionale. Il soggetto di Matera (1951), un’inchiesta documentaria diretta da Romolo Marcellini, parla chiaro: “Matera: la città vecchia ricavata in caverna ove si conduce una vita semiprimitiva e, per contrasto, le nuove costruzioni in collina inquadrate nel piano di risanamento delle zone depresse” [2]. La commissione di censura concede il nulla osta per l’Italia. Ma per l’estero, vista la richiesta di esportazione in Inghilterra, impone che siano “eliminate le scene in cui appaiono animali addetti ai lavori agricoli convivere nelle case degli abitanti in quanto esse possono suscitare errati e dannosi apprezzamenti sul nostro Paese”. I Sassi sono un problema scandaloso, un ‘habitat trogloditico’ ai margini della storia: l’Italia in corsa verso lo sviluppo se ne vergogna. La Documento film, produttore esecutivo per il Piano Marshall, ricorre in appello il 7 febbraio 1951. Qualche giorno prima, lo Information Division del Piano aveva scritto una lettera a Nicola De Pirro, Direttore Generale dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio, nel quale rivendicava proprio la fondamentale importanza visiva delle scene che gli organi di censura volevano eliminare.
Per gli americani la dialettica fra l’Italia del passato e quella del futuro necessita delle sequenze sgradite ai censori – “Le faccio notare che tutto il documentario è imperniato su questo contrasto”, scriveva Frank Gervasi, Chief Information Division – e il 20 giugno 1951 la commissione si convince ad esprimere “parere favorevole per la proiezione in pubblico”. L’imposizione americana riesce dunque a sgretolare le intenzioni della censura nazionale: ciò che, una decina di anni dopo, non riesce (o non interessa?) a Mattei per lo sfortunato film di Ivens. Così, dopo molte trattative, il documentario viene messo in onda in tre puntate, presentato come Frammenti di un film di Joris Ivens: ormai è un film a pezzi, amputato di circa mezz’ora rispetto al montaggio originale [3]. Le ‘colpe’ dell’autore? Non avere realizzato un ‘vero’ film industriale? Avere introdotto indesiderati sguardi antropologici? O forse, semplicemente, avere anticipato una tendenza che segnerà il ‘tecnofilm’ dopo il periodo aureo degli anni Cinquanta e Sessanta [4]? Negli ultimi anni il film di Ivens è divenuto un oggetto simbolico, carico di evocazioni: da un lato attraverso l’importante lavoro di Stefano Missio Quando l’Italia non era un paese povero (1997), in cui il regista cerca di ricostruire il clima che portò alla censura del film attraverso interviste ai sopravvissuti protagonisti di allora; dall’altro attraverso il remake di Daniele Vicari, Il mio paese (2006), in cui l’autore intraprende un viaggio di scoperta, sui passi del film del 1960, nell’Italia contemporanea.
Ma il film di Ivens costituisce anche il momento di massima implosione dell’immagine dei Sassi, prima del lento processo di rinascita, di un riscatto epocale avvenuto anche grazie al cinema, con opere di finzione quali Il vangelo secondo Matteo (1964) di Pier Paolo Pasolini. Per cui, probabilmente, la dimensione meno diretta e più ‘protetta’ della finzione narrativa – dunque l’esigenza pasoliniana di non attestarsi sull’evidenza documentale della contemporaneità – contribuisce ad accettare lo sguardo innanzi a quell’habitat vergognoso, nella lenta ricomposizione di una nuova dimensione epica del mondo. Poco a poco, attraverso una serie di opere ambientate a Matera, il cinema distilla immagini mutanti della città. Grazie a film come Allonsanfan (Paolo e Vittorio Taviani, 1974), Cristo si è fermato a Eboli (1979) e Tre fratelli (1981, entrambi di Francesco Rosi), L’uomo delle stelle (Giuseppe Tornatore, 1995), La passione di Cristo (The Passion of the Christ, Mel Gibson, 2004), Veloce come il vento (Matteo Rovere, 2016), Ben-Hur (Timur Bekmambetov, 2016), un redenzione non banale, capace di toccare la riflessione sui modelli di sviluppo che accompagnarono gli anni della rinascita post-bellica italiana, accompagna la mutante immagine della città, sino alla sua proclamazione di Capitale europea della cultura del 2019.
3. Dopo Mattei, da Bovay a Bertolucci

Fotogrammi dal film Oduroh di Gilbert Bovay, 1964.
Dopo la morte di Mattei l’attenzione per il cinema dell’Eni continua con impegno crescente, attraverso opere di autori come Giuseppe Ferrara (Gela antica e nuova, 1964), Valentino Orsini (Chilometri 1696, 1966; Firenze: una tradizione che continua, 1968; Eni, vent’anni, 1973; Icam 300 giorni, 1986), Gillo Pontecorvo (Una storia per l’energia e Una società congolese che parla italiano, 1984) e, soprattutto, Gilbert Bovay (Oduroh, 1964, Gli uomini del petrolio, 1965 e la trilogia Africa, nascita di un continente, 1968). In Oduroh le grandi sfide della modernità e della industrializzazione sono poste in una prospettiva in cui l’esperienza del magico, del comunitario e del politico scandiscono orizzonti capaci di valicare il problema energetico. Non è un caso se il film viene proposto alla Commissione internazionale svizzera per l’UNESCO come candidato al Prix Kalinga 1964, il cui regolamento prevede che “le sujet du film doit être une réalisation exceptionelle dans le domaine de l’éducation, de la science ou de la culture, obtenue grâce à la cooperation internationale” (Latini 2016, 123).
Il film di Bovay sembra fuoriuscire dal genere del film industriale: la camera a mano che segue Oduroh per le strade di Milano, il tono della voce narrante a Firenze “Queste pietre gli parlano di uomini grandi, belli, muscolosi, che poi non ha mai incontrato per la strada, c’è forse una menzogna in tutto questo?” – le immagini del protagonista felice al suo rientro in Ghana, gli idoli politici rappresentati da Cassius Clay e Malcolm X: tutto rinvia a un cinema politico e alle legittime rivendicazioni del continente africano:
Outre du talent de Gilbert Bovay, ces films témoignent de l’ouverture don’t faisait prevue l’entreprise en matière de promotion, même si l’approche pourrait être qualifée de post – ou néo-coloniale: en effet, tout à la fois traités de géostratègie et d’anthropologie politique, ils prônent simultanément le passage à l’autonomie pour les pays nouvellement indépendants et une étroite collaboration ave l’Eni pour ce qui concerne l’exploitation du pétrole (Roche 2013, 70).
Anche Africa. Nascita di un continente (1968) si muove sulla stessa linea. Bovay sembra anticipare l’interesse terzomondista di Pasolini espresso in Appunti per una Orestiade africana (1970), in un film colmo di consapevolezza sulle vocazioni, ancora inespresse, del grande continente africano. In generale, si tratta di opere fondamentali per illustrare il mutamento di paradigma del cinema industriale. Una linea umanista pervade queste opere: al di là delle macchine, sono lavori che non dimenticano l’uomo, in una costante attenzione alle vite dei protagonisti, alle loro condizioni materiali, nonché agli orizzonti simbolici e culturali. Per questo li collochiamo fra i paesaggi sperimentali di un neorealismo che continua, al di là di alcuni proclami, figli dello spirito del tempo, sulla ‘esaltante’ modernizzazione italiana. Significativa è la relazione tenuta da Cecchinato in un convegno del 1972 sul ‘tecnofilm’: non più film per l’industria ma film sulla vita industriale, critica alle intrusioni in corso d’opera di manager che vogliono “far diventare l’autore del film ‘autista’ del film” (Cecchinato 1972, 17), auspicio di una vera sceneggiatura per superare “film tecnici patinati, puliti, come uno specchio, ma senza alito di vita, di comunicativa” (Cecchinato 1972, 13).
L’autunno caldo è appena passato e anche la Confindustria sente la necessità di allargare il ‘tecnofilm’ al rapporto fra contesto produttivo e società, nei suoi aspetti politici, economici e antropologici: ora si accenna a un ‘cinema dell’uomo’, che dovrebbe osservare meno le macchine e più l’umanità. Nuove consapevolezze, atteggiamenti normativi e sistemi di valori che il cinema dell’Eni aveva anticipato, in un’idea di cinema documentario quale istituzione complessa, già pienamente rappresentata da Le vie del petrolio. L’unico documentario nella carriera di un grande inventore di forme come Bernardo Bertolucci è coprodotto dalla RAI [5]: sono anni in cui nessuna dittatura auditel blocca la televisione e l’azienda sembra libera di concedersi iniziative culturali oggi impensabili. Oltre al film di Bertolucci ricordo lavori come Appunti per un film sull’India di Pier Paolo Pasolini (1967, prodotto dal magazine TV7, poi presentato alla Mostra di Venezia) o Giovani brasiliani, di Gianni Amico (1967). Casi in cui emerge pienamente l’idea che il cinema documentario, ben più del cinema di finzione, sia mediatore di potenti istanze etico-estetiche, in “un lavoro sommerso entro cui si esercita, in maniera ancora più radicale, la possibilità di controllo e manipolazione da parte del potere politico”. Ma anche, continuando con le considerazioni di Gian Piero Brunetta “uno spazio entro cui si continuano a proporre discorsi e ad esplorare realtà, godendo di margini di libertà e di sperimentazione…” (Brunetta 2009, 100).
Sono quelli di cui gode Bertolucci nella realizzazione del suo film, con immagini di rara bellezza, un commento denso di citazioni letterarie, momenti di silente, profonda malinconia, reminiscenze di film girati in questi luoghi e, soprattutto, un fecondo intreccio fra l’arcaismo e il presente. Il film è in tre episodi, ognuno con una forte specificità.
Nel primo, Le origini, si concentra sui siti estrattivi sul Monte Zagros, in Iran, confrontando sguardi di uomini che storicamente dialogavano con il fuoco, con interviste in cui la distanza da casa e l’assenza degli affetti segnano i lavoratori italiani impegnati nei pozzi. Un’attitudine antropologica, che cerca di posizionarsi alla frontiera di mondi irriducibili, in cui dominato e dominatore sembrano prossimi a un futuro in cui potere ri-conoscersi.
Nel secondo episodio, Il viaggio, Bertolucci ci accompagna in un tempo e in un paesaggio sospesi, attraverso una petroliera che attraversa il Canale di Suez per dirigersi lentamente verso Genova. Raccontare l’oro nero significa anche misurarsi con il non visibile, il sotterraneo, e qui la modalità tipica del documentario descrittivo, con il dominio della voce narrante, lascia il posto a un cinema di evocazioni visive: volti paesaggio, figure perdute in spazi desertici, aperti orizzonti marini che sembrano ospitare e rileggere miti fondanti, come il viaggio di Ulisse.
Nel terzo episodio, Attraverso l’Europa, il racconto parte da una
Genova verticale, vertigine, aria, scale; Genova tutta colore, bandiera, rimorchiatore; Genova da intravedere, mattoni, ghiaia, scogliere; Genova di banchina, transatlantico, trina; Genova portuale, cinese, gutturale; Struggimento, scogliera, Genova di petroliera.
Le intenzioni poetiche di Bertolucci si insinuano in momenti di felice ‘sbandamento’ dai compiti istituzionali della voice over e cercano in Mario Trejo, poeta e giornalista argentino, un complice nel difficile viaggio verso la Baviera, laddove il petrolio verrà raffinato. Al termine del viaggio
Ce film semble pour Bertolucci l’occasion de réfléchir au cinéma du point de vue de sa substance même. C’est d’une certaine manière une réflexion sur l’art du mouvement à la fois dans l’image – voitures, tanker, chameaux, tous les modes de déplacement sont mis en action – et à partir de l’image – le rythme insufflé par le montage (Bertozzi, Roche 2013, 69).
Quella dei film prodotti dall’Eni resta un’impresa fondamentale per comprendere il gigantesco processo di modernizzazione dell’Italia del periodo. E forse, proprio la qualità degli autori coinvolti, testimonia intenti aziendali consapevoli di quanto la convivenza tradizione-modernità fosse un tratto ibrido e, per molti versi, distintivo del nostro Paese. Come se alle culture del passato non potesse chirurgicamente sostituirsi il dominio del moderno ma tutto ciò costituisse piuttosto un inestricabile labirinto di aspettative, desideri, immaginari. A momenti di grande fiducia progettuale – quell’onda impetuosa che sembra travolgere gli italiani antichi nel loro viaggio verso una modernità tutta da costruire – i film di Ivens, Bovay, Bertolucci affiancano spazi simbolici carichi di istanze extra industriali, in un’ardua ricalibratura visivo/identitaria sul mondo nuovo. Nel ‘Cinema Italia’ costruito dall’Eni, storie di lungo respiro, cultura del moderno, istanze internazionaliste sembrano procedere insieme. Questo cinema rappresenta il Paese e, al tempo stesso, lo costruisce: una mediazione titanica, nella contraddittoria esperienza italiana del moderno.
Note
[1] Il Parlamento italiano vota l’adesione alla North Atlantic Treaty Organisation (NATO) nel marzo del 1949. Fra gli aspetti promozionali del Piano Marshall ci sono anche il dono di bambole e di dischi, la realizzazione di programmi radio e spettacoli per burattini, l’allestimento di esposizioni di vario genere, con la distribuzione di milioni di fumetti, opuscoli, cartoline, calendari.
[2] Come appare dalla domanda per il nulla osta ministeriale. Si veda M. Bertozzi, Ai limiti del reale. La censura italiana e il cinema documentario, realizzato per la mostra on line realizzata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, www.cinecensura.com.
[3] Per cui oggi esistono almeno tre versioni del film: quella montata dal regista, la versione RAI con una intervista a Mattei realizzata da Paolo Taviani e la versione industriale, con il commento in inglese. Brass inizia anche a curarne una versione per il cinema, ma l’accanimento contro il film si esplica anche con la mancanza del visto di censura e il relativo impedimento a partecipare agli Oscar.
[4] In generale, negli anni Cinquanta il ‘tecnofilm’ costituisce un genere che tiene assai poco conto delle esigenze di autori e spettatori “per soddisfare unicamente quelle del committente, troppo spesso attardato nella rappresentazione di una ‘realtà’ aziendale coperta dagli intenti pubblicitari o trionfalistici”. S.n. Introduzione a Il film industriale alla verifica degli anni 70, Atti dell’omonima tavola rotonda, Ferrara, 9 giugno 1972, 5.
[5] Il film viene messo in onda dalla RAI nel gennaio-febbraio del 1967. Recentemente, restaurato dalla Cineteca Nazionale di Roma, è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, in occasione del conferimento del Leone d’oro alla carriera a Bernardo Bertolucci, nel 2007.
Riferimenti bibliografici
- AA. VV. 1971
AA.VV., Cinema e industria. Ricerche e testimonianze sul cinema industriale, Milano 1971. - Anania, Tosatti 2000
F. Anania e G. Tosatti, L’amico americano. Politiche e strutture per la propaganda in Italia nella prima metà del Novecento, Roma 2000. - Baldi 2003
A. Baldi, Schermi proibiti. La censura in Italia, 1947-1988, Venezia/Roma 2003. - Bertozzi, Roche 2013
M. Bertozzi, Th. Roche, L’autre Néo-réalisme. Une correspondance, Amiens/Crisnée, Festival International du film d’Amiens/Yellow Now 2013. - Brunetta 2009
G.P. Brunetta, Il cinema Neorealista italiano da “Roma città aperta” a “I soliti ignoti”, Bari 2009. - Bruni 2003
D. Bruni, I cortometraggi industriali, in Adriano Aprà (a cura di), Ermanno Olmi. Il cinema, i film, la televisione, la scuola, Venezia 2003. - Castronovo, Ceri, Rondolino 1988
V. Castronovo, P. Ceri, G. Rondolino (a cura di), La cineteca FIAT, Torino 1988. - Cecchinato 1972
G. Cecchinato, Il film industriale alla verifica degli anni 70. Atti dell’omonima tavola rotonda (Ferrara, 9 giugno 1972), Ferrara 1972 - Ciacci 2004
L. Ciacci (a cura di), Venezia è una città. Un secolo di interpretazioni del cinema documentario, Venezia 2004. - Elwood 1996
D.W. Ellwood, L’impatto del Piano Marshall sull’Italia, in G. P. Brunetta (a cura di), Identità italiana e identità europea nel cinema italiano dal 1945 al miracolo economico, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 1996. - Frescani 2014
E. Frescani, Il cane a sei zampe sullo schermo. La produzione cinematografica dell’Eni di Enrico Mattei, Napoli 2014. - Latini 2011
G. Latini, L’energia e lo sguardo. Il cinema dell’Eni e i documentari di Gilbert Bovay, Roma 2011. - Latini 2016
G. Latini, Immagini-mondo. Breve storia del cinema d’impresa, Roma 2016. - Mazzei 2000
L. Mazzei, I documentari industriali di Ermanno Olmi, in Sandro Bernardi (a cura di), Storia del cinema italiano, 1954-1959, Vol. IX, Roma/Venezia 2000. - Mosconi 1991
E. Mosconi, Il film industriale, “Comunicazioni sociali” anno XIII, 1/2 (1991). - Olivetti 1957
A. Olivetti, Dal comunismo al socialismo. Saggio preliminare intorno al salto dalla dittatura alla libertà, “Comunità” 46, anno XI (gennaio 1957). - Olivetti 2001
A. Olivetti, Città dell’uomo, Torino 2001. - Pellizzi et all. 1972
C. Pellizzi, R. Petrognani, M. Wolf, F. Zanella, Cinema industriale e società italiana, Milano 1972. - Perrone 2001
N. Perrone, Enrico Mattei, Bologna 2001. - Sani 2006
M. Sani, Obiettivo sul pozzo in fiamme, “Il manifesto”, 8 agosto 2006. - Sereni [1949] 1974
E. Sereni, Per la difesa del cinema italiano, discorso tenuto al Senato della Repubblica il 25 maggio 1949, in AA.VV., Sul Neorealismo. Testi e documenti (1939-1955), Quaderno informativo, Pesaro, Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, 1974 89. - Tosi 2002
V. Tosi, Joris Ivens. Cinema e Utopia, Roma 2002.
English abstract
Since the 1950s, in harmony with other large Italian companies, Eni has become a producer of industrial films. At the end of the decade, Enrico Mattei feels the need to turn these “tecnofilms” - in which technical, educational and informative aspects dominate - into important films for the general public. To change the international imaginaries, linked to an Italy seen essentially as an agricultural country, great authors are needed and Mattei turns to the famous documentarist Joris Ivens. The events of his L’Italia non è un paese povero - never broadcast in full for the censorship of the RAI; the subsequent films by Gilbert Bovay, shot in Africa and in the Near East and marked by the climate of “decolonization”; a prestigious film such as Le vie del petrolio by Bernardo Bertolucci shine today as evidence of a glorious season of corporate cinema. Works in which the human aspect, the lives of the protagonists, the relationships between our culture and those of the producing countries are observed problematically. Films that, beyond industrial aspects, today constitute a corpus of enormous cinematographic and socio-cultural interest.
Keywords | Bernardo Bertolucci; Joris Ivens; Gilbert Bovay.
La Redazione di Engramma è grata ai colleghi – amici e studiosi – che, seguendo la procedura peer review a doppio cieco, hanno sottoposto a lettura, revisione e giudizio questo saggio.
(v. Albo dei referee di Engramma)
Per citare questo articolo / To cite this Article: Marco Bertozzi, Cinema dal petrolio. L’Eni e il documentario d’impresa, “La Rivista di Engramma” n. 169, ottobre 2019, pp. 153-170 | PDF dell’articolo