Reggio Emilia nella crisi della sinistra e delle sinistre negli anni Ottanta
Luca Alessandrini
English abstract
Adgnosco veteris vestigia flammae
Virgilio, Eneide, IV, 23

Foto di Tano D’Amico, 1972.
A Reggio Emilia, nella solenne quinta del Teatro Municipale, il 24 settembre 1946, Palmiro Togliatti, segretario nazionale del Partito comunista italiano, pronunciò un discorso programmatico che segnava l’inizio di uno degli assi portanti della politica del Pci per i quattro decenni successivi, la costruzione del modello emiliano e il fondamento teorico della “via italiana al socialismo”, già presente, in nuce, nella scelta resistenziale – ben diversa da altre, come quella jugoslava – e nella cosiddetta “svolta di Salerno” dei primi giorni della primavera del 1944. Riflettere sulla dimensione storica e storico-culturale della sinistra italiana, e in particolare di quella comunista, negli anni Ottanta non può prescindere dalla valutazione di quel passaggio epocale per la traiettoria di un partito di matrice terzinternazionalista.
L’occasione è offerta dalla mostra “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024”, dedicata alla traiettoria del gruppo punk rock, che è stata allestita a Reggio Emilia, in un singolare ma forse non imprevedibile repêchage, che raccoglie in sé tanto la celebrazione di una stagione della musica italiana, quanto la riesumazione di un orizzonte simbolico proprio del sovietismo, scelto dalla band in anni nei quali pareva da tempo al tramonto.
Gli anni Ottanta
Si vuole che gli anni Ottanta siano gli anni del riflusso, del ripiegamento nel privato, dell’“edonismo reaganiano”, dopo gli anni dell’impegno sociale, della dimensione collettiva, delle ideologie e financo delle utopie. E ancora, gli anni di un illusorio nuovo benessere, icasticamente riassunti nella fortunata formula della “Milano da bere”, dopo i faticosi anni Settanta, lacerati dall’aspra crisi economica generatasi tra i due shock petroliferi. Se tali rappresentazioni sono certamente fondate, esse rischiano di apparire stereotipate, ritualmente ripetute quasi a eludere sostanziose questioni; anche se indicano alcune possibili linee interpretative, non sono affatto sufficienti a comprendere situazioni e dinamiche di un decennio di transizione e, in particolare, delle sinistre.
Per le sinistre, e per quelle italiane in particolare, il decennio precedente, i tanto declamati anni Settanta, aveva avuto a un tempo la consistenza delle maggiori conquiste di progresso sociale e civile e di una bruciante sconfitta anche se non compresa appieno nell’immediatezza degli eventi. Mentre si portavano a compimento grandi battaglie, mentre si accumulava capitale sociale, si andavano disgregando i vincoli identitari e le prospettive strategiche di partiti, gruppi e movimenti della sinistra. Il grande slancio delle lotte operaie e poi operaie e studentesche si era venuto attenuando, smarrendo efficacia e obiettivi. Diversi nodi erano venuti al pettine, innanzitutto due: la ristrutturazione capitalistica, che sarebbe stata definita con la formula – forse non esatta ma oramai entrata nell’uso – di “neoliberismo”, e l’incapacità delle sinistre di costruire nuovi indirizzi programmatici di ampio respiro. In una parola, se la sinistra era sopravvissuta alla crisi degli anni Settanta, ne era uscita svuotata.
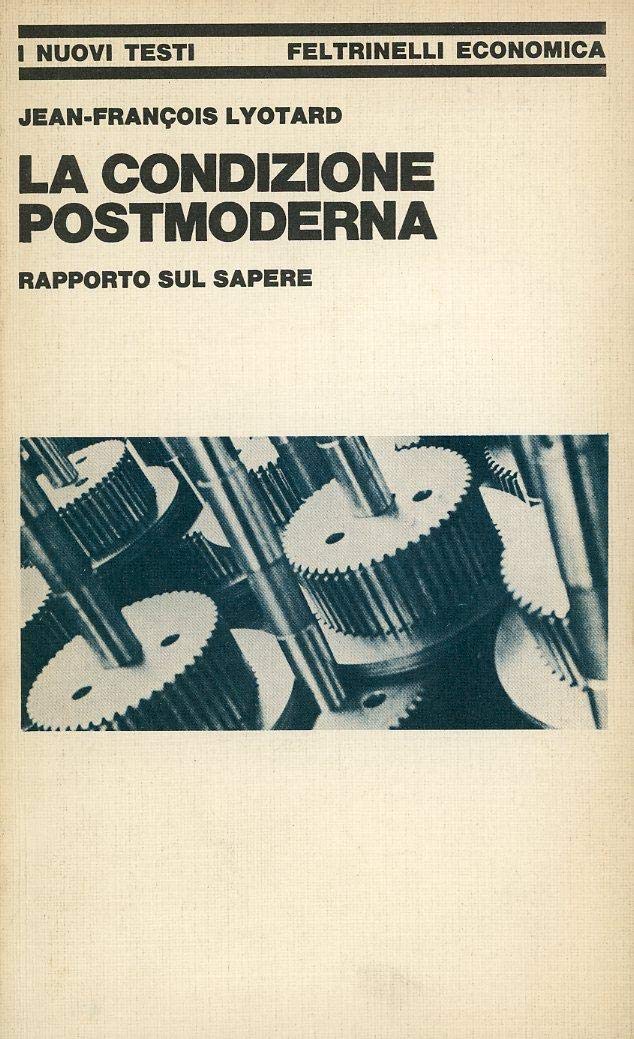
Jean-François Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere [Paris 1979], Milano 1981.
Cosa era accaduto? Oggi è facile leggerlo col senno di poi e alla luce di innumerevoli studi nei campi economici, politologici, sociologici e storici. Ma anche la letteratura e il cinema restituiscono forte l’idea del cambiamento epocale allora in atto. Cambiava il lavoro, sempre meno disponibile e sempre più precarizzato; cambiava la politica, in una insanabile frattura tra rappresentanza politica e rappresentanza sociale, in un contesto generale nel quale si estingueva quell’idea di progresso che per un paio di secoli aveva ispirato e animato la società europea. Mentre si affermava la condizione postmoderna, uscì La condition postmoderne di Jean-François Lyotard, nel 1979, in italiano nel 1981. Si approssimava la fine della mitopoiesi antifascista, annuncio indiretto della fine della “Repubblica dei partiti”, secondo la nota espressione di Pietro Scoppola, e del loro patto ciellenistico.
La crisi degli anni Settanta aveva mutato in profondità il mondo, quello occidentale in particolare. In campo economico si interruppe la formidabile crescita inauguratasi sul finire della Seconda guerra mondiale, “i trenta gloriosi”, gli anni dalla metà dei Quaranta, e nulla sarebbe stato più come prima. Gli accordi di Bretton Woods dell’estate 1944, che avevano definito un ordine monetario per la regolazione dei rapporti tra Stati, vennero a cessare in seguito a due provvedimenti assunti dagli Stati Uniti tra il dicembre 1971, quando il presidente Nixon sospese la convertibilità del dollaro in oro, e il febbraio 1973, lasciando il campo alla fluttuazione dei cambi, fino all’adozione del sistema dei cambi flessibili, sancita definitivamente in Giamaica nel 1976, sulla quale gravava lo stigma di non essere frutto di una strategia negoziata, come era stato dal Dopoguerra, ma di decretare una situazione de facto. La corsa allo spazio e la Guerra in Vietnam avevano segnato le sorti della valuta statunitense, e a tanto si aggiunse la crisi energetica del 1973, tanto sconcertante quanto gravida di conseguenze non soltanto sul piano economico, ma anche nella concezione stessa delle relazioni internazionali. Sconcertante perché metteva in discussione la cheap economy, lo sviluppo fondato sul petrolio – in forme drammaticamente più tangibili della profetica, abbastanza discussa allora, ma priva di conseguenze pratiche, dissertazione del Club di Roma resa nota con la pubblicazione de I limiti dello sviluppo nel 1972 – e perché imponeva di prendere atto della presenza di un nuovo soggetto sulla scena mondiale.
Con la Guerra dello Yom Kippur, un ennesimo attacco allo Stato d’Israele finito ancora una volta con una sconfitta, i paesi arabi produttori di petrolio si erano presentati uniti sul mercato, ostili verso l’Occidente, consapevoli della forza che derivava loro dall’essere i fornitori di una materia prima essenziale. Il mondo non era più diviso in due, in ragione della sola linea di frattura della Guerra fredda, ma si presentava un terzo protagonista, la cui esistenza non poteva essere negata, né più risolta comprandone le classi dirigenti. Ne sortì una grave crisi economica, che colpì in modo particolarmente aspro l’Italia, che fu confermata dalla seconda crisi petrolifera nel 1979, ingenerata dalla Rivoluzione iraniana e dal nuovo regime teocratico sciita. Inoltre, gli anni Settanta si chiudevano con una rinnovata tensione tra Patto Atlantico e Patto di Varsavia, dopo anni di distensione. Non è questa la sede per discettare se la distensione fosse finita o fosse solo in una fase di stasi, ma occorre rilevare una nuova intensa drammaticità del confronto bipolare. Se ancora nel marzo 1979 il Politburo dell’Unione sovietica rifiutava un intervento in Afghanistan a sostegno del regime comunista, che lo aveva richiesto, proprio perché si riteneva che fosse più importante di ogni altra considerazione non compromettere le relazioni con gli Stati Uniti, nel dicembre lo stesso organo svolse considerazioni opposte e decise l’invasione, nella convinzione che la pressione statunitense fosse in aumento, mentre si aggravava la situazione a Kabul. Contestualmente, negli Stati Uniti, nonostante gli sforzi dell’amministrazione Carter, si andava affermando un’idea di politica estera aggressiva, sostenuta dai “neoconservatori” e dalla nuova destra repubblicana.
Nel gennaio 1981, Ronald Reagan venne eletto con largo margine presidente degli Stati Uniti dando corpo al nuovo conservatorismo con l’aumento delle spese militari e del deficit, la riduzione delle tasse sul reddito e dei tassi di interesse, la deregulation, liberalizzazioni e – si potrebbe dire, naturalmente – politiche antisindacali. In una formula, coniata allora, Reaganomics. Le tesi erano quelle della Chicago School of Economics, che ispiravano anche le scelte, del tutto analoghe a quelle reaganiane, di Margaret Thatcher nel Regno Unito, il cui periodo della responsabilità di governo è il medesimo di Reagan, gli anni Ottanta: l’una dal 1979 al 1991, l’altro dal 1981 al 1989. Il mondo occidentale era dominato dal conservatorismo e dal neoliberismo. Thatcher propugnava e realizzava la deregulation, privatizzava, indeboliva i sindacati. Le furono appioppati almeno due nomignoli: the Iron Lady, per la sua irremovibilità una volta assunte decisioni, esibita in particolare nella dolorosa vertenza con i sindacati dei minatori, e Tina (acronimo di “There is no alternative”), sottinteso a quel neoliberismo che non si limitava a essere una politica economica, ma veniva a costituire un intero sistema di pensiero. Ancora Thatcher se ne faceva portatrice, come con la sua nota affermazione “La società non esiste” come ebbe a spiegare in una intervista: “There is no such thing as society. There are individual men and women, and there are families” (Thatcher 1987, 29), dopo aver considerato “I think we have gone through a period when too many children and people have been given to understand ‘I have a problem, it is the Government’s job to cope with it!’”, liquidando l’idea stessa di stato sociale e indicando la via delle fortune individuali: “There is nothing wrong with having a lot more money”. Una cesura netta con l’orizzonte concettuale della sinistra e non solo di questa, ma anche di quel pensiero liberale che aveva partecipato della scrittura delle costituzioni postbelliche. Gli anni Ottanta, quegli anni Ottanta, chiudevano con le idee di Stato e di cittadinanza fondato sui principi universalistici dell’uguaglianza, della comune responsabilità, della solidarietà non già quale gesto caritatevole verso i più sfortunati, ma come elemento necessario in una società che produce diseguaglianze, sulla partecipazione e sui corpi intermedi, nei quali e attraverso i quali si esprimono istanze e conflitti.
Le due chiese
La sinistra italiana, nel suo carattere variegato e non facilmente ricomponibile, aveva conosciuto una crescita costante seppure non senza discontinuità. I socialisti erano entrati nella compagine di governo dall’inizio degli anni Sessanta, sebbene il programma riformatore del quale erano portatori avesse dovuto infrangersi contro un insormontabile rifiuto, rivelato dal segretario Pietro Nenni quando affermò di avere udito un “tintinnar di sciabole”, quell’ipotesi di colpo di Stato, qualora le sinistre avessero prevalso, che sarebbe stato scoperto nel 1967 dal giornalismo d’inchiesta vanto del settimanale “L’Espresso”.
.png)
Nuova impetuosa avanzata del Pci, “l’Unità”, 22 giugno 1976.
Paradossalmente, era stato ben più riformatore il di poco precedente governo Fanfani IV, con l’appoggio ancora solo esterno dei socialisti, che aveva nazionalizzato la produzione della corrente elettrica e realizzato la scuola media unica. Ne seguirono anni di un centrosinistra statico. Il Partito comunista all’opposizione cresceva costantemente – fino alla vetta del 34,4% delle elezioni politiche del giugno 1976 – ma non poteva aspirare al governo. E ciò innanzitutto per un motivo: il “bipolarismo imperfetto” come è stato definito il sistema italiano della prima fase della storia della Repubblica, non contemplava la possibilità che i comunisti, considerati l’equivalente interno del nemico esterno nella Guerra fredda, l’Unione sovietica, potessero assumere la guida del paese.
Proprio il grave stato di tensione nel quale la Guerra fredda aveva fatto precipitare i rapporti politici fin da prima che ne fosse escogitato il termine nel 1945 da George Orwell, prima della sua constatazione nel discorso di Churchill a Fulton (negli Stati Uniti) il 5 marzo 1946, secondo il quale l’Europa, e il mondo, sarebbero stati divisi da una “cortina di ferro”, e prima della sua aperta proclamazione nel discorso del presidente Truman al Congresso degli Stati Uniti il 12 marzo 1947. In realtà, già nell’ultima fase della Seconda guerra mondiale, ed esplicitamente nella conferenza di Jalta nel febbraio 1945, era stata netta la distinzione tra aree di influenza del paese guida del cosiddetto “socialismo reale” e delle potenze occidentali.
Il Partito comunista italiano, di gran lunga il più consistente dell’Occidente, nella polarizzazione indotta dalla Guerra fredda e dalla radicalizzazione del conflitto sociale in Italia a partire dal Dopoguerra, aveva rappresentato uno dei due poli. Si era venuto creando non soltanto un fronte delle opposizioni egemonizzato di fatto dal Pci, ma una subcultura comunista contrapposta a quella moderata e cattolica, politicamente rappresentata dalla Democrazia cristiana. Entrambi gli schieramenti erano capillarmente presenti nella vita sociale, in forme politiche organizzate, sindacali, negli enti locali, nell’associazionismo, fino alla diffusione sul territorio delle Case del Popolo da una parte, come degli oratori e delle parrocchie dall’altra. Era questa la logica della costruzione togliattiana del “partito nuovo” nel Secondo dopoguerra, partito di massa che avrebbe dovuto aderire a “ogni piega della società”.
Tale polarizzazione aveva presto prodotto due conseguenze: la prima si concretò nella marginalizzazione delle correnti politiche laiche e socialiste non di dottrina sovietica, di cui è stato esempio evidentissimo il Partito d’Azione, protagonista centrale della Resistenza, importantissimo laboratorio di idee liberaldemocratiche e liberalsocialiste, fortemente dialettico al proprio interno, che si trovò ineluttabilmente ridotto a esigui risultati elettorali e in breve alla disgregazione, schiacciato dall’impraticabilità di politiche terze e di dibattiti raffinati non immediatamente spendibili nella tenzone politica. Non vi era spazio tra i due grandi schieramenti, anche se la dimensione culturale di tali posizioni ebbe modo di esistere e resistere, seppure spesso in disparte. La seconda conseguenza ebbe la consistenza della creazione di due universi antitetici ai quali ci si legava fideisticamente: due chiese. Per i comunisti il credo era nel Partito (con la maiuscola) di leniniana concezione e gramsciana rappresentazione, quale machiavellico “moderno principe”, forma tangibile dell’imperativo categorico, della necessità storica della rivoluzione socialista.
Una rivoluzione procrastinata sine die, ma presente e viva in una concezione che finiva per essere (modestamente) teleologica. Infatti, il Partito comunista italiano aveva rinunciato da tempo alla prospettiva rivoluzionaria di tipo comunista sovietico, almeno dal 1943, ma tale scelta era già nelle ben precedenti riflessioni di Antonio Gramsci. I comunisti italiani costruirono, durante la guerra, i Comitati di liberazione nazionale con tutti gli altri partiti; benché forza largamente maggioritaria nella lotta armata, coinvolsero gli altri partiti nel paradigma dell’unità antifascista nel quale a un tempo si dispiegava la lotta per l’egemonia ma vi era posto per tutti; operarono tenacemente per la creazione di una repubblica parlamentare pluralista, e conseguentemente agirono in sede di Assemblea Costituente; fino a svolgere nella vita politica nazionale un ruolo assai più simile a quello di una forza socialdemocratica europea che a quella di un partito bolscevico.
La “doppiezza togliattiana”
E dunque è questa la nota “doppiezza togliattiana”: non già una simulazione democratica e una occulta preparazione per la presa del potere violenta, secondo la vulgata di una pubblicistica corriva; ma la coesistenza di un’ideologia politica rivoluzionaria, fedele all’Unione sovietica, di dottrina terzinternazionalista e di liturgia leninista, che persisteva nel celebrare il mito della Rivoluzione d’ottobre, e una pratica politica parlamentare, democratica, legalitaria e gradualista. Ci si potrebbe chiedere se tale ambivalenza fosse adottata strumentalmente, e per ingannare chi: l’opinione pubblica moderata o gli stessi dirigenti sovietici, preoccupati dell’autonomia delle vie nazionali dei partiti comunisti nei diversi paesi? Oppure gli stessi militanti del partito, e l’insoddisfazione delle classi subalterne di cui erano portatori, che avrebbero voluto cambiamenti ben più radicali e rapidi?
Nel tentare una risposta assumono grande rilievo alcune considerazioni: la forza del modello del “socialismo realizzato”, dell’eguaglianza materiale raggiunta, seppure a prezzo di un regime di polizia. La Rivoluzione d’ottobre aveva dimostrato che era possibile che i lavoratori assumessero il potere e che si ponesse fine alla società divisa in classi. Nel corso della guerra di liberazione erano divenute leggendarie – non solo tra i comunisti – la resistenza popolare sovietica e la tenacia dell’Armata Rossa, con il noto immane sacrificio di vite umane. Inoltre, si poneva un problema di schieramento sovranazionale, la borghesia e le classi dominanti avevano dalla loro gli Stati Uniti, pareva necessaria una proiezione internazionale altrettanto forte e contraria. Infine, la prospettiva di una rivoluzione immaginata – ma possibile, come dimostrava l’esistenza stessa dell’URSS – ha costituito come una sorta di lenitivo della sofferenza sociale per cui un’Italia poverissima resa ancora più misera dalla guerra e dalle sue grandi distruzioni, ha potuto trovare la forza di tirare avanti, di ricostruire il paese, di lavorare come poteva, di fare figli, in breve di guardare al futuro con fiducia. Tuttavia, non può esservi dubbio che, per quanto avesse aspetti che possono essere ascritti alla sfera della tattica politica come alla dimensione utopica, la “doppiezza togliattiana” è dato strutturale – toppo profonde e coerenti e continuate nel tempo ne sono state le scelte.
Con il benessere economico che ha accompagnato e seguito la formidabile crescita economica, in particolare tra il 1958 e il 1962, che aveva in un lasso di tempo brevissimo trasformato l’Italia da paese rurale arretrato in una delle prime potenze industriali del pianeta – terza produttrice mondiale di elettrodomestici, che allora erano la misura del nuovo modo di vivere –, alla sinistra si ponevano nuove incalzanti domande. Si ebbe una nuova conflittualità operaia, seguita dal Sessantotto, che di fatto in Italia iniziò nel 1967, e dall’autunno caldo del 1969, nonché parallelamente (un marxista di allora direbbe: conseguentemente) la formazione di nuove correnti di pensiero di sinistra fuori dal partito comunista, sotto forma di riviste, gruppi, movimenti, che presto sarebbero stati definiti con termini come sinistra extraparlamentare, nuova sinistra o – come allora si preferiva – sinistra rivoluzionaria, perché contrapposta a un Partito comunista accusato di avere da tempo rinunciato alla rivoluzione e svenduto la conflittualità operaia – “revisionista”, di tanto lo tacciavano le correnti più radicali.
Si trattava di formazioni molto diverse tra loro: chi si richiamava al marxismo-leninismo (con enfasi sul trattino, s’intende), optando gli uni per la sua declinazione sovietica, gli altri per quella maoista; la più parte, pur dichiarandosi marxista e riconoscendosi leninista, non apprezzava la storia dell’URSS dopo la morte di Lenin, e respingeva lo stalinismo e il breznevismo; non mancavano settori ancor più minoritari come i trockisti che si richiamavano alla IV Internazionale. Non occorre ricordare che fu proprio nell’estate del 1968 che si consumò l’invasione sovietica della Cecoslovacchia per porre fine alla Primavera di Praga e che il suicido di Jan Palach fu cantato da un Francesco Guccini che, benché non marxista e meno che mai leninista, era molto amato dal movimento.
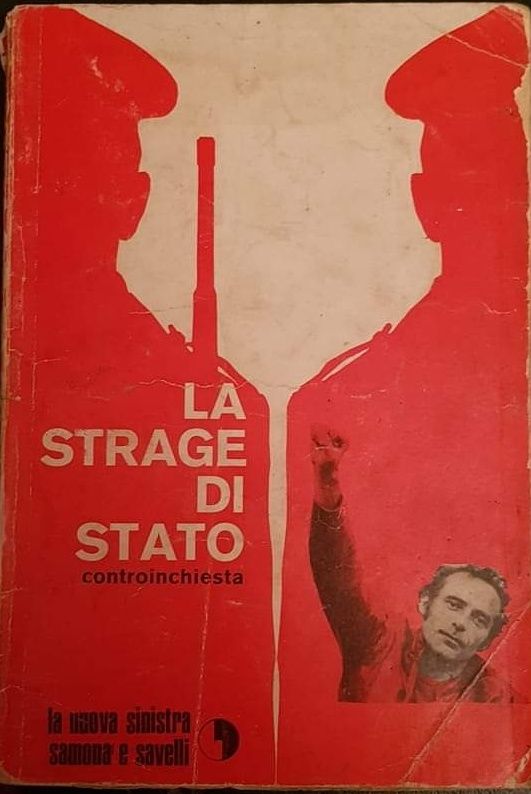
Eduardo M. Di Giovanni, Marco Ligini, Edgardo Pellegrini, La strage di Stato. Controichiesta, Roma 1970.
Gli anni Sessanta si erano chiusi con la strage di piazza Fontana a Milano del 12 dicembre 1969, che gettava l’ombra di una pesante ipoteca sulla vita democratica della Repubblica e dei suoi conflitti sociali e politici. Era passato solo un anno dalla più plateale contestazione studentesca del “consumismo immorale”, che aveva avuto luogo all’inaugurazione della stagione della Scala a Milano, ed era in corso un intenso ciclo di lotte operaie. Fu definita, con un’espressione che fu diffusamente adottata, “strage di Stato”, da un libro precoce, La strage di Stato. Controinchiesta, che uscì sette mesi dopo l’attentato alla Banca dell’Agricoltura del 12 dicembre 1969, e che costituì il “manifesto politico della controinformazione italiana” in cui si denunciavano le collusioni tra gruppi neofascisti e apparati dello Stato nella sua preparazione, nello sviare le indagini e nell’occultamento della verità.
Si era inaugurata quella strategia della tensione che avrebbe accompagnato il paese per tutto il decennio Settanta e oltre. Come è ormai giudizio condiviso, il terrorismo nero italiano – e di fatto anche quello rosso – aveva lo scopo non già di destabilizzare il paese ma di stabilizzarne gli assetti di potere consolidati. Un caso per tutti, il primo, assume valore simbolico dell’efficacia di tale strategia: le grandi agitazioni operaie dell’autunno caldo cessarono di colpo con una rapida firma dei contratti collettivi di lavoro nazionali, pressoché immediatamente dopo la bomba di Milano. Parallelamente, nelle strade, si manifestava l’assalto perturbatore neofascista, coincidente con l’assunzione della segreteria del Movimento sociale italiano da parte di Giorgio Almirante, la quale inaugurava una nuova stagione del neofascismo italiano sull’incerto confine tra legalità e illegalità. Guido Crainz cita il caso della sola città di Milano nella quale, dal gennaio 1969 al febbraio 1971 si sono avuti 147 attentati e 247 aggressioni (Crainz 2003, 372 da Calvi 1973, 92). Assalto neofascista che pose all’ordine del giorno del movimento il delicato e non privo di ambiguità tema della violenza politica, e in particolare ai gruppi della nuova sinistra che erano scaturiti dal movimento stesso e che ne erano parte nella gestione e nel controllo dei servizi d’ordine.
Nonostante le incombenti minacce rese manifeste dallo stragismo, che assumevano le forme di chiusure conservatrici e di progetti autoritari più radicali fino a vere e proprie ipotesi di colpo di Stato, nel paese la sinistra continuava a crescere tanto nei consensi elettorali quanto nelle conquiste sindacali, politiche, civili. Nel 1970 furono istituite le Regioni e furono varati lo Statuto dei lavoratori – sul quale in Parlamento il Pci si astenne perché lo riteneva insufficiente, giacché non estendeva tutti i diritti ai lavoratori delle aziende con meno di quindici dipendenti – e la legge che istituiva il divorzio, poi impugnata e confermata da un referendum assai partecipato e che assunse il potente significato simbolico nel 1974 di grande scontro tra moderatismo e progressismo; nello stesso 1974 si ebbe anche la seconda fase della riforma del sistema tributario che istituì l’Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche che, “secondo i principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione della propria capacità contributiva e della progressività”, fissava 32 aliquote dal 10% al 72%; nel 1975 la riforma del Diritto di famiglia italiano che, dopo ventisette anni dall’entrata in vigore della Costituzione e del suo articolo 3, poneva infine sullo stesso piano i coniugi nella “potestà genitoriale”; nel 1978 la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, anche questa sottoposta a referendum nel 1981 e confermata; ancora nel 1978 la riforma che aboliva il sistema mutualistico e istituiva il Servizio sanitario nazionale; nel 1981 era soppresso l’arcaico delitto d’onore. Importanti conquiste sociali e civili, non soltanto in sé, per la lettera della legge, ma per le vie per le quali erano state ottenute: infatti, esse erano dovute certo alla costruzione di maggioranze parlamentari, ma anche e soprattutto erano state precedute e sostenute da una diffusa partecipazione dal basso attraverso diverse forme di organizzazione.
Gli anni Settanta
Anni complessi gli anni Settanta, caratterizzati da spinte contrapposte: da una parte si costruiva capitale sociale, dall’altra veniva progressivamente e profondamente erosa la fiducia nella capacità e nell’interesse delle istituzioni di rappresentare e dare risposte alle domande della società. Un elemento di crisi, questo, destinato ad approfondirsi, a divenire endemico e, nei decenni successivi, a trasformarsi in crisi della politica e crisi della democrazia stessa. La sinistra avrebbe continuato la propria crescita elettorale fino alle politiche del giugno 1976 e la stagione delle riforme si sarebbe estesa fino a fine decennio, tuttavia la crisi della sinistra era già cominciata e iniziava a palesarsi su più livelli.
La sinistra rivoluzionaria, di fronte alla constatazione evidente non tanto che non sarebbe stata possibile alcuna rivoluzione, ma che non sarebbero stati possibili cambiamenti sociali profondi in tempi brevi, manifestò cambi di rotta e lacerazioni: nel 1973 si scioglieva Potere operaio, nel 1976 Lotta continua; una quota di dirigenti e militanti de “il Manifesto” entrarono o rientrarono nel Partito comunista nel 1976. Una parte non grande ma significativa della nuova sinistra, considerati i tempi lunghi della lotta sociale, optò per la militanza in un grande partito operaio e riformista, e aderì ai Partiti socialista o comunista. Un’altra parte scelse altre vie, nuove ed esasperate, di fedeltà a un’idea di radicalismo politico che toccò la sua acme nell’esperienza di Autonomia operaia e nella contiguità con le tesi della violenza diffusa, considerata a un tempo come espressione di lotta possibile e alterità rispetto a un mondo inaccettabilmente in balia della ristrutturazione capitalistica.
Si esclude qui l’esame dei gruppi del terrorismo soi-disant comunista, se non per rilevare che entrambe le sue declinazioni non furono del tutto isolate. Le Brigate Rosse, le prime a formarsi in modo organico, ancor prima dei fatti di sangue incontrarono il rifiuto delle proprie prospettive di lotta armata da parte di pressoché tutta la sinistra rivoluzionaria italiana, non già perché questa rifiutasse la violenza in quanto tale, ma per il carattere chiuso della scelta brigatista, compiuta nell’isolamento e non già maturata in un rapporto di massa. Ciò che, tuttavia, non impedì l’arruolamento di alcuni e una sorta di consenso relativamente esteso agli attentati che le BR compivano.
Dall’altra parte, i gruppi del cosiddetto terrorismo diffuso, che intendevano essere in rapporto col movimento, come avanguardia ed espressione dello stesso, respingendo il dogmatismo ideologico delle Brigate Rosse. Numerose sigle, di cui la più importante e più attiva era Prima Linea, furono in effetti composte da componenti del movimento, ma non riuscirono mai ad andare oltre omicidi e azioni dimostrative per sciogliersi o sparire tutte – ciò che conferma una matrice ideologica comune, se non nessi organizzativi – nel giro di breve, nei primi anni Ottanta. Che l’impostazione ideologica di questa area fosse opposta a quella delle Brigate Rosse si evince anche soltanto da un frammento del documento di Prima Linea che ne decreta lo scioglimento ma al tempo stesso traccia un bilancio critico della lotta armata, rimarcando la distanza dalle BR, per tornare alla:
Ripresa adeguata di un processo rivoluzionario finalmente sgravato da ogni tesi totalizzante che depauperi l’enorme ricchezza e complessità delle pratiche antagoniste (“Il Bollettino del Coordinamento dei Comitati contro la Repressione” 1983, 59-62).
Il Partito socialista mutava pelle con l’elezione alla segreteria di Bettino Craxi nel 1976, una vera e propria appropriazione del partito, del quale diveniva il capo incontrastato. La tradizionale competizione col Pci, sempre temperata da solide collaborazioni nelle amministrazioni locali, si riaccendeva con la conclamata riscoperta da parte di Craxi di Proudhon in opposizione ai comunisti, dei quali evidenziava gli aspetti autoritari del marxismo-leninismo. Quindi, lo stesso Craxi aveva rinunciato a ipotesi di sinistra e, giocando sulla consolidata conventio ad excludendum nei confronti del Pci e incontrando il facile consenso della Democrazia cristiana post-morotea, era divenuto l’arbitro della politica italiana disponendo abilmente del suo limitato ma determinante peso parlamentare. Secondo alcune letture, non prive di fondamento, Craxi, di fronte alla crisi della politica, avrebbe inteso riaffermarne con spregiudicatezza il primato, ma questa era ormai inesorabilmente chiusa in se stessa.
Il Partito comunista si trovava in una posizione particolarmente delicata: rappresentava a un tempo la continuità della storia della sinistra in Italia e il mondo del lavoro, in evidente sofferenza per i morsi della crisi economica e per la già avviata precarizzazione. In questo frangente, si manifestò la crisi sotto forma di una serie di sconfitte. Dopo il successo delle elezioni politiche del 1976, che seguiva quello delle amministrative del 1975, il sostegno al “Governo di solidarietà nazionale” o “Governo della non sfiducia", fondato sul principio della responsabilità, sull’austerità e sull’attesa di una futura possibilità di assumere responsabilità dirette nell’esecutivo ne erose i consensi.
Il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro, il politico democristiano che già, anni prima, aveva aperto ai socialisti e che prospettava un coinvolgimento del Pci nella responsabilità di governo, segnò la fine di quella stagione. Nei giorni del ricatto terrorista il partito sostenne col proprio voto parlamentare il governo Andreotti IV fino a quando, dieci mesi dopo, chiese di farne parte direttamente e incontrò la fiera opposizione della Democrazia cristiana, che non era più quella di Moro. Le elezioni del 1979 confermarono l’arretramento dei comunisti, così come ne rinnovarono la conventio ad excludendum. Nel decennio successivo i governi furono retti dalla formula del Pentapartito, cavalcata dal Psi di Craxi, con la quale si sanciva la fine della politica così come era stata concepita nei primi quattro decenni del Dopoguerra, unendo in un’alleanza inedita centrosinistra e chi vi si era tradizionalmente sempre opposto, i liberali, inaugurando una politica “all’insegna di un ‘pragmatismo’ povero di contenuti e sempre più commisto a prassi degenerative” (Crainz 2003, 594-595).

Marcia durante l’occupazione della sede Fiat Mirafiori, settembre 1980.
Un’altra significativa sconfitta, densa di valori simbolici, fu quella dell’occupazione della Fiat nel settembre 1980. L’agitazione era stata motivata dalle decisioni, rese note nel giro di una settimana, di porre 22.000 operai in cassa integrazione per diciotto mesi e quindi di licenziarne oltre 14.000. Gli scioperanti ebbero il pieno appoggio del Partito comunista il cui segretario Berlinguer portò personalmente loro la propria solidarietà fin sui cancelli di Mirafiori. Dopo oltre un mese di agitazione, si mobilitarono i quadri della Fiat, attraversando la città con quella che è divenuta nota come “marcia dei quarantamila”. Indipendentemente dal numero, certamente inferiore, si era di fronte a un fatto nuovo: era la prima volta che i quadri scendevano in strada, era stata possibile una manifestazione antisindacale, si era spezzato il rapporto tra colletti bianchi e operai, la cui capacità di lotta usciva fortemente ridimensionata.
Nello stesso campo, quattro anni dopo il Pci dovette subire la significativa riduzione della scala mobile, emblematico strumento di politica salariale volto a tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori. Una storica bandiera della sinistra che fu difesa col ricorso al referendum, promosso dal Pci nel 1985, ma che fu perso. La scala mobile sarebbe stata poi definitivamente abrogata nel 1992. Nel 1984 morì Enrico Berlinguer, l’ultimo segretario comunista dotato di un carisma riconosciuto, un politico che aveva racchiuso in sé, non senza drammaticità, il doppio ruolo di pontefice della fede comunista e di colui il quale aveva tentato di mutarla in profondità.
L’inesorabile tramonto del partito-guida
Negli anni Ottanta si compiva l’ultimo atto della parabola del Partito comunista, da grande partito di classe di massa a partito postcomunista che ha preferito l’aggettivo democratico piuttosto che socialdemocratico, in nome di un’antica ostilità mai superata. Il termine a quo è necessariamente la morte di Aldo Moro, che segna tragicamente la chiusura di un’epoca, la fine di una competizione con il mondo moderato e cattolico aspra ma anche foriera di possibilità negoziali, così come era avvenuto con i socialisti all’inizio del decennio precedente nella costruzione del “centro-sinistra organico”; sgombrato il campo da una inammissibilità a priori, Dc e Pci avrebbero potuto misurarsi sul terreno gramsciano dell’egemonia.
Il periodo si conclude con lo smantellamento del Muro di Berlino, la fine dell’Unione sovietica, la conseguente fine della Guerra fredda, e la recessione del 1992, in Italia le inchieste della cosiddetta Tangentopoli (ove si scelga di mantenere la volgarità di un termine coniato dalla spettacolarizzazione dell’informazione per sottolinearne la drammatica inadeguatezza a rappresentare un passaggio di fase epocale), nel 1992, che hanno prodotto il collasso del sistema dei partiti così some si era strutturato a partire dal 1943, durante la Resistenza e nell’immediato Dopoguerra, attorno al Patto costituzionale. Poco prima, sull’onda della presa d’atto dell’estinguersi del “socialismo reale” il mutamento di nome del Pci avvenne come un trauma, ma non attraverso un adeguatamente elaborato bilancio dell’esperienza storica del comunismo.
E se la maggioranza del partito, in ispecie in Emilia-Romagna, accettò la trasformazione senza spostarsi su nuove formazioni che pretendevano di protrarre la tradizione comunista, ciò fu dovuto non tanto alla comprensione delle trasformazioni politiche in atto quanto, come qualcuno argutamente osservò, al “dogma dell’infallibilità del segretario generale del partito” (Convegno Identità collettive e costruzione della memoria repubblicana in Emilia-Romagna, Reggio Emilia il 2 e 3 giugno 1998, promosso dall’Associazione per la Storia e le Memorie della Repubblica, dall’Istituto Gramsci Emilia-Romagna, dall’Istituto storico Parri Emilia-Romagna e dagli Istituti storici provinciali della Resistenza della regione. Atti non pubblicati. L’espressione è stata usata da Antonio La Forgia nella tavola rotonda finale in presenza di chi scrive). La consolidata acquisizione leniniana della centralità necessaria del partito reggeva l’urto delle trasformazioni, i militanti, benché privati del nome comunista e del mito sovietico restavano fedeli al partito. Dogma che era stato colto nel 1985 dal comico Maurizio Ferrini che, nel programma televisivo di Renzo Arbore Quelli della notte, interpretava un comunista romagnolo “fedele alla linea”, completamente scevro da ogni indulgenza al dubbio con il suo tormentone: “non capisco, ma mi adeguo”.
In tale contesto, il filosovietismo si riscontrava tra gli anziani militanti di partito, spesso anche colti, ma che ritenevano ancora necessario quel modello contrapposto alla società occidentale fondata sull’economia di mercato e tutto ciò che ne consegue. Si ritrovava anche in ambienti giovanili, seppure limitati ad aree politiche definite. Era la seduzione inesauribile di un mito o la forza dell’alterità di un modello opposto a quello della società dei consumi occidentale? Entrambe le risposte sono plausibili e si coniugano con la particolare declinazione che il Pci ha dato della propria capillare presenza nella società e con la arretratezza e chiusura dello Stato e delle classi dirigenti italiane che reagivano con la chiusura alle istanze di mutamento che emergevano dalla società, dando un’interpretazione restrittiva o non applicando le libertà costituzionali, per tacere delle trame eversive utilizzate per confermare gli assetti di potere.
Eppure, sebbene con cautela, il Partito comunista italiano si era progressivamente allontanato dal “partito guida”, il Pcus. Il V Congresso del Pci, tenutosi tra il 29 dicembre 1945 e il 5 gennaio 1946, aveva dato vita al “partito nuovo”, un partito di massa – non più di quadri rigorosamente selezionati – nel contesto della stagione costituente. Nel 1947, Togliatti, nell’ambito della III Conferenza di organizzazione, aveva esplicitato l’idea di una “via italiana” al socialismo, diversa e autonoma rispetto a quella sovietica.
Il 1956 fu un anno difficile per i comunisti: il 4 novembre l’Armata Rossa aveva invaso l’Ungheria dove si erano registrate tanto ampie proteste popolari da essere definite “rivolta” o “rivoluzione”, e il nuovo primo ministro Imre Nagy – che sarebbe poi stato condannato alla pena capitale e impiccato nel 1958 – si era dimostrato disposto a considerarne le ragioni. Centouno intellettuali comunisti avevano firmato un “manifesto” di solidarietà con gli insorti ungheresi il 29 ottobre, nel quale principalmente si invitava a rivedere il giudizio che si trattasse di una “controrivoluzione delle forze reazionarie” e si criticava lo stalinismo. In breve, diversi ritrattarono, altri uscirono dal Pci. Antonio Giolitti, allora deputato comunista, lasciò il partito, mentre vi rimase con grande sofferenza Giuseppe Di Vittorio, il quale non rinnegò il suo dissenso dalle scelte sovietiche, ma il suo ruolo di amatissimo e prestigioso segretario generale della Cgil ne impedì la cacciata.
In quello stesso anno 1956 vi era stata un’altra protesta dal basso in un altro paese di area sovietica, la Polonia, dove a giugno era stata repressa un’insurrezione operaia a Poznań. Nel febbraio si era tenuto il XX Congresso del Pcus, nel corso del quale, in una seduta riservata, il segretario Chruščëv aveva presentato la relazione Sul culto della personalità e le sue conseguenze, nota come Rapporto segreto, di denuncia di crimini ed “errori” di Stalin. Quindi, una sintesi del rapporto era stata diffusa tra i partiti comunisti del mondo. L’VIII Congresso del Pci si era tenuto nel dicembre di quell’anno: aveva enunciato il compito della lotta per la democrazia e il socialismo, e il “policentrismo”, ovvero, non esisteva solo Mosca e non poteva concepirsi la lotta per il socialismo senza la democrazia. Una nuova occasione di aspra presa d’atto della distanza dal Pcus si ebbe con l’invasione della Cecoslovacchia dell’agosto 1968 che pose fine alla Primavera di Praga.
Contrariamente a quanto avvenuto per l’Ungheria, il Partito italiano in questa occasione manifestò la propria protesta ricorrendo all’inedita espressione “grave dissenso”, allora assai pesante, che ebbe l’effetto di aggravare le due crisi nelle quali il Pci si dibatteva, seppure sempre evitando di farlo in modo palese: quella interna, tra i militanti fedeli al sovietismo e gli altri; e quella esterna, nei rapporti con il Pcus. Il dissenso del Pci non impedì che maturasse nel 1969 la radiazione del gruppo de “il Manifesto”, rivista della sinistra interna al partito, che aveva denunciato con maggiore forza l’invasione col noto editoriale Praga è sola.
Al XII Congresso del Pci, nel 1969, la relazione presentata dalla Commissione di Organizzazione si esprimeva per un “partito non totalizzante” e per un “partito come realtà che ne riconosce altre”, e infine il Pci era concepito come “componente di un vasto schieramento di forze sociali e politiche”, ormai non v’era più nulla di sovietico in quel partito, almeno nella sua elaborazione teorica, ché i militanti avevano posizioni anche fortemente differenziate ancorché poco evidenziabili nella disciplina del centralismo democratico.
Nel marzo 1972, lo Statuto del Pci, approvato al XIII congresso, nel suo preambolo confermava l’autonomia da Mosca, mantenendo la prospettiva del socialismo, ma attraverso la democrazia. Definiva il partito:
L’organizzazione politica d’avanguardia della classe operaia e di tutti i lavoratori, i quali, nello spirito della Resistenza e dell’internazionalismo proletario e nella realtà della lotta di classe, lottano per l’indipendenza e la libertà del paese, per l’edificazione di un regime democratico e progressivo […] per il socialismo, mentre avanza su una via autonoma e nazionale – la via italiana al socialismo – attinge alla ricca e multiforme esperienza del movimento operaio internazionale, dell’Unione sovietica, della Cina popolare e di tutti i paesi di nuova democrazia e partecipa allo scambio di esperienze con i partiti comunisti e operai di tutto il mondo.
Quanto all’organizzazione interna si ribadiva il principio del “centralismo democratico”, e all’articolo 5, I doveri:
Ogni iscritto al partito […] deve approfondire la conoscenza del marxismo-leninismo e applicarne gli insegnamenti nella soluzione delle questioni concrete […]; esercitare la critica e l’autocritica.
Enrico Berlinguer, eletto allora segretario dopo essere stato il vice di Longo, mostrava di mantenere un legame privilegiato con il Pcus, ma al contempo si scontrava con Leonid Breznev sui diritti civili in URSS e in difesa del dissenso, era di allora il caso di Andrej Dmitrievič Sacharov. Intanto, in forma riservata, il Pci intesseva relazioni con le dirigenze della socialdemocrazia europea. Questo nuovo attivismo del partito di Berlinguer non mancò di suscitare forti preoccupazioni tanto tra gli anticomunisti occidentali quanto nel Pcus di Bréžnev. Nel 1973, si sarebbe addirittura attentato alla vita di Berlinguer in Bulgaria, come svelò Emanuele Macaluso nel 1991 e come tentarono di verificare due giornalisti italiani lo stesso anno. Fino ad allora il fatto era stato coperto dal riserbo: un camion militare, inspiegabilmente, si era lanciato contro l’auto diplomatica su cui il segretario del Pci veniva condotto all’aeroporto per rientrare in Italia, si era salvato “miracolosamente” si disse, con qualche escoriazione, mentre il suo interprete era rimasto ucciso. La visita in Bulgaria era stata breve e burrascosa, Berlinguer aveva opposto un fermo rifiuto di fronte alla richiesta di ritrattare il dissenso del Pci circa l’invasione della Cecoslovacchia di cinque anni prima, propostagli dal segretario del partito bulgaro Todor Živkov e dal generale Ilja Kashev, capo dell’Ubo, i servizi segreti bulgari.
Nei lavori del XIV Congresso del Pci, nel 1975, Berlinguer non mancò di elogiare il “clima morale superiore” che si sarebbe avuto in Unione sovietica, anche se l’elaborazione politica si mosse in tutt’altra direzione, con la scelta strategica dell’incontro con le masse cattoliche, anche in forza delle riflessioni gramsciane.
Ma gli “strappi”, come furono definiti, inequivocabili furono tre. Nel giugno 1976, in una intervista resa a Giampaolo Pansa per il “Corriere della Sera” che gli chiedeva del Patto di Varsavia e della Nato rispose: “Mi sento più sicuro stando di qua”. Il 3 novembre del 1977, Berlinguer, in un discorso breve ma ufficiale a Mosca, nell’ambito delle celebrazioni del sessantesimo anniversario della Rivoluzione d’ottobre, sostenne che la democrazia era il valore storicamente universale sul quale fondare un’originale società socialista. In seguito, il 15 dicembre 1981, per televisione, nel corso di conferenza stampa in cui era stato chiamato a pronunciarsi sulla stretta autoritaria del generale Jaruzelski in Polonia, a fronte delle proteste popolari, Berlinguer aveva dichiarato che:
Ciò che è avvenuto in Polonia ci induce a considerare che effettivamente la capacità propulsiva di rinnovamento delle società, o almeno di alcune società, che si sono create nell’est europeo, è venuta esaurendosi. Parlo di una spinta propulsiva che si è manifestata per lunghi periodi, che ha la sua data d’inizio nella Rivoluzione socialista d’ottobre […]. Oggi siamo giunti a un punto in cui quella fase si chiude […] è necessario che avanzi un nuovo socialismo nell’ovest dell’Europa, nell’Europa occidentale, il quale sia inscindibilmente legato e fondato sui valori e sui principi di libertà e di democrazia. Si tratta, in sostanza, della politica, della strategia, dell’ispirazione fondamentale del nostro partito, che ricevono da quei fatti una nuova conferma.
Il Pci di allora dette un’altra conferma, di fatto, di una propria concezione plurale della democrazia anche nell’ambito della compagine della sinistra di classe, con il caso della Sinistra indipendente. Si trattava di un gruppo parlamentare composto di eletti nelle liste del Partito comunista, ma non comunisti (Scirè 2012). A partire dal 1968 – la data a quo non è priva di significati – il Pci mise a disposizione una quota di seggi per eletti liberi da ogni vincolo verso il partito che ne aveva reso possibile l’elezione, del tutto indipendenti ideologicamente e politicamente dal partito, quali espressioni particolarmente libere dell’intellettualità politica italiana. Non erano animati dell’intenzione “di un nuovo partito, ma di un’area di dibattito permanente volto a mettere in crisi il sistema dei partiti per rinnovare il legame tra società civile e istituzioni” (Archivio Centrale dello Stato, Archivi di partiti, sindacati, movimenti, associazioni e comitati). Vi si trovavano personalità di sinistra di diversa ispirazione, azionista, socialista e liberalsocialista, liberaldemocratica, laica e cattolica, capogruppo in Senato fu a lungo Ferruccio Parri.
Il bambino e l’acqua sporca
Se la subalternità del Partito comunista all’impianto ideologico e ai legami con l’URSS era andata lentamente attenuandosi, era mancata la costruzione di un progetto pienamente riformista, al netto delle esperienze – e non del tutto nemmeno queste – delle regioni e dei comuni guidati dal Pci. La “via italiana al socialismo”, se sulla carta dichiarava la volontà di emancipazione dal comunismo sovietico, era stata di blanda e incerta elaborazione. Infine, il comunismo del Pci, con Achille Occhetto, senza darsi troppe spiegazioni, si autoestinse in connessione con la crisi del mondo di quel cosiddetto socialismo reale dal quale si proclamava autonomo e diverso.
Tutto era profondamente, radicalmente mutato all’inizio degli anni Novanta, con la fine dell’età contemporanea, erano finiti la società di massa, il “socialismo reale” e la Guerra fredda, e lo stesso Partito comunista italiano aveva mutato nome repentinamente ma non inaspettatamente, per chi avesse voluto capire. Era ormai svuotata anche la fascinazione esercitata per un certo periodo del modello cinese-maoista, dapprima per la sua rottura col Pcus, dal 1956, e poi col fallimento della politica del “Grande balzo in avanti”, in seguito con la condanna della cosiddetta “Banda dei quattro” dei quali faceva parte Jiang Qing, la vedova di Mao, che segnava la fine della Rivoluzione culturale, la nuova Cina di Deng Xiaoping e infine la repressione della protesta di piazza Tienanmen della primavera 1989. Del Pci restava la certezza della centralità necessaria del partito per i più, per pochi altri la fedeltà al nome nella formazione Rifondazione comunista, fin dalle origini drammaticamente divisa tra filosovietici di antico conio, come Armando Cossutta, e i loro storici opposti, come Lucio Libertini e Sergio Garavini, e le più giovani sinistre radicali provenienti da Democrazia proletaria. All’inizio degli anni Novanta, uno dei personaggi della trasmissione televisiva comica Avanzi era Beppe Mancuso, interpretato da Stefano Masciarelli, un operaio della Fiat in tuta blu d’ordinanza, ma che parlava come il Presidente della stessa Fiat Gianni Agnelli, facendone propri vezzi comunicativi e presunti stili imprenditoriali, segnando la fine della contrapposizione sociale per adesione al modello della classe dominante. La centralità operaia, nucleo fondante del pensiero politico di impronta marxiana si era esaurita e con essa si era estinta, se non la classe operaia, la coscienza di classe, motore della trasformazione sociale.
Il comunismo storico era davvero finito e nessuno pareva disposto a raccoglierne il testimone, i “fedeli alla linea” non avevano più un saldo punto di riferimento, si trovarono progressivamente sempre più smarriti, mentre si eludeva sul piano politico un bilancio storico dell’esperienza del socialismo realizzato. Toccò a un non comunista, Norberto Bobbio, porre la questione di fronte allo smantellamento del Muro di Berlino:
Sono in grado le democrazie che governano i Paesi più ricchi del mondo di risolvere i problemi che il comunismo non è riuscito a risolvere? Questo è il problema. Il comunismo storico è fallito, non discuto. Ma i problemi restano, proprio quegli stessi problemi che l’utopia comunista aveva additato e ritenuto fossero risolvibili. […] La democrazia ha vinto la sfida del comunismo storico, ammettiamolo. Ma con quali mezzi e con quali ideali si dispone ad affrontare gli stessi problemi da cui era nata la sfida comunista? (Bobbio in Manni 2001; Bobbio 1995; Bobbio 1992).
La Rivoluzione francese aveva proclamato la libertà e l’eguaglianza, aveva prevalso la libertà dei paesi occidentali, mentre l’eguaglianza imposta con la forza aveva portato al fallimento dei paesi del socialismo reale, ma il problema dell’eguaglianza rimaneva. Non era facile dirlo, nemmeno allora, ma Bobbio era un grande intellettuale, un laico, che non si era mai consegnato ad alcuna chiesa.
Riformisti di Lenin e rivoluzionari
.jpg)
Vladimiro Ferretti, Riformisti di Lenin. La cooperazione reggiana nel Secondo dopoguerra, prefazione di Luciano Casali, Reggio Emilia 1982.
In Emilia-Romagna, e a Reggio Emilia in particolare, i passaggi di fase del comunismo erano stati vissuti da un angolo visuale peculiare, quello caratterizzato dall’essere “regione rossa”, governata dai comunisti, l’espressione praticata di una alterità ai governi e alle classi dirigenti nazionali, la prova tangibile della possibilità di esistere e di prosperare di un mondo altro rispetto a quello del moderatismo cattolico imperante in Italia. Altre due caratteristiche definiscono la regione e in particolare le provincie di Bologna, Modena e Reggio Emilia: l’alto tasso di conflittualità e la tradizione riformista e cooperativista. Le grandi e aspre lotte agrarie, dei braccianti e dei mezzadri, le durissime risposte dei proprietari terrieri, gli agrari, fino al ricorso alla violenza della squadre fasciste contro le organizzazioni dei lavoratori, gli “scherani dello schiavismo agrario” (De Felice 1966, 218), come li aveva definiti D’Annunzio, e ancora la notissima “Settimana rossa” del 1914; poi la larga partecipazione popolare alla Resistenza, tanto larga che nell’estate 1944 si pose il problema di rifiutare il reclutamento nelle fila partigiane, giacché la guerra di guerriglia non poteva per sua natura concepire grandi numeri. Contestualmente, quelle terre erano state quelle del socialismo riformista dei Prampolini, dei Massarenti e degli Zanardi, così come della cooperazione che rinacque nel Secondo dopoguerra per assumere un ruolo centrale nella ricostruzione prima e nella costruzione poi del tessuto economico e sociale della regione. Un libro, non a caso incentrato su Reggio Emilia, rappresenta una sorta di ossimoro fin dal suo titolo Riformisti di Lenin (Ferretti 1982). Può essere questo lo spunto per ritornare alla storia del comunismo reggiano come una sorta di conflitto pluridecennale tra gradualismo di ispirazione socialdemocratica – ancorché l’aggettivo fosse recisamente rifiutato – radicalismo ideologico e mito sovietico.
A Reggio Emilia Palmiro Togliatti giunse il 23 settembre 1946. Aveva scelto quella città per la sua storia e per la storia della regione, ma anche per la questione della violenza. Si trattava delle uccisioni da parte di gruppi di partigiani protrattesi oltre il limite definito dalla legge, l’insurrezione proclamata dal Comitato di liberazione nazionale Alta Italia di concerto col governo di Roma e con gli angloamericani. Questa avrebbe dovuto cessare con l’insediarsi di un Amg, governo militare alleato, al quale sarebbero stati trasferiti tutti i poteri militari e civili. In tutt’Italia era continuata una certa attività di azioni contro fascisti e ancor più in Emilia. Reggio era nota per essere stata sede di “regolamenti di conti” particolarmente sanguinosi.
In realtà, si erano avute molte più uccisioni nelle provincie di Bologna e di Modena, ma ciò che distinse Reggio fino a farne un caso nazionale furono i tempi e i modi. Se a Bologna il partito poteva contare dirigenti che assai probabilmente tollerarono e coprirono azioni armate oltre il limite di legge, si allineò immediatamente alla linea togliattiana quando, verso la fine di maggio 1945 assunse la segreteria Arturo Colombi, che impose subito e autorevolmente la cessazione di ogni attività violenta.
A Reggio Emilia, invece, le uccisioni furono di gran lunga inferiori, ma ebbero tre caratteristiche che le resero indifendibili: si protrassero troppo avanti nel tempo, addirittura fino al 1946; colpirono anche non fascisti dichiarati, è noto il caso di un prete, don Pessina; la direzione del Pci locale non soltanto non fermò le uccisioni ma le coprì e financo sembrò dare segni di vederle di buon occhio. Togliatti ritenne di intervenire di persona e la sera stessa di quel 23 settembre riunì i sindaci comunisti di Bologna, Giuseppe Dozza, di Modena, Alfeo Corassori e di Reggio, Cesare Campioli, e tre dirigenti della federazione reggiana, tra i quali Arrigo Nizzoli, il segretario. I reggiani, nella migliore delle ipotesi non avevano saputo evitare la violenza omicida, col gergo di allora, omessa vigilanza rivoluzionaria, una colpa grave, come grave era l’errore politico di avere commesso atti che screditavano il partito. La condanna era immediata, ma dilazionata per non dare l’impressione di eventi traumatici nel partito, il segretario Nizzoli sarebbe stato sostituito sei mesi dopo, ma da quel momento doveva allinearsi completamente. Un attivo del partito, a porte chiuse, affrontò il tema della violenza, non ammissibile nel percorso democratico intrapreso dal Pci, tanto che non si sarebbero mai più viste armi proprie in mano ai comunisti, con l’unica nota eccezione dello sciopero proclamato in seguito all’attentato a Togliatti del 14 luglio 1948, anche se continuarono a esistere servizi armati con esclusive funzioni di difesa. Togliatti di fronte ai reggiani aveva decretato seccamente le necessità della complessità della politica democratica con una delle sue battute taglienti:
È più facile dirigere un’unità partigiana in combattimento che non una grande federazione di quaranta o cinquantamila iscritti (Pansa 2008).
Il giorno dopo, 24 settembre 1946, in un grande discorso aperto al pubblico, Togliatti illustrò teoria e strategia di quella che sarebbe stata la linea politica, sociale ed economica del “partito nuovo”. Il discorso fu pubblicato con un titolo eloquente, tanto più se si considera che era espresso da un partito di area sovietica e in un luogo come Reggio Emilia: Ceto medio ed Emilia rossa. Togliatti spiegava l’errore del socialismo riformista, del quale non voleva e non poteva ignorare l’esperienza nell’Italia prefascista, il quale “nell’azione pratica si comportò verso i gruppi intermedi come se non ne comprendesse le caratteristiche e i bisogni” (Togliatti [1946] 1974).
Questa era la chiave: i comunisti, più della socialdemocrazia, erano in grado di comprendere la complessità del tessuto sociale, e innanzitutto la presenza delle classi medie. Togliatti considerava che “l’Italia è infatti un paese ricchissimo di gruppi intermedi, tanto nelle città quanto nelle campagne”, la cui importanza era data dalla constatazione che “i migliori successi elettorali, del resto, sono stati raggiunti proprio in quelle zone dove abbiamo maggior numero di aderenti e di simpatizzanti tra i ceti medi delle campagne”. La conclusione di Togliatti era una indicazione di linea politica strategica:
Tanto come gruppi sociali interessati a un miglioramento decisivo delle loro condizioni di esistenza, quanto come uomini aspiranti al progresso nella libertà e nella giustizia, i ceti medi sia di campagna che di città hanno il loro posto nel fronte delle forze del lavoro che avanzano per rinnovare tutta la società (Togliatti [1946] 1974) 49-50).
Nel 1951, nel corso del Congresso provinciale del Pci, il segretario Valdo Magnani, che nel 1947 aveva sostituito Nizzoli perché di solido equilibrio politico, compì un atto inconcepibile. Al termine della sua relazione di apertura, aveva aggiunto a parte una sua considerazione sulla necessità di una maggiore autonomia dall’URSS. Una riflessione che anni dopo sarebbe apparsa blanda ebbe un effetto esplosivo. A lui si unì subito Aldo Cucchi da Bologna, suo antico amico, che aveva maturato un pensiero fortemente critico nei confronti delle realizzazioni del “socialismo reale”. Togliatti li attaccò duramente con la famosa espressione “anche nella criniera di un nobile cavallo possono esservi due pidocchi” (Dichiarazioni di Togliatti a “l’Unità”, in Togliatti 1951), mentre la stampa comunista li additava quali traditori definendoli col nomignolo “Magnacucchi” (Cucchi, Magnani 1995; Andalò 2010; Bianchini 2013).
Erano due personalità di rilievo, entrambi parlamentari, Magnani aveva due lauree e aveva combattuto la guerra di Liberazione in Jugoslavia, Cucchi, medico e medaglia d’oro alla Resistenza. Entrambi respingevano la concezione del Pcus come partito-guida e non avevano approvato la rottura con la Jugoslavia; avrebbero dato vita a una formazione socialista, poi le loro strade si sarebbero separate: nel Partito socialdemocratico Cucchi, mente Magnani sarebbe stato riaccolto nel Pci, ma la proposta della direzione nazionale del partito di candidarlo al Parlamento fu bloccata dalla federazione reggiana, ancora memore di quella remota ma evidentemente ancora imperdonabile presa di distanza dall’URSS. I due “Magnacucchi” e i loro pochi sodali subirono un ostracismo totale, maldicenze e minacce. La stessa Nilde Jotti, colpevole di essere cugina di primo grado di Magnani fu sospettata di essere una spia, un’infiltrata del Vaticano.

Scontri a Reggio Emilia, 10 luglio 1960.
Nel 1960, Reggio Emilia divenne la capitale dell’esplosione delle proteste contro il governo Tambroni, l’ultimo tentativo centrista da parte della Democrazia cristiana reso possibile, a fine aprile, dai voti determinanti del neofascista Movimento sociale italiano, partito che a fine giugno avrebbe voluto tenere il proprio congresso nazionale a Genova. La somma dei due eventi fece deflagrare una protesta politica fondata su un rinnovato antifascismo partecipato anche da numerosi ragazzi, troppo giovani per avere vissuto alcunché della Resistenza. Si ebbero manifestazioni e scontri di piazza molto duri in tutto il paese, morti a Licata, uno, a Roma, uno, a Palermo, due; ma a Reggio Emilia la polizia, negli scontri che ebbero luogo il 7 luglio, fece largo uso delle armi da fuoco e si contarono cinque manifestanti uccisi, tutti operai, tre ex partigiani e due più giovani. L’amministrazione comunale si fece carico del rito funebre, al quale partecipò Togliatti, la camera ardente nel Teatro Municipale, la cui piazza fu poi intitolata ai “Martiri del 7 luglio 1960”. L’episodio costituì un nuovo importate capitolo della mitopoiesi antifascista, una canzone dedicata al fatto, Per i morti di Reggio Emilia, ebbe un’enorme diffusione. Scritta a caldo da Fausto Amodei, fu poi cantata da tanti tra i quali gli Stormy Six, Milva, Maria Carta e reinterpretata da Francesco Guccini nel 2022, divenne colonna sonora immancabile di ogni stagione dei movimenti di sinistra.

Palmiro Togliatti, La via italiana al socialismo, a cura di Luciano Gruppi e Paola Zanini, Roma 1972.
Un anno prima di quel luglio 1960, che sarebbe divenuto epitome di un nuovo antifascismo di piazza, si tenne la Conferenza regionale del Pci, che si svolse nell’ambito di un’iniziativa nazionale volta a promuovere in tutte le regioni l’applicazione della linea politica emersa due anni prima nell’VIII congresso Pci, ovvero la destalinizzazione e “la via italiana al socialismo”. I toni furono aspri, tanto da portare alla rimozione del segretario di Reggio Emilia, Onder Boni, che era succeduto a Valdo Magnani.
In breve: a Reggio si era passati da Nizzoli, troppo incline alla lotta armata, a Magnani, troppo poco allineato all’URSS, a Boni di nuovo troppo stalinista. A Bologna emerse l’astro di Guido Fanti, che avrebbe assunto la segreteria del Pci di Bologna, poi ne sarebbe divenuto sindaco; quindi sarebbe stato il primo presidente del neonato ente Regione e infine parlamentare, non a caso esponente di spicco della corrente detta migliorista. Fanti indirizzò la discussione su due assi, l’uno più prettamente ideologico, l’altro strategico. Circa il primo, sostenne che:
Non vi era rinnovamento possibile se non nella definitiva rinuncia a ogni falsa, illusoria prospettiva rivoluzionaria nell’attesa di una fatidica ora X (Conferenza Regionale del Pci 1959).
Colpisce che tale tesi sia stata espressa tanto apertamente ventidue anni prima del noto – e non da tutti accettato – “strappo” del segretario nazionale del Pci Enrico Berlinguer, espresso in occasione della stretta autoritaria in Polonia di Jaruzelski. Sul piano strategico, parallelamente, emergeva, riconfermata, rafforzata e articolata rispetto al discorso di Togliatti del 1946 a Reggio Emilia, l’idea di uno “sviluppo industriale basato sulla piccola e media impresa e la trasformazione professionale di centinaia di migliaia di braccianti e casalinghe in addetti alle attività industriali e terziarie”, ponendo in primo piano il tema della scelta del rapporto con i ceti medi, che avrebbe dovuto essere considerato non già necessario e strumentale, ma strutturale e portante di nuovi rapporti economici e sociali.
Persistenze
Ciò non significava, tuttavia, giubilare il mito del “socialismo reale”: Fanti, divenuto sindaco di Bologna, nel 1967 ricevette con tutti gli onori la cosmonauta sovietica Valentina Tereskova, prima donna nello spazio che, nel 1963, aveva completato una non facile missione di tre giorni sulla Vostok 6. Indicata come “uno dei simboli più alti della società socialista”, per due giorni fu accompagnata dal sindaco comunista in un intenso programma di visita: alla colonia marina bolognese di Cervia e in palazzo d’Accursio, sede del Comune, a incontrare le rappresentanti delle organizzazioni femminili. Tereskova, che era anche membro del Soviet supremo, quindi del Comitato centrale del Pcus, fu insignita dell’“Archiginnasium Bononiense”, infine, la sera “si incontrava con i cittadini di Bologna in piazza Maggiore, illuminata a festa e stipata di folla” le cui “dimostrazioni di affetto” non costituivano solo un:
Omaggio all’animosa donna che per prima ha sfidato le paurose incognite dello spazio interplanetario, ma anche un contributo di amicizia al grande popolo sovietico del quale essa è una nobile rappresentante (“Il Comune di Bologna. Notiziario settimanale” 1967, 2).
Si aggiunge che – e forse tale notazione non è fuori dal tema della presente riflessione – Valentina Tereskova, nella Russia post-sovietica, è stata eletta alla Duma e ha fatto parte del gruppo parlamentare per la protezione dei valori cristiani, ha appoggiato l’approvazione dell’inserimento nella Costituzione russa del principio secondo cui “l’ortodossia è la base dell’identità nazionale e culturale della Russia”, nonché, nel 2020, ha sostenuto l’eliminazione di ogni limite ai mandati presidenziali, per consentire a Vladimir Putin di restare alla guida del paese indefinitamente.
È nota la riconosciuta rilevanza delle “amministrazioni rosse” nella storia del Pci e della politica italiana. Eppure, benché il partito nazionale indicasse “la funzione nazionale dell’Emilia-Romagna nella costruzione della via democratica al socialismo” – sono le parole di un dirigente nazionale del peso di Giorgio Amendola – il IX Congresso nazionale del Pci, tenutosi nel 1960, non elesse alcun dirigente emiliano in direzione nazionale, e lo stesso sindaco Dozza, che ne aveva fatto parte, passava dalla direzione alla Commissione centrale di controllo, incarico altrettanto prestigioso ma che lo escludeva dal momento decisionale. Sembrava che, nonostante le professioni di fede sovietica, il partito emiliano fosse tropo riformista o troppo estremista per vedersi affidare responsabilità nazionali.
Si citano qui soltanto due casi opposti. Renato Zangheri, storico, sindaco di Bologna dal 1970 al 1983, poi deputato e capogruppo del Pci alla Camera, nel 1999 scrisse che “il Partito comunista italiano svolge per più aspetti, com’è stato osservato, la funzione di una moderna socialdemocrazia”. Alberto Franceschini era originario di Reggio Emilia, iscritto alla federazione giovanile del Pci, padre e nonno comunisti e resistenti. Fu tra i fondatori delle Brigate Rosse con Renato Curcio, l’uno giunto alla lotta armata deluso dall’interno dalle politiche del Partito comunista italiano, l’altro proveniente dalle agitazioni studentesche del Sessantotto. Reggiani, di famiglia comunista, erano pure Prospero Gallinari, brigatista della prima ora, e Franco Bonisoli, membro della direzione strategica delle BR, entrambi parteciparono al rapimento di Moro. Naturalmente, non possono certo essere collocati sullo stesso piano di uno Zangheri, nemmeno per pura speculazione teorica, coloro i quali scelsero la politica dell’omicidio in tempo di pace in uno Stato democratico, seppure zoppicante e non privo di profonde ingiustizie, prima ancora che per ragioni morali, perché sarebbe antistorico. I “riformisti di Lenin” hanno fatto parte di un fenomeno storico di lungo periodo, avevano un profondo radicamento sociale, il terrorismo rosso, invece, di fronte alla propria impotenza ha rinunciato alla pazienza e alla tenacia della costruzione e ha scelto la scorciatoia dello scontro diretto, immediato con un presunto nemico. Ma non vi può essere dubbio alcuno, che si sia trattato di un seppure superficiale e sbrigativo attingere alla tradizione della Rivoluzione d’ottobre, tradizione che aveva continuato ad albergare nel partito comunista. Lo aveva ben spiegato Rossana Rossanda quando, in pieno rapimento Moro, aveva usato l’espressione “album di famiglia” (l’espressione è contenuta in Rossanda 1978a), suscitando un vespaio di polemiche, alle quali rispose pochi giorni dopo: “la requisitoria delle BR contro la Dc, nel loro secondo messaggio, ricalca stilemi veterocomunisti, mirando a trovare consensi nello spazio lasciato aperto dalla cessazione d’una analisi seria e d’una seria lotta del Partito comunista alla Democrazia cristiana” (Rossanda 1978b). Da par sua, Rossanda spiegava che si trattava solo di alcuni stilemi malamente scimmiottati, riportando la discussione ai più alti livelli teorici della storia del marxismo, ma la sua riflessione era chiara: il Pci da tempo non aveva elaborato una capacità di lettura della società e della politica, che aveva lasciato “spazi aperti” a ogni sorta di avventura.
Da quel momento iniziavano, almeno sul piano politico, gli anni Ottanta. Da parte dei comunisti si aveva la costruzione di una ipotesi di rinnovamento sociale separata, distinta e sempre più lontana dal sovietismo. E tuttavia permanevano sotto traccia, soprattutto perché in assenza di altro che non veniva elaborato, tratti ideologici profondi e che parevano irrinunciabili, che vedevano ancora nel Pcus se non il partito guida, il mito tangibile, l’eroe omerico fattosi uomo. Un’inclinazione ideologica, questa, che non divise il partito e i militanti in due gruppi, ma che attraversava i gruppi e l’animo politico di molti militanti.
Certo non di chi aveva aderito al Pci negli anni Settanta perché era un partito progressista non più stalinista e “amministrava bene”. La differenza era tra chi lasciava la III Internazionale alla dimensione di ascendenza remota e chi non era disposto ad accettarne un tramonto ormai sopravvenuto da tempo. Ciò che, in assenza di una riflessione articolata e capillare, partecipata e compresa, rischiava di lasciare, almeno in alcuni, soltanto la “fede”. Una fede ormai fuori tempo che veniva richiamata in retoriche esibite e in stereotipi frustri affastellati alla bell’e meglio. Una fede che aveva portato a importanti progressi sociali, ma che nel progressivo estinguersi della spinta rinnovatrice, finiva per restare solo “fede”, la consolazione dei deboli.
I comunisti, nonostante tutte le loro colpe, non meritavano una fine tanto triste. O forse sì, come aveva profetizzato Marx il quale, leggendo uno scritto di Hegel secondo cui i fatti del passato si presentano due volte, chiosò:
Ha dimenticato di aggiungere: la prima volta come tragedia, le seconda come farsa (Marx [1852] 1964).
Riferimenti bibliografici
- Andalò 2010
L. Andalò, I “magnacucchi” in Emilia Romagna. Un’eresia comunista e socialista (1951-1957), Cesena 2010. - Bianchini 2013
S. Bianchini (a cura di), Valdo Magnani e l’antistalinismo comunista, Milano 2013. - Bobbio 1992
N. Bobbio, Né con loro, né senza di loro, “Nuvole. Per la ragionevolezza dell’utopia” 2 (gennaio 1992). - Bobbio 1995
N. Bobbio, Eguaglianza e Libertà, Torino 1995. - “Il Bollettino del Coordinamento dei Comitati contro la Repressione” 1983
Sarà che avete nella testa un maledetto muro o Il Muro, manifesto della Conferenza interna d’Organizzazione di Prima Linea tenuta nel carcere di Torino, 9 giugno 1983, in “Il Bollettino del Coordinamento dei Comitati contro la Repressione” (settembre 1983). - Calvi 1973
G. Calvi, Giustizia e potere, Roma 1973. - “Il Comune di Bologna. Notiziario settimanale” 1967
Affettuose manifestazioni di Bologna città di pace a Valentina Tereskova prima donna nello spazio, “Il Comune di Bologna. Notiziario settimanale” VII, n. 33, 15 settembre 1967. - Conferenza regionale Pci 1959
Per il rinnovamento democratico e socialista dell’Emilia-Romagna e dell’Italia, conferenza regionale del Pci (Bologna, Salone del Podestà, 27-28-29 giugno 1959), Bologna 1959. - Crainz 2003
G. Crainz, Il paese mancato, Roma 2003. - Cucchi, Magnani 1995
A. Cucchi, V. Magnani, Crisi di una generazione, introduzione di M. Flores, Roma 1995. - De Felice 1966
R. De Felice, Mussolini il fascista. I. La conquista del potere 1921-1925, Torino 1966. - Ferretti 1982
V. Ferretti, Riformisti di Lenin. La cooperazione reggiana nel Secondo dopoguerra, prefazione di L. Casali, Reggio Emilia 1982. - Manni 2001
F. Manni, Il filosofo e i comunisti. Intervista a Norberto Bobbio, “Diario” VI, 4 maggio 2001. - Marx [1852] 1954
K. Marx, Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte [Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, New York 1852], Roma 1954. - Pansa 2008
G. Pansa, Quando Togliatti disse basta, “l’Espresso”, 19 maggio 2008. - Rossanda 1978a
R. Rossanda, Il discorso sulla Dc, “il Manifesto” 28 marzo 1978. - Rossanda 1978b
R. Rossanda, Il veterocomunismo della lotta armata, “il Manifesto” 2 aprile 1978. - Scirè 2012
G. Scirè, Gli indipendenti di sinistra. Una storia italiana dal Sessantotto a Tangentopoli, Roma 2012. - Thatcher 1987
M. Thatcher, interview edited by D. Keay, “Woman's Own”, 23rd September 1987. - Togliatti [1946] 1974
P. Togliatti, Ceto medio e Emilia rossa, discorso pronunciato a Reggio Emilia, a cura del Centro diffusione stampa del Pci, Roma 1946; ora in L. Arbizzani (a cura di), P. Togliatti, Politica nazionale e Emilia rossa, Roma 1974, 21-51. - Togliatti 1951
Intervista a Palmiro Togliatti, “L’Unità” 28 febbraio 1951, 1.
A contribution to the reflection on the crisis of the Italian left in the 1980s, which took place while the world was radically changing. In particular, it deals with the “duplicity” of the Italian Communist Party, between reformist/social-democratic political practices and revolutionary ideology of a third-internationalist stamp. The left was moving away from the Ussr but a mythical dimension of it remained. In the context of the history of the left, attention is drawn to the case of Reggio Emilia, a city and province with strong reformist socialist traditions, but also of strong radicalism.
keywords | Italian Left; Pci; Communism; Communist Party; Reggio Emilia.
questo numero di Engramma è a invito: la revisione dei saggi è stata affidata al comitato editoriale e all'international advisory board della rivista
Per citare questo articolo / To cite this article: L. Alessandrini, Reggio Emilia nella crisi della sinistra e delle sinistre negli anni Ottanta, “La Rivista di Engramma” n. 210, marzo 2024, pp. 55-59 | PDF