La tardiva e meritata scoperta di Sebastiano
Recensione alla mostra Sebastiano del Piombo 1485-1547
Roma, Palazzo Venezia, 8 febbraio - 18 maggio 2008; allestimento a cura di Luca Ronconi e Margherita Palli; mostra e catalogo a cura di Claudio Strinati, Motta, Milano 2008
Simona Dolari

Luitpold Dussler nella prefazione alla sua monografia su Sebastiano Luciani (Basilea 1942) scriveva: "a new monograph on the painter Sebastiano del Piombo needs no justification".
Effettivamente quale giustificazione si poteva richiedere allo studioso, quando fino a quel momento, a parte i coraggiosi Bernardini e D’Achiardi nel 1908, nessuno si era mai cimentato nella redazione di un catalogo della produzione del grande pittore veneziano? Sorte questa, che per ironia del vero non cambiò mai neanche con il passare dei decenni, come palesemente mostra la minima bibliografia critica, di cui per valore possiamo rammentare Pallucchini 1944, Lucco 1980, Hirst 1981. E che ha determinato un continuo rimbalzare di attribuzioni da Giorgione a Tiziano a Palma a Raffaello ma anche a Cima, per arrivare solo alla fine a Sebastiano, con un’indecisione a volte molto poco comprensibile, guardando il forte marchio stilistico che molti quadri mostrano.
All’interno di questo scenario, quindi, niente di strano che solo nel 2008 sia stata allestita la prima mostra monografica (Roma, Museo di Palazzo Venezia, 8 febbraio-2 giugno 2008; Berlin, Staatliche Museen zu Berlin - Gemäldegalerie, Kulturforum, Sonderausstellungshallen, 28 giugno-28 settembre 2008) con tanto di catalogo aggiornato (Motta Editore), di questo gigante della pittura, di cui, tra pregiudizi vari, pochissimi potranno negare le altissime doti sopratutto di ritrattista.
Pittore dalla difficile fortuna critica, vuoi per i giudizi a volte non generosi che lo bollarono “pittore pigro” (G. Vasari, Le Vite... 1568), vuoi per convenzioni ripetute e consolidate che lo vollero “povero di invenzione” e pertanto “aiutato” nelle sue opere piu’ importanti, vedi la Pietà di Viterbo, dal geniale e intoccabile Michelangelo (L. Lanzi, Storia pittorica dell’Italia, 1809), Sebastiano del Piombo per secoli è stato, se non dimenticato, compreso poco nella sua densa complessità artistica. Riconosciuto, da Carlo Volpe in poi, nel ruolo di alto mediatore fra l’antico e il moderno, fra tradizione e innovazione, passando pertanto nella sua fase veneziana dalle impostazioni belliniane alle tematiche giorgionesche, e nella fase romana dal classicismo raffaellesco alla potenza michelangiolesca, è spesso stato considerato dagli studiosi dediti alla cultura veneziana limitatamente alla sua permanenza in laguna fino al 1511, divenendo quindi oggetto di un’attenzione parziale per gli anni romani dal 1511 al 1547.
Tale la scansione riproposta anche in mostra, divisa pertanto in tre sezioni principali: "Sebastiano a Venezia", "Sebastiano a Roma" e "Sebastiano e la Controriforma". Scelta che sicuramente ha reso più comprensibile la visione ai visitatori o, come avrebbe detto Baldassare Castiglione, “ai fruitori”, ma che a mio avviso ha creato nuovamente una cesura troppo netta, che ostacola continuamente certi ragionamenti sulla figura dell’artista.
 In mostra, esposte fino al 2 giugno, circa ottanta opere provenienti dai maggiori musei del mondo, con l’esclusione di pochi capolavori di cui i più rappresentativi sono sicuramente il Clemente VII di Capodimonte e la Resurrezione di Lazzaro della National Gallery di Londra, opere certamente capitali nell’economia della produzione dell’artista. La prima, rimasta nella casa romana di Sebastiano fino alla sua morte (1547) e menzionata da Vasari come ritratto di Clemente VII “che allora non portava barba”, e l’altra, il mitico oggetto della contesa con Raffaello e la sua la Trasfigurazione (Pinacoteca Vaticana). Alla fine del 1516 a entrambi i pittori, come ricorderemo, fu affidata da Giulio dei Medici la commissione di realizzare una grande pala per la Cattedrale di Narbonne, sede vescovile del committente. L’iniziativa diede adito a un aperta e vera contesa tra i due pittori, e vide molti artisti dell’epoca schierarsi da una parte o dall’altra.
In mostra, esposte fino al 2 giugno, circa ottanta opere provenienti dai maggiori musei del mondo, con l’esclusione di pochi capolavori di cui i più rappresentativi sono sicuramente il Clemente VII di Capodimonte e la Resurrezione di Lazzaro della National Gallery di Londra, opere certamente capitali nell’economia della produzione dell’artista. La prima, rimasta nella casa romana di Sebastiano fino alla sua morte (1547) e menzionata da Vasari come ritratto di Clemente VII “che allora non portava barba”, e l’altra, il mitico oggetto della contesa con Raffaello e la sua la Trasfigurazione (Pinacoteca Vaticana). Alla fine del 1516 a entrambi i pittori, come ricorderemo, fu affidata da Giulio dei Medici la commissione di realizzare una grande pala per la Cattedrale di Narbonne, sede vescovile del committente. L’iniziativa diede adito a un aperta e vera contesa tra i due pittori, e vide molti artisti dell’epoca schierarsi da una parte o dall’altra.
“Bastiano”, come riporta Leonardo Sellajo in una lettera a Michelangelo, nel 1519 ha gia’ completato la sua opera, “una cosa mirabile”, che “fa miracholi e a fatto rovinare ognuno”. Raffaello la finirà nell’aprile del 1520, solo pochi giorni prima della sua morte. Due capolavori assoluti, nel caso del pittore perugino addirittura una sorta di testamento artistico, che in qualche modo segnerà il percorso dell’arte moderna. Infatti proprio alla fine di quel decennio, morto il Sanzio ancora nel pieno nell’età e nel pieno della fiducia di Leone X, e ormai evidente a tutti la supremazia del Buonarroti sulle tre arti anche a dispetto degli allievi di Raffaello, da Giulio Romano a Perino del Vaga e a Polidoro da Caravaggio, ma anche di Rosso e Parmigianino giunti nell’Urbe, Sebastiano diverrà a Roma, grazie alle sue capacità tecniche oltre che al sostegno del suo valente sostenitore, tra i più grandi e apprezzati pittori del suo tempo.
Ma a parte i grandi assenti, i capolavori in mostra sono tanti e straordinariamente seducenti, come del resto lo sono gran parte delle opere di Sebastiano. Complice sicuramente anche l’incredibile allestimento affidato a Margherita Palli e al noto regista teatrale Luca Ronconi, che per l'occasione ha veramente tirato fuori il meglio della sua esperienza e della sua fantasia immaginifica, conducendoci a vedere grandi quadri come in un suo teatro (sull'allestimento di Ronconi vedi il contributo di Katia Mazzucco in questo stesso numero di "Engramma").
Del resto come in un fantastico palcoscenico si può dire che i personaggi non mancavano, e i ruoli erano vari e variegati: per ogni opera una storia da leggere, comprendere e interpretare, in un gioco di sguardi che sopratutto i ritratti di Sebastiano non abbandonano mai, anzi sollecitano o meglio sfidano. Si tratta nella maggior parte dei casi di ritratti di ecclesiastici, mercanti, condottieri, nobildonne, sante: grandi figure dall’impianto piramidale, che occupano lo spazio della tela o della tavola quasi imponendosi, e limitando la superficie circostante a mero sfondo.
I personaggi, stanti o di tre quarti, in piedi o seduti, occupano il pieno della scena, spesso non entrano addirittura nei margini del quadro, enfatizzando con una forte ostentazione corporea o con un eloquente gioco di mani, il loro ruolo sociale e politico. Si pensi al Ritratto di Anton Francesco degli Albizzi (Houston, Museum of Fine Arts), al Ritratto del Cardinale Ferry Carandolet e del segretario (collezione Thyssen-Bornemisza), al presunto Ritratto di Cristoforo Colombo (New York, Metropolitan Museum of Art), all’Andrea Doria (Roma, Galleria Doria Pamphili) ma sopratutto al quel dipinto strordinario che, durante i mesi dell'allestimento romano, ha affascinato e attratto e visitatori della mostra sotto forma di poster e di locandina pubblicitaria, che è il Ritratto d’uomo in arme di Hartford. Una staordinaria capigliatura irsuta e selvaggia, quasi 'barbarica', una armatura lucente di acciaio bianco che mette in luce una metà del volto mentre l’altra metà è in ombra, e uno sguardo diretto così seducente che cattura il desiderio degli spettatori di ogni genere (e che quindi con grande difficoltà si lascia leggere attraverso la chiave univocamente omosessuale identificata proposta da Mauro Lucco).
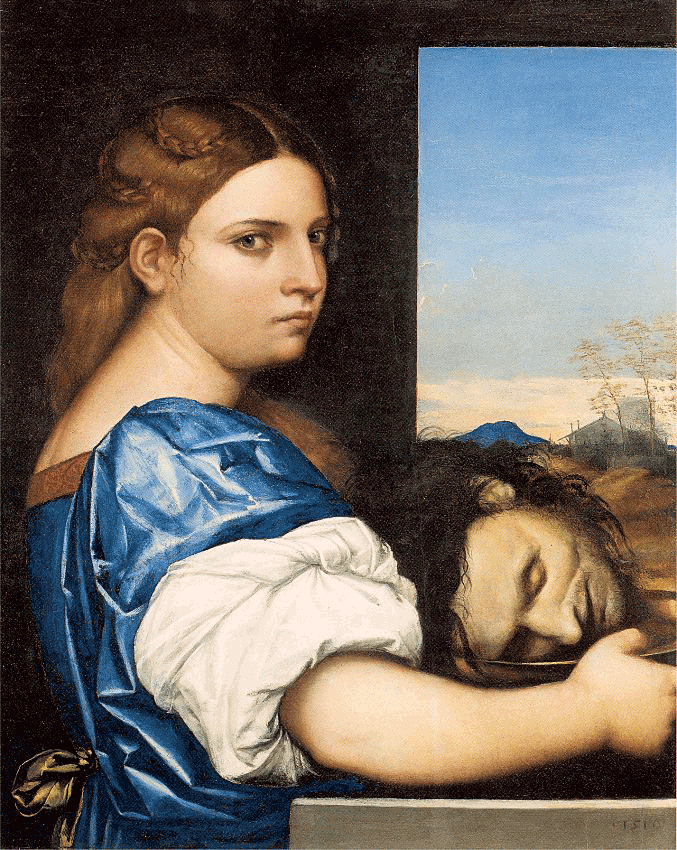 Accanto a questo, sempre rimanendo nella schiera dei grandi ritratti, non possiamo fare a meno di tralasciare quel ritratto di Salomè oggi alla National Gallery di Londra, che il già citato Lucco così, nel 1980, descriveva: “fissa sullo spettatore uno sguardo innocente e tranquillo. L’afa che corrode gli alberetti sottili, il languore del soffocante tramonto estivo, annegano, smorzano la crudeltà e l’orrore del scena”.
Accanto a questo, sempre rimanendo nella schiera dei grandi ritratti, non possiamo fare a meno di tralasciare quel ritratto di Salomè oggi alla National Gallery di Londra, che il già citato Lucco così, nel 1980, descriveva: “fissa sullo spettatore uno sguardo innocente e tranquillo. L’afa che corrode gli alberetti sottili, il languore del soffocante tramonto estivo, annegano, smorzano la crudeltà e l’orrore del scena”.
Sguardo tranquillo, forse, quello di questa mitica fanciulla assassina, ma non certo "innocente": raramente nella storia della pittura cinquecentesca abbiamo incontrato un viso così sottilmente inquietante come quello di questa straordinaria Salomè. Certamente appare calma, e forse "tranquilla", a patto però che vogliamo riconoscerle la serenità di una delle migliori eroine di Hitchock che ha appena compiuto il delitto perfetto. La fisionomia del volto ripropone i caratteristici tratti delle figure femminili di Sebastiano: viso molto tondo e decisamente largo soprattutto all’altezza degli zigomi, mento piccolissimo e leggermente sfuggente, naso importante e dritto, e soprattutto i tipici occhi dal taglio molto allungato, che sembrano qui fissare in maniera quasi sfrontata chi, con un cenno, ha forse fermato il suo cammino e l’ha obbligata a una pausa: l'attimo di cui l'artista coglie la posa.
Salomè sta infatti poggiando l'argenteo vassoio che reca la testa madida di sudore del Battista su un parapetto, e una leggera torsione del collo, causata forse da un richiamo di uno spettatore impertinente (noi, che la guardiamo), provoca due straordinarie pieghe nella morbida carne, accesa come la parte alta del volto dal riflesso pelaceo di un vestito di seta blu cielo 'notte di mezza estate', con un risvolto bianco che, a distanza di secoli, inebria di sensuale compassione tutti quanti noi ci soffermiamo ad ammirare il dipinto.
Le opere narrative, quasi tutte di argomento religioso, rispetto ai ritratti hanno sempre molto meno convinto la critica, soprattutto in relazione all’originalità grafica e compositiva dei lavori.
 Un esempio eclatante: la celeberrima Pietà di Viterbo; il quadro sul quale il Luciani ha fondato quasi tutta la sua postuma fama, e che anche per la sua vicenda dovette costituire la base robusta e decisiva della sua, tardiva ma oramai decisamente crescente, reputazione. La diatriba intorno alla paternità michelangiolesca dell’idea di fondo o dell’intero disegno, che prende le mosse dal testo vasariano, è molto nota, ma appare assai poco credibile e decisamente semplicistica, esito scolastico della costante furia di deferire praticamente ogni opera o dettaglio di valore a Michelangelo. Intervenire ora in merito all'annosa questione certamente non è appropriato: è certo che tra i due artisti intercorsero scambi di idee grafiche nel lungo rapporto di amicizia che li legò per anni, come del resto i diversi disegni conservati ed esposti anche in questa occasione mostrano, ma privare il catalogo di un artista del calibro di Sebastiano di una tale opera è certamente riduttivo.
Un esempio eclatante: la celeberrima Pietà di Viterbo; il quadro sul quale il Luciani ha fondato quasi tutta la sua postuma fama, e che anche per la sua vicenda dovette costituire la base robusta e decisiva della sua, tardiva ma oramai decisamente crescente, reputazione. La diatriba intorno alla paternità michelangiolesca dell’idea di fondo o dell’intero disegno, che prende le mosse dal testo vasariano, è molto nota, ma appare assai poco credibile e decisamente semplicistica, esito scolastico della costante furia di deferire praticamente ogni opera o dettaglio di valore a Michelangelo. Intervenire ora in merito all'annosa questione certamente non è appropriato: è certo che tra i due artisti intercorsero scambi di idee grafiche nel lungo rapporto di amicizia che li legò per anni, come del resto i diversi disegni conservati ed esposti anche in questa occasione mostrano, ma privare il catalogo di un artista del calibro di Sebastiano di una tale opera è certamente riduttivo.
E ciò che conta, al di là di ogni sterile discussione è che la Pietà rimane uno dei dipinti più potenti e importanti dell’estetica e del pensiero religioso rinascimentale. Il corpo di Cristo straordinariamente bello, dotato della potenza anatomica michelangiolesca, ma anche di una grazia e di una sensibilità del miglior Raffaello, Lotto e Bellini, è offerto al fedele come un dono sacrificale. Non c’è dolore straziante, c’è sublime accetazione di qualcosa che viene dall’alto, a cui Maria, qui potente come la più bella Mater matuta, quasi a testimoniare il sublime diniego della maternità negata nella morte del suo frutto, rivolge lo sguardo e le mani giunte. Uno sfondo cupo e notturno accoglie la scena, un silenzio deserto e tombale in cui si scorgono solo i resti di una città diroccata e alberi in ombra, e una tenue luna piena apparsa in uno squarcio di sereno tra le nuvole, assistono innocui. Qualcosa di irreparabile è accaduto: una nefasta tragedia, che pietrifica per sempre i personaggi, si è svolta.
Ora non c’è più tempo per l’azione come nelle prime opere del pittore veneziano. Nel giovanile Giudizio di Salomone di Kingston Lacy, fatto per la “casa Grimana di San Ermacora”, finalmente qui esposto per la gioia dei nostri occhi dopo anni di oscurantismo, il giovane Sebastiano raccontava la bella storia del Libro dei Re, in cui il re Salomone, ascoltata la storia delle due madri, sentenziava che il bimbo vivo venisse tagliato e datone metà per donna. Nel dipinto, incompiuto forse per la precipitosa partenza di Sebastiano per Roma, le figure dei bambini mancano, la scena è colta nel momento in cui la vera madre preferisce cedere all’altra il proprio figlio piuttosto che vederlo ucciso. Qui l’azione è tutta in fieri, c’è ancora tempo di agire e di cambiare la storia: l’esecutore della pena nella sua statuaria bellezza e nudità si sta muovendo, i suoi muscoli sono tesi, sia quelli delle gambe che quelli delle braccia, ma il colpo non è stato ancora dato, le madri continuano a parlare, e il re invece, alto sul podio, medita silenzioso. La magnifica quinta costruita dalla più perfetta delle prospettive, ci porta nella scena, il sipario è aperto. La storia si racconta come una grandiosa scena teatrale: in silenzio guardiamo.
Solo un appunto: molte delle opere sono parse un po’ troppo restaurate, e forse un po’ troppo uniformate secondo un canone di brillantezza a volte poco cinquecentesco. Sarebbe stato utile conoscere qualche cosa di più su questa scelta tecnica, nell'allestimento e nel catalogo troppo trascurata. Infine: molto belli i disegni in mostra e importanti da punto di vista contenutistico, ma da nessuna parte si leggeva un'informazione critica fondamentale, e cioè che, come scriveva già nell’86 Freedberg, molti dei disegni per decenni attribuiti totalmente a Michelangelo hanno in realtà un’autografia ancora tutta da accertare. Ma bene così, del resto Sebastiano è un artista ancora molto da studiare, e questo è sempre l’invito più bello che un pittore ci lancia, e che questa mostra con i suoi mille indizi irrisolti ci lascia come spunto di approfondimento e di ricerca.
Per citare questo articolo / To cite this article: S. Dolari, La tardiva e meritata scoperta di Sebastiano. Recensione alla mostra Sebastiano del Piombo 1485-1547, “La Rivista di Engramma” n. 65, giugno/luglio 2008, pp. 63-70 | PDF