“Cinema di prosa” e “cinema di poesia”, tertium datur
Su Pier Paolo Pasolini e I pugni in tasca di Marco Bellocchio
Silvia De Laude
English abstract
- Se dovesse fare il bilancio della sua attuale filosofia,
della sua ideologia “poetica”?
- È una domanda disumana.
(P.P. Pasolini, dichiarazione a Jean Duflot, 1970)
Nella vulgata delle chiacchiere e dei convegni,
Pasolini è presentato come un propugnatore del “cinema di poesia”:
nei testi, Pasolini giudica negativamente il “cinema di poesia”
(cioè il cinema costruito secondo la lingua della poesia)
perché ci vede una “scuola internazionale” di élitarismo snob – il cinema
che lo interessa è invece costruito con la semplicità sintattica della prosa,
ma una prosa capace di testimoniare che la poesia esiste nella Realtà.
(W. Siti, Tracce scritte di un’opera vivente, 1998)
Uno “scambio epistolare” fittizio
Nel 1967, due anni dopo l’uscita del film, esce da Garzanti la sceneggiatura de I pugni in tasca, preceduta da uno “scambio epistolare” fra Pier Paolo Pasolini e Marco Bellocchio (Bellocchio 1967, 9-24, Pasolini [1967b] 1999, II, 2800-2815). Il volume è il quarto titolo della collana “Film e discussioni”, diretta dallo stesso Pasolini e curata dal critico cinematografico Giacomo Gambetti. I titoli precedenti della collana erano stati Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, E venne un uomo di Ermanno Olmi (aperto da un saggio di Pasolini) e Uccellacci e uccellini, ancora di Pasolini.

1 | Il volume della sceneggiatura de I pugni in tasca nella collana “Film e discussioni” diretta da Pier Paolo Pasolini.
All’inizio del volume, Gambetti firma un’avvertenza che giustifica la scelta di presentare la sceneggiatura di un film già apparso nelle sale, a differenza di quanto era avvenuto con Il Vangelo, con E venne un uomo e con Uccellacci e uccellini. L’eccezione è imputata alla straordinaria rilevanza de I pugni in tasca, “il cui interesse va oltre le circostanze immediate dell’attualità e della novità”:
Per la prima volta in questa collana esce un volume su un film non inedito, anzi da tempo già noto al pubblico e alla critica.
Ci sembra in realtà che I pugni in tasca sia meritevole di particolare considerazione. Si tratta infatti di un’opera il cui interesse va oltre le circostanze immediate dell’attualità e della novità, per portare numerosi elementi di analisi critica – come pochissimi altri film, quest’anno – in tutto l’ambiente stagnante del cinema italiano, e non soltanto italiano. Un’opera che vale la pena – al di là delle opinioni che può suscitare e che sono state e saranno sanamente, vivacemente contrastanti, dall’esaltazione indiscussa fino alle maggiori riserve – analizzare nella personalità del suo autore, nei suoi motivi di origine e di sviluppo, nelle sue componenti ambientali.
Per questo abbiamo ritenuto utile raccogliere su I pugni in tasca il materiale che ora presentiamo, per documentare – nella linea di “Film e discussioni” – le ragioni di un avvenimento così partecipe della evoluzione della nostra cultura (Bellocchio 1967, 7).
Oltre alla sceneggiatura, ai dialoghi definitivi del film e ai testi presentati nel volume come Uno scambio epistolare Pasolini-Bellocchio (quattro a firma di Pasolini, e tre a firma di Bellocchio), il volume comprende una lunga intervista di Gambetti al giovane regista de I pugni in tasca (Marco Bellocchio contro il “sentimento”, ivi, 25-51), un intervento di Pio Baldelli (“I pugni in tasca” e il cinema di oggi, ivi, 54-67) e ventisei tavole fuori testo con fotografie di scena, o legate alla lavorazione e ai luoghi del film.
In una nota, Gambetti presenta lo “scambio epistolare” così:
Un colloquio epistolare, fra uno scrittore e regista che ama il cinema giovane, che del cinema anticonformista è fra i rappresentanti più avanzati e appassionati, e uno dei pochi giovani che in Italia con maggiore coraggio e clamore si sono posti a fare, a provocare, con la forza dei loro vent’anni, non avendo vissuto il fascismo e il neorealismo. Quelli della “rabbia” e dello “scandalo” non sono che due dei grandi elementi di discussione de I pugni in tasca. Se Pasolini e Bellocchio li hanno preferiti ad altri, è perché essi servono assai bene a rompere i luoghi comuni: obiettivo che sta loro molto a cuore e a cui punta da sempre la miglior tradizione del cinema italiano (n.d.c.) (Bellocchio 1967, 10).
Le cose, riguardo al “colloquio”, sono in realtà un po’ più complicate. Le quattro lettere di Pasolini a Bellocchio non compaiono nell’edizione a cura di Nico Naldini (Pasolini [1955-1975] 1988). Non sono infatti vere lettere, ma momenti di uno scambio epistolare fittizio, nato per introdurre la sceneggiatura. La prima – lo vedremo più avanti – è la ripresa puntuale, giusto adattata ai modi epistolari, dell’intervento di Pasolini al dibattito su I pugni in tasca che si era svolto a Roma il 16 marzo del 1966 nella sede dell’associazione Italia-Urss, per iniziativa del Circolo culturale Ludovisi. Lo riporta integralmente “Rinascita” il 2 aprile, in un ampio servizio dal titolo Dibattito su “I pugni in tasca”. Cinema di prosa e cinema di poesia.

2 | La pagina di “Rinascita”, 2 aprile 1966, che riporta l’intervento di Pasolini al dibattito romano su I pugni in tasca organizzato dal Circolo culturale Ludovisi (16 marzo 1966).
Insieme al regista de I pugni in tasca e a Paolo Alatri, presidente dell’associazione Italia-Urss, avevano preso la parola il regista Elio Petri e lo storico Roberto Giammanco. Tra i presenti, “scrittori, studenti e pubblico abituale delle sale cinematografiche”. Già il 17 marzo, aveva reso conto dell’intervento di Pasolini, in veste di cronista cinematografico, Dario Argento, presentando l’incontro organizzato dal Circolo Ludovisi come “uno dei più accesi, interessanti, vivaci, appassionanti dibattiti di questi ultimi tempi”:
Quindi ha preso la parola Pier Paolo Pasolini, che ha condotto un’illuminante relazione sulle fonti di ispirazione de I pugni in tasca. Inquadrando il film in un contesto culturale, Pasolini ha subito ricordato che il cinema va diviso in cinema di poesia e cinema di prosa. Nel cinema di prosa lo stile non ha valore primario e lo spettatore non deve notare la macchina da presa e il montaggio. Il cinema di poesia, invece, lascia intravedere uno stile preciso e rende il montaggio evidente. Godard e Bernardo Bertolucci sono registi di poesia. Bellocchio realizza film di prosa, ma con sfumature nella poesia. Per definire Bellocchio ci si può riferire al neorealismo o al realismo socialista? No. Ai film alla Antonioni? No. Bellocchio rappresenta un'alternativa culturale ai dieci anni che ci hanno preceduto. Richiesto se egli condivide l’opinione di Pasolini che classifica il suo film come un film di prosa, Bellocchio ha risposto affermativamente (Argento [1966] 2000, 6).
Marco Bellocchio, dal canto suo, ha dichiarato a più riprese che le risposte alle ‘missive’ pasoliniane erano state opera del fratello maggiore Piergiorgio e di Grazia Cherchi:
Devo dire […] che quelle lettere non le scrissi io, risposero mio fratello Piergiorgio, che era direttore dei “Quaderni piacentini”, e Grazia Cherchi. Non avevo la scrittura giusta per contrappormi a Pier Paolo, non avevo un apparato critico adeguato, potevo argomentare sulla pittura, magari rispondere in poesia, ma ovviamente condivido ancor oggi le ‘nostre’ risposte (Bellocchio 1995, 71).
Cosa ci dice allora oggi, sul film, questo singolare scambio di lettere? E cosa su Pasolini, nell’atto di intervenire sul folgorante esordio di Marco Bellocchio? Nonostante la sua natura doppiamente ‘fittizia’ (una prefazione in forma di carteggio, in cui la lettera introduttiva è il reimpiego di un intervento pubblico, e uno dei due interlocutori parla con più voci), credo ancora moltissimo.
La scelta della forma epistolare
Da parte di Pasolini, non sorprende l’interesse per il film che come un meteorite capitato da chissà dove era riuscito a smuovere le acque stagnanti del cinema italiano, dimostrando la possibilità di “una specie di esaltazione della abnormità e della anormalità contro la norma del vivere borghese, familiare” – “una rabbiosa rivolta dall’interno del mondo borghese” (Pasolini 1999, 2802), senza il bisogno di fughe in un altrove variamente ‘mitico’. Sarebbe stato sorprendente, piuttosto, che Pasolini non prendesse posizione su un film che aveva fatto discutere, fra l’altro, letterati come Alberto Moravia, Mario Soldati e Italo Calvino, a cui si deve sul giovanissimo autore de I pugni in tasca un’osservazione molto acuta: “ha messo su una costruzione autosufficiente e dotata di quella particolare autorità per cui, per il solo fatto di essere lì, disturba fortemente tutto quello che c’è intorno” (Calvino [1966] 1988, 227; cfr. anche Moravia [1966] 2005 e Soldati 1966).
Quanto alla soluzione di introdurre nella collana da lui diretta la sceneggiatura de I pugni in tasca in una forma non canonica, quale appunto un carteggio costruito a tavolino, è da osservare che si tratta di una scelta in linea con una tendenza alla contaminazione e allo scambio delle marche di genere che si manifesta nella sua produzione fin dal periodo friulano, ma acquista progressivamente perentorietà e consapevolezza proprio a partire dalla metà degli anni Sessanta.
Nel campo della saggistica, già nel 1957 l’intervento critico chiesto dall’amica pittrice Anna Salvatore per il catalogo di una sua mostra romana, dove figurano anche scritti di Alberto Moravia e Federico Fellini, è sostituito da una poesia in terzine nei modi delle Ceneri di Gramsci, preceduta da una breve premessa:
Cara Anna, ti mando una poesia invece che una nota critica. Mi è riuscita meglio. Occorre che te ne spieghi le ragioni? (Siti et alii 2003, I, 1645).
Più tardi, si moltiplicano gli “appunti” per saggi da scrivere. Un caso estremo è Appunti con molti punti per ecc. (ora in Pasolini [1974] 1999, 2662-2665), introduzione nella collana mondadoriana dello “Specchio” a Le betulle nane di Evgenij Evtušenko, che si presenta in effetti come lunga e caotica enumerazione di argomenti da sviluppare. Ma Appunti “en poète” per una linguistica marxista è il sottotitolo del saggio Dal laboratorio, fra i più complessi di Empirismo eretico; e nella stessa raccolta, il saggio sul discorso indiretto libero posto in apertura della sezione Letteratura prende le mosse dallo studio di Giulio Herczeg sullo stile indiretto libero in italiano (Herczeg 1972), e si presenta fin dall’attacco come una ‘non-recensione’: piuttosto, “un agglomerato di appunti e di excursus – quelli che si fanno ai margini di un libro” (Pasolini [1965d] 2001, 1345).
Gli “appunti” possono anche prendere la forma di un “diario”, come in Diario al registratore, in Lettura in forma di giornale del “Gazzarra” o nel postumo Diario del “caso Lavorini”, che Pasolini aveva inviato al direttore di un periodico con una lettera di accompagnamento che comincia così:
Gentile direttore,
poiché penso che nessun altro giornale o settimanale italiano accoglierebbe questi miei frammenti di diario, li mando a Lei, anche se alcuni sono in poesia, e quindi inusitati per il suo lettore (ma spero che la prosa serva a chiarire i punti oscuri e difficili della poesia) (De Laude-Siti 1999, 1751).
Non sono escluse complicazioni ulteriori, in scritti, dove il genere epistolare e quello della trascrizione da nastro magnetofonico (“la mia ultima scoperta stilistica”) sono combinati per intervenire senza perder tempo in una polemica sollevata sull’“Espresso” da Alberto Moravia e Guido Piovene sui termini “sperimentalismo” e “realismo”:
Caro Alberto,
finalmente posso parlarti a voce bassissima. Senza che tu m’interrompa. Sono solo nella mia stanza di fronte al registratore: che, come ti dicevo ieri sera, è la mia ultima scoperta stilistica. Non è molto dignitoso parlare a voce alta da soli, senza “cavia”, però data la mia situazione di lavoro, non ho altra scelta per poter intervenire nella polemica “sperimentalismo e realismo”, che tu e Piovene avete inaugurato sull’“Espresso”, e in cui vorrei proprio intervenire, benché materialmente, a causa delle circostanze di lavoro, debba intervenirci male: parlando così, come un matto, davanti al nastrino giapponese. […] (Che atroce orgia di terminologie volgari! Ma devi scusarmi, parlo, e non scrivo, e parlo in fretta. L’importante è capirci) (Pasolini [1963] 1999, 2771-2774).
Qualcosa di simile avviene, in parallelo, negli altri generi nei quali Pasolini esercita il suo talento di “ergastolano della propria vocazione”. Troviamo, nel cinema, “appunti” per film ‘da farsi’ (Appunti per un film sull’India, Appunti per un’Orestiade africana; Appunti per un film su san Paolo; Appunto per un poema su Terzo Mondo). In poesia, “appunti” per versi da scrivere (gli Appunti con una romanza, gli Appunti per un romanzo sull’immondezza, gli Appunti per una “Ballata per Gadda”, l’Appunto per una poesia in lappone, l’Appunto per una poesia in terrone, l’Appunto per uno sproloquio o gli Appunti per un poema da farsi – sottotitolo del poemetto postumo con calligrammi F.). Nel filone della narrativa, gli Appunti per il libro che seguirà a “Una vita violenta” e i racconti “fatti”, “da farsi” e “non fatti” di Alì dagli occhi azzurri (Pasolini [1965c] 2001, 2458-2459), uno dei quali, Appunti per un poema popolare, include sezioni in versi.
Come quella dell’“appunto”, del “diario”, del “giornale” o della “lettura cronologica” (questa, nel corpo del testo, la definizione della recensione a Il Gazzarra di Massimo Ferretti; Pasolini [1967] 1999, 2473), la forma della lettera consente di lasciare spazio al provvisorio, all’urgenza di esprimersi a caldo senza esaurire un argomento, e tenendo aperta la possibilità di tornarci sopra.
È così che, nello “scambio epistolare” su I pugni in tasca, Pasolini giustifica l’astensione da un esame di tipo “stilistico-filologico” del film: il tipo di “esame”, cioè, che lui stesso considerava il più adatto ad affrontare criticamente il cinema, il ‘genere’ sceneggiatura e quel “vero e proprio monstrum delle nuove lettere” che è la sua riscrittura della sceneggiatura in forma narrativa.
Se ne era convinto prima ancora di girare Accattone, come risulta da una lettera indirizzata nel 1959 a Edoardo Bruno, nel sottoporgli in vista della pubblicazione su “Filmcritica” due episodi tratti dalla sua sceneggiatura della Notte brava, per Mauro Bolognini:
Il primo brano servirà di introduzione e di campione per il “filologo” (quando, finalmente ci si occuperà di cinema filologicamente) che volesse operare dei confronti fra il testo scritto e il testo girato (Pasolini [1955-1975] 1988, 465).
Lo aveva ribadito, qualche anno più tardi, nel Diario al registratore steso durante la lavorazione di Mamma Roma, dove la mancanza di “gusto filologico” e attenzione agli “accorgimenti tecnici” del testo filmico è presentato come “il più grave difetto della critica cinematografica” (Pasolini [1957] 1998, 1845), e in termini non meno drastici in un dibattito tenuto nel 1964 alla Scuola Sperimentale di Cinematografia di Roma (Pasolini [1964] 2001, 2878-2879).
Ma “non c’è il modo, ora”. Non è una lettera, nella fictio dello scambio epistolare, la sede giusta per un esame “filologico-stilistico” del film, come non era la sede giusta, nel testo già apparso su “Rinascita”, l’intervento a un dibattito. Riporto qui insieme l’inizio della prima ‘lettera’, sulla quale mi concentrerò qui, e l’inizio dell’intervento apparso su “Rinascita”, che si può leggere integralmente in Appendice):
Caro Bellocchio,
non le farò un discorso particolare, sul suo film, tanto più che non c’è il modo, ora, di condurre un esame, come a me piace, filologico-stilistico sul testo. Le farò, però, e spero che questo le interessi, un discorso in generale, che ho già iniziato altrove. Cioè io vorrei inquadrare il film in una situazione culturale che in qualche modo lo supera, lo trascende, lo include, lo implica – e mi riallaccerò quindi a certi miei discorsi, a certi miei ragionamenti teorici fatti a più riprese e che hanno come centro l’individuazione della nascita del cosiddetto cinema di poesia (Pasolini 1999, 2800).
Non farò un discorso particolare sul film di Bellocchio, non ne farò una recensione, come del resto non l’ha fatta nemmeno Petri, perché di questo film si è già parlato, credo, in questi mesi, in molte sedi, e molti l’hanno già visto: quindi credo sia inutile soffermarsi sul film in quanto opera particolare, tanto più che appunto non ho avuto il tempo di condurre un esame particolare, come a me piace, cioè filologico-stilistico, sul testo. Farò dunque sul film di Bellocchio, e spero che questo discorso interessi anche all’autore, un discorso più generale, cioè io inquadrerei il film in una situazione culturale che in qualche modo lo supera, lo trascende, lo include, lo implica, e mi riallaccerò quindi a certi miei discorsi, a certi miei ragionamenti teorici fatti a più riprese e che hanno come centro l’individuazione della nascita del cosiddetto cinema di poesia (Pasolini 1966, 26).
L’urgenza, per Pasolini, è un’altra, anche se per un confronto “fra il testo scritto e il testo girato” il volume Garzanti si premura di offrire al lettore i materiali che lo rendono possibile:
Pubblichiamo, per fornire materia di informazione e di studio, la sceneggiatura più completa, con ciò che nel film non è rimasto e anche ciò che non è stato girato o non è stato montato. I dialoghi che in seguito riportiamo integralmente danno comunque un preciso elemento di confronto col film nella sua stesura definitiva (n.d.c.) (Bellocchio 1967, 70).
Anche a costo di mettere fra parentesi le regole pur enunciate della buona educazione critica, quello che davvero preme a Pasolini è di interrogarsi attraverso il film di Bellocchio sulle caratteristiche del linguaggio cinematografico, e di verificare l’efficacia dei “ragionamenti teorici” che lo stavano occupando da qualche tempo intorno alla “nascita del cosiddetto cinema di poesia”. Ci torneremo.
Dramatis personae
Due parole, intanto, sugli interlocutori, all’altezza dello “scambio epistolare”. Nel 1965, all’uscita de I pugni in tasca, il talentuosissimo Marco Bellocchio aveva venticinque anni, solo tre più di Bernardo Bertolucci – affine e diverso, una di quelle “gemellarità litigiose” da cui era incantato fenomenologicamente Cesare Garboli. Era – nelle parole di Giacomo Gambetti, certo sorvegliate, nel volume Garzanti, dallo stesso Pasolini – uno dei giovani “che in Italia con maggiore coraggio e clamore si sono posti a fare, a provocare, con la forza dei loro vent’anni, non avendo vissuto il fascismo e il neorealismo” (Bellocchio 1967, 10). Anche lui, come Bernardo Bertolucci, prima di dedicarsi al cinema aveva pubblicato poesie, sui “Quaderni piacentini” e altrove (alcune si leggono in Malanga 1998, 65-76). Prima de I pugni in tasca, aveva realizzato solo tre cortometraggi, di cui uno, Abbasso il zio, gli era valso una borsa di studio a Londra presso la Slade School of Fine Arts, dove aveva discusso una tesi sui metodi di Antonioni e Bresson nel lavoro con l’attore. La proposta di pubblicare la sceneggiatura del suo primo film nella collana “Film e discussioni” gli era arrivata l’anno dopo l’uscita nelle sale e la presentazione a Locarno e Venezia. La stessa collana non aveva accolto in precedenza – e qualcosa vorrà dire, la sceneggiatura del secondo film di Bertolucci, Prima della rivoluzione (con sceneggiatura dello stesso Bertolucci e di Gianni Amico), del 1964.
Pasolini, nel ’65, di anni ne aveva quarantatré, e già la differenza d’età gli cuciva addosso il ruolo di fratello maggiore. Nel cinema aveva esordito da non molto, ma bruciando le tappe: del 1961 è Accattone; del 1962, Mamma Roma; del 1963, La rabbia e La ricotta; del 1964, Il Vangelo secondo Matteo e Comizi d’amore (senza considerare il contributo a film di altri e i Sopralluoghi sul Vangelo, risultato di un montaggio di riprese effettuate in Terra Santa in vista della realizzazione del film, che sarebbe stato poi girato altrove).
È al cinema che negli anni Sessanta stava dedicando la maggior parte delle sue energie di “ergastolano della propria vocazione”, a discapito dei linguaggi in cui si era sperimentato in precedenza. Sul versante della narrativa, all’uscita di Una vita violenta nel 1959 era seguito un momento di impasse. Notavamo con Walter Siti, lavorando alle opere complete nella collana dei “Meridiani”, che scegliendo per la sua recensione a Una vita violenta il titolo Un romanzo aperto verso l’avvenire, Carlo Salinari aveva colpito con icastica precisione, esattamente, il contrario della verità, al punto di rasentare la profezia iettatoria (Siti 1998, CXXXIII). Anche sul versante della poesia, gli anni fra il 1964 e il 1968 sono di un lungo silenzio, anomalo per un poeta prolifico come lui. C’è per la verità un’eccezione, il lungo poemetto auto-bio-bibliografico Poeta delle Ceneri (titolo alternativo, Who is me), pensato come risposta all’intervista (immaginaria?) da parte di un critico statunitense (Pasolini [1967] 2003). Un poemetto “brutale, episodico, intenzionalmente epidittico per la volontà di presentarsi a un pubblico nuovo, quello americano, che non lo conosceva probabilmente che come cineasta” (Gelli 2010, 10), dove “inevitabile”, tra le domande “prevedibili”, è quella che riguarda l’abbandono della letteratura, per passare al cinema, per il quale sono date tre risposte: 1) il bisogno di cambiare modo di espressione, visto che la sua nevrosi lo costringeva a ripetere ossessivamente gli stessi motivi; 2) il bisogno di scegliere uno strumento espressivo non legato ai limiti nazionali, visto che la poesia, che pure si pretende assoluta, è di fatto incomprensibile oltre i confini; 3) il bisogno di calarsi direttamente nella lingua della “vita che si rappresenta”.
Qui di séguito, qualche frammento del poemetto – versi “in uno stile non poetico”, rivolti all’immaginario interlocutore perché non lo leggesse “come si legge un poeta”:
Nel ’60 ho poi girato il mio primo film, che,
come ho detto, s’intitola Accattone.
Perché sono passato dalla letteratura al cinema?
Questa è, nelle domande prevedibili di un’intervista,
una domanda inevitabile: e lo è stata.
Rispondevo dunque ch’era per cambiare tecnica,
che io avevo bisogno di una nuova tecnica per dire una cosa nuova,
o, il contrario, che dicevo la stessa cosa, sempre, e perciò
dovevo cambiare tecnica: secondo le varianti dell’ossessione (Pasolini [1967] 2003, 1271-1272).
Ma ero solo in parte sincero nel dare questa risposta:
il vero di essa era in quello che avevo fatto fino allora.
Poi mi accorsi
che non si trattava di una tecnica letteraria, quasi
appartenente alla stessa lingua con cui si scrive:
ma era, essa stessa una lingua...
E allora dissi le ragioni oscure
che presiedettero alla mia scelta:
quante volte rabbiosamente e avventatamente
avevo detto di voler rinunciare alla mia cittadinanza italiana!
Ebbene, abbandonando la lingua italiana, e con essa,
un po’ alla volta, la letteratura,
io rinunciavo alla mia nazionalità (ivi, 1271-1272).
Vi ho raccontato queste cose
in uno stile non poetico
perché tu non mi leggessi come si legge un poeta.
[…]. Ma non ero del tutto
sincero, ancora.
Poiché il cinema non è solo un’esperienza linguistica,
ma, proprio in quanto ricerca linguistica, è un’esperienza filosofica.
[…] La lingua dell’azione, della vita che si rappresenta
è così infinitamente più affascinante!
È essa che si ricostituisce – appena chiuso –
da un libro di versi: essa è prima e dopo:
in mezzo c’è un veicolo espressivo
che la evoca, ecco tutto. Opera di stregoni (ivi, 1275-1276).
Sulla prima ragione, non c’è molto da dire, se non che testimonia quale chiarezza Pasolini abbia ormai raggiunto nell’autoanalisi, ma nel resto del discorso, oltre al sollievo della liberazione dal codice della lingua italiana mediante la trans-nazionalità dell’immagine, “è da notare il rifiuto di ogni assolutezza stilistica, di quella decisione per cui si esclude tutto ciò che non appartiene alla Legge del testo” (Siti 1981, 154). Un rifiuto fatto a favore di un continuum che aderisce alla continuità del reale, e porta a interrogarsi sulla dose di “realtà” che può entrare in un film e quella che ne deve restare fuori: il modo, cioè, in cui un testo si ritaglia in un continuum con il quale deve comunque fare i conti (magari capovolgendo le regole del gioco, ed esibendo magari la propria impotenza a catturarlo).
Si colloca su questo sfondo la riflessione sul “cinema di poesia”, nozione famigerata e spesso fraintesa, oggetto di continui ripensamenti da quando Pasolini la aveva esposta, proprio l’anno dell’uscita de I pugni in tasca, alla tavola rotonda su Critica e nuovo cinema tenuta durante la prima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, che si era svolta tra il 29 maggio e il 31 giugno. Il testo letto a Pesaro, e ripreso in Empirismo eretico, era apparso in forma integrale insieme agli altri contributi alla tavola rotonda nell’aprile del 1966, in un numero quadruplo della rivista “Marcatré” (Pasolini [1966a] 1999), quando già ne erano state pubblicate, col titolo Il “cinema di poesia”, almeno due anticipazioni – su “Filmcritica” (Pasolini 1965), e nel volume Garzanti di Uccellacci e uccellini (Pasolini 1966), uscito stando al colophon in febbraio (De Laude-Siti 1999, 2962-2963).
Ancora su Pasolini, e alcuni dei suoi “ragionamenti” sul “cinema di poesia”
Famigerata, e spesso fraintesa, l’idea di un “cinema di poesia” contrapposto a un “cinema in prosa” era ancora, al momento dello “scambio epistolare” con Bellocchio, un clamoroso vient-de-paraître, rimbalzato sulle pagine dei giornali fra mille polemiche (Desogus 2018, 77-85) e critiche anche da parte di amici, come Moravia (Moravia 1966). Oggi si trova spesso riferita per sineddoche, in modo più o meno arbitrario, all’intero cinema pasoliniano, oltre che estesa (in modo suggestivo, per la verità) ad altri generi e campi disciplinari – fin dagli anni Ottanta da Federico Tiezzi e Sandro Lombardi, per esempio, col loro “teatro di poesia” (Tiezzi 2012), e più tardi dallo storico dell’arte Giovanni Agosti, che ha parlato di “mostre in poesia” e di impaginazione ‘poetica’ delle immagini nell’apparato iconografico di monografie storico-artistiche, come la sua dedicata a Mantegna (Agosti 2007).
Mettere a fuoco con precisione l’idea, però, non è semplice, perché Pasolini la sottopone dal 1965 in poi a una instancabile messa a fuoco. Occorrerebbe tentarne una lettura ‘stratigrafica’ (lo farò altrove), ma risulta subito dai saggi sul cinema, solo in parte confluiti in Empirismo eretico, l’immagine commovente di un autore che ingenuamente e coraggiosamente pensa a voce alta e in pubblico. Pasolini aggiusta il tiro dopo nuove letture (forse, suggerisce Desogus 2018, 79, anche, Šklovskij [1927] 1971), cui poteva aver avuto accesso fin dal 1966, quando ne era stata messa in lavorazione la traduzione da Garzanti in un’altra collana da lui diretta insieme a Adriano Aprà; rivede ed estremizza la propria posizione nel confutare le critiche (quelle di Umberto Eco, per esempio, danno lo spunto al saggio Il codice dei codici (1967), in fondo a Empirismo eretico, Pasolini 1972, su cui Siti 2015); introduce di continuo aggiustamenti di fuoco.
Schematicamente, possiamo dire che esistono agli occhi di Pasolini due forme di esperienza visiva, riconoscibili dal modo in cui la macchina da presa aderisce all’oggetto rappresentato nel film. La prima, apparentabile alla prosa, è quella in cui l’oggetto è interpretato secondo il bagaglio di codici che lo spettatore ha acquisito in precedenza, e predilige un’organizzazione del materiale coerente al racconto dei fatti, secondo schemi narrativi e rapporti di causa-effetto funzionali al piano narrativo. La seconda, apparentabile alla poesia, coinvolge elementi visivi e sonori che non sono necessariamente riconducibili all’economia narrativa, e possono assumere una funzione autonoma rispetto alla storia narrata; gli espedienti tecnico-stilistici di questo secondo tipo di cinema possono essere riassunti nell’atto, da parte del regista, di “far sentire la macchina” allo spettatore, evidenziando perciò come l’esercizio delle riprese sia in mano a chi governa la cinepresa:
La prima caratteristica di questi segni costituenti una tradizione del cinema di poesia, consiste in quel fenomeno che normalmente e banalmente vien definito dagli addetti ai lavori con la frase: “Far sentire la macchina”. Insomma, alla grande massima dei cineasti saggi, in vigore fino ai primi anni Sessanta: “non far sentire la macchina!”, è successa la massima contraria. Tali due commi, gnoseologici e gnomici, contrari, stanno lì a definire inequivocabilmente la presenza di due modi diversi di fare il cinema: due diverse lingue cinematografiche (Pasolini [1965] 1966, 1484).
“Far sentire la macchina” rompe l’automatismo della percezione prodotto da quei procedimenti che creano l’illusione di una unità di spazio e di tempo e di una consequenzialità tra le varie inquadrature della scena. Ad essi, sostituisce qualcosa di simile al sens obtus teorizzato da Roland Barthes (Barthes [1970] 1995, e per il carattere ottuso dell’immagine Joubert-Laurencin 1995; Joubert-Laurencin 2007; Desogus 2017): un “senso ottuso”, difficile da afferrare, che attraverso espedienti tecnici come falsi raccordi, inquadrature a diversa distanza e sullo stesso angolo in successione, “soggettive libere indirette”, doppiaggi stranianti inseriti in fase di post-produzione o primi piani inseriti senza il rispetto dell’unità d’azione definisce la posizione dell’autore davanti alla macchina da presa e fa emergere la sua soggettività, presentandola come punto di vista sul reale.
Lo stesso Pasolini, d’altra parte, riconosce che esistono “poemi fotografici” (di Chaplin, Mizoguchi o Bergman) che non ricorrono a espedienti di questo genere. “La loro poesia era altrove che nel linguaggio in quanto tecnica del linguaggio” (ivi, 1484). Esiste cioè una poeticità che può consistere nel limitare gli impieghi di espedienti riconducibili alla prosa, ma neanche così la prosa può essere lasciata da parte. La “soggettiva libera indiretta”, per esempio, è considerata già nell’intervento alla mostra di Pesaro tra gli elementi caratteristici del “cinema di poesia”, in quanto intreccia lo sguardo del personaggio con quello dell’autore, che guarda il personaggio guardare (Bazzocchi 2013, Desogus 2018, 84-85). Ma si tratta di un procedimento che Pasolini individua e teorizza sulla scorta della sua riflessione sul “discorso indiretto libero” in prosa, e non per niente il titolo originario dell’intervento di Pesaro era, nel dattiloscritto, Di un possibile discorso indiretto libero nel cinema (De Laude-Siti 1999, 2962).
La “soggettiva” permette allo spettatore di vedere con gli occhi del personaggio, ma l’autore non si eclissa del tutto, e la collisione tra il centro deittico del personaggio (il suo qui e ora nella scena) e quello (extradiegetico) di chi governa la macchina da presa enfatizza piuttosto la presenza autoriale. Deleuze ha osservato il carattere metalinguistico della “soggettiva” cinematografica:
Un personaggio agisce sullo schermo ed è supposto vedere il mondo in un certo modo. Ma nello stesso tempo la cinepresa lo vede, e vede il suo mondo da un altro punto di vista, mentre pensa, riflette e trasforma il punto di vista del personaggio (Deleuze [1983] 1984, 94).
Ma il modello è la prosa, che Pasolini chiama in causa, in un dibattito con gli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia, per spiegare caratteri del suo cinema che sono presentati nella relazione di Pesaro come tipici del “cinema di poesia”:
Il segno sotto cui lavoro è sempre la contaminazione. Infatti se voi leggete una pagina dei miei libri, noterete che la contaminazione è il fatto stilistico dominante, perché io, che provengo da un mondo borghese e non soltanto borghese ma, almeno in gioventù, dalle sedi più raffinate di quel mondo, io lettore degli scrittori decadenti più raffinati eccetera, eccetera, sono arrivato a questo mio mondo. Conseguentemente il pastiche, per forza, doveva nascere. E infatti in una pagina dei miei romanzi sono almeno tre i piani in cui mi muovo: cioè il discorso diretto dei personaggi che parlano in dialetto, in gergo, nel gergo più volgare, indiretto, più fisico direi; poi il discorso libero indiretto, cioè il monologo interiore dei miei personaggi e infine la parte narrativa o didascalica che è quella mia. Ora questi tre piani linguistici non possono vivere ognuno nella sua sfera senza incontrarsi: devono continuamente intersecarsi e confondersi. Infatti nelle battute dei personaggi, anche in quelle che sembrano le più fisicamente e brutalmente registrate, c’è sempre un cursus, un numero spesso, addirittura in endecasillabi, composti anche con delle parolacce. È quindi la mia educazione di borghese che si inserisce nel discorso fino a trasformare in endecasillabi delle battute fisicamente registrate dal mondo reale. Nel discorso libero indiretto poi la contaminazione avviene in maniera chiara, cioè il dialetto, il gergo si contaminano con la lingua parlata. Questa contaminazione avviene anche a livello più alto cioè a livello della parte descrittiva e narrativa. Certe descrizioni, che sono piaciute a Cecchi ed anzi sono le uniche che egli salva, sono scritte in certi momenti da letterato addirittura – tremo nel confessarlo – quasi post-dannunziano, ma anche in esse sono sempre presenti elementi presi dagli altri piani linguistici; e così avviene anche nei film. Evidentemente quando io tratto una certa materia, la rappresento nella sua brutalità fisicamente reale, cioè vado al Pigneto e fotografo quei muretti, quelle spazzature, quel sole, e prendo Franco Citti, e lo fotografo così come è lui; però naturalmente tutta questa materia grezza, bruta, fisicamente violenta, la assumo poi a un altro livello linguistico. Ora, mentre nella pagina di un romanzo questa contaminazione estremamente complessa e raffinata può sfuggire, nel cinema, il cui linguaggio è più elementare, più rozzo di quello letterario [...], viene fuori con maggior violenza. Così che mentre gli elementi dannunziani che possono essere in un romanzo spariscono – soltanto un diagnostico, un critico riesce a rintracciarli – gli elementi invece di sublime religiosità che io ho cercato di tradurre con la musica di Bach sono immediatamente avvertibili e quindi possono disturbare di più (Pasolini [1964] 2001, 2871-2873).
Il “cinema di poesia”, insomma, si avvale di procedimenti stilistici tipici della narrativa. Il terreno in cui Pasolini si spinge per distinguere un “cinema di poesia” e un “cinema di prosa” è pieno di insidie. E il fatto stesso che la tecnica audiovisiva sia ancora giovane, così che nessun codice abbia ancora acquistato tanta autorità da imporsi (“la lingua cinematografica è ancora tutta da fare – questo affascina Pasolini, poter re-inventare il cinema, e questa è l’impressione che si ha vedendo i suoi primi film”, secondo Siti 1989, 123-124), non consente di considerare come elemento davvero discriminante l’infrazione di una presunta oggettività narrativa prodotta dal “far sentire la macchina”, dalle forzature sintattiche del racconto filmico o dagli “strappi del montaggio”.
L’impressione è che Pasolini sia attratto inizialmente da quello che definisce “cinema di poesia”, se non altro perché lo attraeva, in tutte le sue forme, l’infrazione in sé:
Io stesso provo in moviola (o prima, girando) l’effetto quasi sessuale dell’infrazione del codice, come sentimento di qualcosa di violato (sentimento che si prova scrivendo versi, ma che il cinema moltiplica all’infinito: una cosa è essere martirizzati in camera e una cosa è essere martirizzati in piazza) (Pasolini [1970] 1999, 1608).
Ma che presto si renda conto di come in assenza di un codice forte l’eccesso di infrazione esibito dagli autori paia più immediatamente ascrivibile al “cinema di poesia” (Godard, Antonioni, il giovane Bertolucci) e rischi di trasformarsi a sua volta in codice, o peggio ancora, in una specie di ‘maniera internazionale’:
La formazione di una tradizione di ‘lingua di poesia di cinema’ si pone come spia di una forte e generale ripresa del formalismo, quale produzione media e tipica dello sviluppo culturale del neocapitalismo. […] La tradizione stilistica di un cinema di poesia nasce in un ambito di ricerche neo-formalistiche, corrispondenti all’ispirazione materica e prevalentemente linguistico-stilistica tornata d’attualità nella produzione letteraria (Pasolini [1965] 1966, 1487).
Se Pasolini intende mettere alla prova i suoi ragionamenti teorici applicando gli strumenti di lettura che stava elaborando in quegli anni a I pugni in tasca, è proprio perché ne avverte più di quanto sia disposto ad ammettere (niente esplicite abiure, in questo caso) la problematicità. Credo che abbia ragione Walter Siti: al di là di “poesia” o “non-poesia”, la questione fondamentale era come fare a infrangere l’infrazione, se si vuole restare sulla linea del fuoco. Proprio per superare questa impasse, Pasolini si era improvvisato teorico, con saggi che vanno nella direzione di far coincidere la semiologia del cinema con la semiologia della realtà tout court. Tra il codice della realtà e il codice del cinema, si legge in Empirismo eretico, non c’è alcuna differenza. Il cinema è “lingua scritta dell’azione”, ne rispetta la totalità e anche il mistero ontologico, ma avere lo stesso codice della realtà è come non avere nessun codice, perché il codice della realtà non può essere mai completamente descritto:
Se la storia del cinema non ha una convenzione che si possa contraddire con sufficiente scandalo, basta lasciar trasparire, al di sotto dei singoli film, il mistero della Realtà, quella sì perennemente scandalosa (Siti 1989, 125).
L’allusione – qui, e poi in Tracce scritte di un’opera vivente (Siti 1998, L-LI) – è ai momenti in cui nel cinema la realtà appare (o dà l’illusione) di apparire materialmente, in dettagli magari marginali (un ginocchio flesso, un soffio non previsto di vento, l’impigliarsi casuale di una veste…):
La poesia non si raggiunge esasperando il manierismo tecnico, ma catturando la Realtà, che è poetica. Il cinema di Pasolini quindi non è un ‘cinema di poesia’ (nel senso di un oggetto costruito secondo le regole della poesia), ma un cinema che testimonia che la poesia esiste nella Realtà (Siti 1989, 125).
E ancora:
Nella vulgata delle chiacchiere e dei convegni, Pasolini è presentato come un propugnatore del “cinema di poesia”: nei testi, Pasolini giudica negativamente il “cinema di poesia” (cioè il cinema costruito secondo la lingua della poesia) perché ci vede una “scuola internazionale” di élitarismo snob – il cinema che lo interessa è invece costruito con la semplicità sintattica della prosa, ma una prosa capace di testimoniare che la poesia esiste nella Realtà (Siti 1998, LI).
Questi, alcuni dei “ragionamenti” in cui Pasolini era impegnato al momento di includere la sceneggiatura de I pugni in tasca nella collana “Film e discussioni”. Nella prospettiva del pensare a voce alta intorno al “cinema di poesia”, la decisione di aprire il volume con un colloquio non è dunque solo una brillante trovata editoriale. La richiesta di un dialogo suona autentica, e il gioco dello “scambio epistolare”, pur nato a tavolino, sembra prendere la mano ai due interlocutori, dando spunto a quella che si presenta come una discussione aperta, “a canone sospeso”, nella quale nessuno mostra di possedere pregiudizialmente la verità.
“Cinema di prosa” o “cinema di poesia”? Le complicazioni di un film che si sottrae alle “formule che ci sono state care finora”
La prima ‘lettera’, dopo l’attacco che ho riportato più sopra, affronta subito la questione che allora a Pasolini stava più a cuore, riprendendo quasi alla lettera l’intervento pubblicato su “Rinascita”, per distinguere i due tipi di cinema:
Lo riassumo proprio in due parole, proprio per intenderci: alle origini il cinema è stato una ‘lingua poetica’ – si sa che in letteratura c’è contemporaneamente una lingua della poesia e una lingua della prosa; la lingua della poesia, mettiamo, in un dato momento storico usava le parole ‘fé’ o ‘speme’, che in prosa non si usavano. Il cinema, alle sue origini, si presenta essenzialmente come cinema di poesia, a causa soprattutto, probabilmente, delle restrizioni prosodiche del muto (Pasolini [1967b] 1999, 2800).
La nascita del cinema, dunque, nel segno della “poesia” (anche forse per le “restrizioni prosodiche del muto” – è fra le pochissime aggiunte al testo di “Rinascita”), e una successiva evoluzione verso la “prosa”:
Però, piano piano, le ragioni commerciali hanno fatto sì che il cinema prendesse una strada che in fondo è contraddittoria e cioè diventasse praticamente un cinema scritto nella lingua della prosa, diventasse un cinema di prosa. E si sono avuti dei capolavori di prosa – veri e propri romanzi – mettiamo da Ford a Bergman. In questi ultimi tempi si è presentata all’orizzonte europeo e mondiale la figura di una internazionale stilistica di cinema di poesia. Qual è la differenza fondamentale tra questi due tipi di cinema, il cinema di prosa e il cinema di poesia? Il cinema di prosa è un cinema in cui lo stile ha un valore non primario, non appariscente, non clamoroso: mentre lo stile del cinema di poesia è l’elemento centrale, fondamentale. In parole molto povere, nel cinema di prosa, non si sente la macchina da presa e non si sente il montaggio, cioè non si sente la lingua – la lingua traspare sul contenuto e ciò che conta è quello che viene narrato. Nel cinema di poesia invece si sente fortemente la macchina da presa, si sente fortemente il montaggio (ivi, 2800-2801).
Gli esempi di “cinema di poesia” sono identici, nella ‘lettera’ e nell’intervento su “Rinascita”:
Come esempio limite, vi faccio pensare ai film di Godard, in cui si sente continuamente la presenza della macchina da presa che lavora sui personaggi e si sentono continuamente gli strappi del montaggio che non sono mai una funzione di una narrazione quieta, piana, tranquilla, ecc. Pensate per esempio anche al film di un altro giovane, Bertolucci, Prima della rivoluzione (Pasolini [1967b] 1999, 2801).
Come identica è la domanda cui Pasolini mirava fin dall’inizio, che riguarda la collocazione nell’uno o nell’altro filone (del “cinema di prosa” e del “cinema di poesia”) del film d’esordio del ragazzo di Piacenza:
Il suo film, Bellocchio, a quali di questi due filoni appartiene? Il cinema di prosa o il cinema di poesia? Prevale il racconto, il contenuto, il personaggio, la psicologia, la rivolta antiborghese, o prevale lo stile (Pasolini [1967b] 1999, 2801)?
La risposta è nota, e ha dato luogo ad alcune incomprensioni:
Direi che il suo film appartiene al cinema di prosa. Ma questo è il punto che mi sembra importante. È una prosa molto particolare, è una prosa che spesse volte sbava e sfuma quasi nella poesia – ricordo per esempio un recente libro di Roberto Roversi, in cui il tessuto narrativo ogni tanto sfociava in pezzi di vera e propria poesia, cioè la prosa si trasformava in frammenti di versi. Così, un po’, in lei. La sua è una prosa sì, ma una prosa che sfuma continuamente verso forme di espressione di tipo stilisticamente poetico, e cioè una prosa profondamente espressionistica. E questo è rivelazione e spia di un fatto estremamente importante nella sua ispirazione. Infatti – naturalmente, sto facendo uno schema – se volessimo riassumere in una formula che cosa è questo film, non saremmo soccorsi da nessuna delle formule che ci sono state care finora (Pasolini [1967b] 1999, II, 2801-2802; il corsivo è mio).
Il giudizio su I pugni in tasca non è in alcun modo una diminutio, e basterebbe a capirlo il passo sui film del “cinema classico”, da Luci della città di Charlie Chaplin a L’occhio del diavolo di Ingmar Bergman), che sono scritti nella “lingua della prosa”, ma ai quali la poesia “è interna: come, mettiamo, nei racconti di Čechov o di Melville”– film che nella relazione di Pesaro sono definiti “pseudo-racconti”, con “una serie di pagine liriche, la cui soggettività è assicurata dall’uso pretestuale della ‘soggettiva indiretta libera’: e il cui vero protagonista è lo stile” (Pasolini [1966a] 1999, 1485).
Pur evocando all’inizio le “ragioni commerciali” che possono aver contribuito all’evoluzione del linguaggio filmico, nella ‘lettera’ il “cinema di prosa” è presentato come un cinema in cui “il contenuto, il personaggio, la psicologia, la rivolta antiborghese” ha una forza d’impatto superiore ai formalismi dell’“internazionale stilistica” del “cinema di poesia” (espressione che di per sé dovrebbe mettere in sospetto, se a usarla è chi delle ‘internazionali’, in sospetto di ‘prodotto neocapitalistico’, ha sempre insegnato a diffidare).
Rivelatore è anche l’esempio tra storia del cinema e storia della letteratura fatto più sopra (“in letteratura c’è contemporaneamente una lingua della poesia e una lingua della prosa. La lingua della poesia, mettiamo, in un dato momento storico usava le parole ‘fé’ o ‘speme’, che in prosa non si usavano”), che riporta a certi saggi di Passione e ideologia, come La confusione degli stili, dove la variabile configurazione del rapporto fra generi e stili, e la maggiore o minore divaricazione nelle singole fasi storiche fra “lingua della prosa” e “lingua della poesia”, è esaminata con strumenti critici desunti da Erich Auerbach, Giacomo Devoto, Alfredo Schiaffini e Gianfranco Contini, e in termini dai quali risulta chiaramente che l’interesse principale di Pasolini è per la ‘contaminazione’, o quello che Schiaffini chiamava “sliricarsi” della poesia, il suo aprirsi verso forme di prosa più vicine alla realtà creaturale (Schiaffini 1959): è la “confusione degli stili” ad assicurare “la riscoperta di quello che gli stilisti chiamano il concreto-sensibile” (Pasolini 1956, 1080). “Confusione degli stili” è una delle tante libere traduzioni pasoliniane del lessico di Erich Auerbach – in questo caso Stilmischung. E si sa quanto Pasolini considerasse proprio la mescolanza degli stili la dominante del suo cinema (Cadoni 2015; e per Auerbach in Pasolini, Bologna 2009; De Laude 2009 e 2018).
La prosa, insomma, non esclude la poesia, e per un film essere scritto insieme “in prosa” e “in poesia” invece che solo “in prosa” o solo “in poesia è un valore aggiunto. Anche alla distinzione tra “cinema di prosa” e “cinema di poesia”, Pasolini allude senz’altro nel presentare I pugni in tasca come un film per classificare il quale “non saremmo soccorsi da nessuna delle formule che ci sono state care finora” (Pasolini [1967b] 1999, 2801-2802).
Lo stesso dirà più avanti per altre “formule”, come neorealismo e cinema “di tematica neocapitalistica”, alla Antonioni:
Potremmo parlare di neorealismo per il suo film, potremmo dire che c’è del neorealismo, che in qualche modo il suo film è neorealistico? No: le situazioni umane, stilistiche, del suo film non sono neorealistiche. Non si tratta nemmeno di un film che appartenga in qualche modo al realismo socialista, cioè non è nemmeno un film di denuncia sociale fatto da un punto di vista marxista; e non è nemmeno un film, per intenderci, fatto all’Antonioni, cioè un film di problematica neocapitalistica che si ponga quasi contemplativamente i problemi del mondo più strettamente contemporaneo, del mondo degli anni Sessanta.
Lei è al di fuori di queste formule. Il nòcciolo del suo film è una specie di esaltazione della abnormità e della anormalità contro la norma del vivere borghese, contro le istituzioni e contro il livello medio della vita borghese, familiare. È una rabbiosa rivolta dall’interno del mondo borghese. Per esprimermi vivacemente, potrei dire che il suo film è il film di un beat, di un capellone. Mi ricorda in qualche modo la poesia di Ginsberg – cioè è estremamente al di fuori di tutte le scuole, le correnti poetiche, ideologiche ecc. ecc., che hanno caratterizzato il cinema italiano finora (Pasolini [1967b] 1999, 2801-2802).
Il film di Bellocchio si sottrae dunque a tutti gli schemi, risente dell’esperienza del neorealismo ma lo supera, purificandosi attraverso una “specie di lavacro” delle “sue origini oscuramente novecentesche”:
È vero, il suo film non è un film realistico, però c’è l’esperienza neorealistica che non è affatto lasciata da parte, dimenticata; è assimilata; c’è un certo modo di vedere l’Appennino, un certo modo di vedere mettiamo la scena del ballo – i ragazzi che ballano in quel piccolo night-club di provincia – certe corse in macchina, la breve scena in cui i due fratelli, fratello e sorella, stanno a osservare delle prostitute ecc. ecc., sono echi stilistici della esperienza neorealistica. E così c’è anche, evidentemente, un tipo di denuncia critica di tipo marxista alla società. È chiaro che è presente, lei non la ignora; e c’è anche la problematica di tipo neocapitalistico all’Antonioni – questo mondo del benessere che arriva anche nella piccola frazione della provincia di Reggio, di Parma, di Piacenza. Dunque questi temi ci sono tutti.
L’irrazionalismo, la sua rivolta, passa attraverso tutte queste fasi, quasi come una specie di lavacro attraverso cui si purifica delle sue origini oscuramente novecentesche (Pasolini [1967b] 1999, 2803).
Si spiega così il confronto con la poesia di Allen Ginsberg: apparentemente uno “scivolone” (Costa 2005, 113), che serve però a ribadire l’inclassificabilità de I pugni in tasca (“al di fuori di tutte le scuole, le correnti poetiche, ideologiche ecc. ecc.”), se il poeta americano, nel saggio La fine dell’avanguardia, è presentato come più rivoluzionario di tutti i contestatari della neo-avanguardia messi insieme (“in confronto mettiamo a Ginsberg, tutti i contestatari avanguardistici appaiono degli abatini – come un giornalista imitatore di Contini, chiama i giocatori di calcio graziosi e accademici”, in Pasolini [1966b] 1999, 1407, con un riferimento allo stile del giornalista Gianni Brera), e in altro, sempre confluito in Empirismo eretico, si legge: “Era dai vecchi tempi di Machado che non facevo una lettura fraterna come quella di Ginsberg” (1966d, 1438).
È questo il punto su cui insiste Pasolini – il sottrarsi de I pugni in tasca a tutte le “formule che ci sono state care finora” (compresa, credo sia da intendere, la distinzione tra “cinema di prosa” e “cinema di poesia”, come era stata fino ad allora recepita) – e torna ad insistervi uno dei pochi passi presenti solo nel testo apparso su “Rinascita”:
Questo film dunque pone in discussione tutta una ideologia, tutta una impostazione ideologica, almeno per quel che mi riguarda (Pasolini 1966, 26).
Qualche incomprensione, a proposito di “cinema di prosa” e “cinema di poesia”
Già al dibattito romano su I pugni in tasca, il sociologo Roberto Giammanco aveva manifestato qualche perplessità nei confronti della nozione di “cinema di poesia”, da ricondurre, a suo avviso, ad “un tipo di idolatria del lirismo e della formula verbale che, secondo me, Bellocchio ha voluto ignorare, o se si preferisce contestare” (Giammanco 1966, 27). L’idea di una superiorità del “cinema di poesia” rispetto al “cinema di prosa” è ancora dominante.
Nella sua monografia su I pugni in tasca, Antonio Costa riconosce “l’imbarazzo di Pasolini nel cercare di definire il film di Bellocchio in base alle categorie da poco introdotte nel suo intervento pesarese su cinema di poesia”, ma considera poi nel giudizio espresso il film di Bellocchio degradato nello “scambio epistolare” a “film di prosa”, e riconosce in Pasolini una maggiore “sintonia” con i film di Antonioni, Godard, Bertolucci, tanto che sarebbe da intendere solo come una sorta di escamotage il recupero, per I pugni in tasca, di “una non meglio definita poeticità dei contenuti” (Costa 2005, 113).
Anche secondo Anton Giulio Mancino, il film sarebbe “relegato” nella categoria del “cinema di prosa” – giudizio, questo, all’origine di un “dissapore” tra Bellocchio e Bertolucci:
Non è […] ‘fittizio’, ancorché costruito a tavolino e in un certo senso inflitto, il dissapore tra Bellocchio e Bertolucci incautamente alimentato proprio da Pasolini che aveva assegnato Prima della rivoluzione del suo ex aiuto regista Bertolucci alla categoria privilegiata del cinema “di poesia”, a differenza de I pugni in tasca di Bellocchio, relegato in quella del cinema “di prosa” (salvo l’attenuante “che spesse volte sbava e sfuma quasi nella poesia” (Mancino 2018; il corsivo è mio).
E la replica di Bellocchio all’intervento del dibattito romano, rapidamente registrata da Dario Argento (“Richiesto se egli condivide l’opinione di Pasolini che classifica il suo film come un film di prosa, Bellocchio ha risposto affermativamente”, Argento 1966, 6) andrebbe intesa come una risposta obbligata, per ragioni di cortesia:
Bellocchio cosa poteva fare o dire, del resto? Sarebbe stato controproducente intervenire in un dibattito che rischiava di sfuggirgli di mano, pensato com’era per trascendere il film, persino servirsi della tecnica del dividi e conquista. Comunque sia per investire il film di responsabilità altre. Controproducente per il film stesso, per la forza delle sue immagini e la sua esemplare resistenza nel tempo, contro il tempo e contro qualsiasi gioco di squadra allora in atto (Mancino 2018).
Non era la prima volta, del resto, che Pasolini utilizzava la distinzione fra cinema “di prosa” e “di poesia” in modo meno rigido dei lettori suoi contemporanei, e di molti interpreti di oggi. Di un misto di “prosa” e di “poesia” aveva già parlato per Uccellacci e uccellini, uno dei suoi film che amava di più, com’era detto nella Lettera aperta nel dépliant pubblicato in occasione della prima del film al cinema Ritz di Milano:
Cari amici, cari critici milanesi,
non ho mai dato congedo a un film così indifeso, così delicato, così riservato come Uccellacci e uccellini. […] Mai mi sono così esposto come in questo film. Mai ho assunto a tema di un film un tema esplicitamente così difficile (Pasolini [1966b] 2001 830).
Presentando nel volume della collana “Film e discussioni” che precede immediatamente I pugni in tasca la sceneggiatura del film, Uccellacci e uccellini era definito un esperimento ibrido di “prosa” e “poesia”, o una specie di “operetta morale” scritta in prosa:
una prosa che però è quella delle favole, cioè una particolare prosa che ha una certa nervosità e una certa fantasia proprie della poesia, ma ci sono in più i salti linguistici, le violenze linguistiche del cinema di poesia: è un film raccontato in prosa con delle punte poetiche” (dichiarazione riportata in De Giusti 1979, 49; il corsivo è mio).
“Una particolare prosa”, sconfinante nella poesia, è la stessa espressione riferita, si è visto, a I pugni in tasca. E la genesi del film è spiegata così:
L’intenzione prima era di fare un’operetta poetica nella lingua della prosa. Le crisi e le opzioni tecniche all’inizio della lavorazione sono sfociate nell’adozione – nei particolari, nelle singole scene – di un certo quantitativo di “lingua della poesia”. Ora, il film concluso, quasi definitivamente montato, è tornato ad essere quell’operetta poetica nella lingua della prosa che avevo pensato prima di cominciare la sceneggiatura (ivi).
Anche il risvolto di copertina stabilisce un confronto fra ciò che avviene nel “cinema di poesia” e ciò che nel romanzo avviene, secondo Lucien Goldmann, in merito alla soppressione del “soggetto” come “individuo problematico”:
Godard e, nell’insieme, il “cinema di poesia” tendono anch’essi a distruggere il romanzo come “ricerca demoniaca” dell’eroe (secondo la terminologia di Lukács: “la ricerca degradata di valori autentici in un mondo degradato”)? È chiaro che nel cinema c’è solo la tendenza a tutto questo. La destinazione e la produzione del film lo impediscono a priori: non è concepibile l’equivalente, nel cinema, del romanzo senza personaggio o della pittura non figurativa. Forse inconsciamente, con Uccellacci e uccellini, ho cercato di liberarmi di tutte queste possibilità e impossibilità, dovute al mondo economico in cui opero. […] ho eluso, […] soprattutto attraverso la struttura tecnica stessa dell’opera, l’impossibilità di un autore a far altro, nel romanzo, che “una ricerca degradata dei valori autentici in una società degradata”: perché io infatti rappresento due “personaggi veri” occupati, direttamente e esplicitamente, in una “ricerca degradata di valori autentici in un mondo degradato”. Questo è l’oggetto stesso del mio film (Pasolini [1966a] 2001, 828; il corsivo è mio).
Il resto del carteggio
Non mi fermo qui sul seguito dello “scambio epistolare”, se non per qualche precisazione. La risposta di Bellocchio alla prima ‘lettera’ di Pasolini lascia cadere la questione del “cinema di prosa” e di poesia” e sposta il discorso sul tema, toccato già da Pasolini, della “rivolta”, della “rabbia”, con un argomento che Grazia Cherchi aveva già toccato in una sua recensione a I pugni in tasca (Cherchi [1966] 1988):
Ora, l’atteggiamento di Alessandro non è di un “arrabbiato” per due motivi principali: primo perché, seppur organicamente malato, è rappresentato come consapevole delle proprie azioni e dei propri vizi; secondo, perché i suoi obiettivi criminali sono già dei bersagli innocui, scontati, inerti, prima che arrivi lui a spingerli con la forza di un dito in una fossa che già da molto prima doveva ospitarli. Il matricidio e il fratricidio sono il colpo di grazia a due esistenze che da decine d’anni avevano perso la coscienza e il contatto con una realtà che progrediva senza più tener conto di loro (Pasolini [1967b] 1999, 2805).
Importante l’individuazione nel protagonista del film (Alessandro, interpretato da Lou Castel) di un tratto decadente, dannunziano, che lo convince a eliminare madre e fratello non solo perché sono un passivo nel bilancio domestico, ma anche “perché sono brutti, impresentabili”, e “deturpano il paesaggio familiare come abiti o mobili fuori moda, o come animali che non hanno imparato e non impareranno più a sporcare in giardino”. Il ragazzo sogna a occhi aperti:
fantasticando una realtà diversa dalla propria uccide anche soltanto per la curiosità di sapere che cosa succederà introducendo in un ordine stantio, cronico e immobile un attimo di irrazionalità, capace di sconvolgerlo e di dargli un ritmo più accelerato (Pasolini [1967b] 1999, 2805).
La sua non è tanto una rivolta contro “valori” che non esistono più (“ad esempio: il diritto di proprietà, la famiglia, la patria, la religione ecc. ecc.”), ma l’eliminazione di “reliquie rispettate per interesse”, che non rappresentano, oggettivamente, più nessun valore: “In questo senso Alessandro non si “arrabbia” contro di essi, ma li elimina, li liquida, come inutili ingombri, utensili che hanno fatto il loro tempo” (ivi, 2806). Un’affermazione, anche questa, da confrontare con la recensione di Grazia Cherchi:
L’equivoco in cui sono caduti molti critici è che Bellocchio sia in posizione di violenta polemica, provocatoria e demistificante, con le sacre istituzioni, i cosiddetti valori borghesi. […] Ma Bellocchio non è così ingenuo da polemizzare con i “valori” tradizionali tramite gli sberleffi di Alessandro. Il film analizza il comportamento di un adolescente, e tale comportamento prevede anche certe reazioni, sprovvedute, infantili, e di comodo, al mondo degli adulti. […] Il motivo per cui il film mi sembra importante è che da esso traspare che non c’è nulla da profanare. I “valori” sbeffeggiati da Alessandro non sono valori per Bellocchio, e quindi non richiedono una seria confutazione. […] Si riparte da zero (Cherchi [1966] 1988, 227).
Il team ‘piacentino’ non segue l’ideatore dello “scambio epistolare” sul terreno del “cinema di poesia”, o della sua contaminazione con la prosa, ma Pasolini si lascia coinvolgere dal colloquio, al punto di indirizzare al giovane autore de I pugni in tasca una delle sue più lucide auto-analisi sul tema dello “scandalo”:
Caro Bellocchio,
bene; scusi ora se cito me stesso, e soprattutto scusi se cito dei versi di prima stesura, gettati giù così, in questi giorni per un dramma che si chiama Poesia (glielo dico perché si tratta della storia di un poeta simbolicamente cecoslovacco – intendo dire della sua storia poetica – dall’anteguerra a oggi: e nell’anteguerra egli è stato un giovane arrabbiato, com’ero io e com’è lei oggi: arrabbiato, cioè, senza i connotati tipici della rabbia ecc. ecc.) (Pasolini [1967b] 1999, 2807).
Il “dramma che si chiama Poesia” è la pièce in versi poi ribattezzata Bestia da stile, e il discorso continua così:
Lo scandalizzare non sarà un atto che un autore compie perché ricada su lui stesso? Un atto di sadomasochismo, diciamo, o di autolesionismo? Un atto espressivo in quanto pubblica punizione di se stesso? Cosicché lo scandalo non abbia valore per quello che esso è nelle forme o nei contenuti dell’opera, ma per quello che esso è ricadendo nella persona stessa dell’autore? Cioè nel ridivenire azione, pragma? Cosicché l’opera non sia stata che un episodio, con altri valori intrinseci, ma con questa dichiarata strumentalità di essere veicolo di uno scandalo, che mette direttamente in rapporto l’autore con i destinatari (Pasolini [1967b] 1999, 2808-2809)?
L’idea di mettere “direttamente in rapporto l’autore con i destinatari” non è estranea al “cinema di poesia”, e il passo va confrontato con alcune pagine di un saggio più tardo, Il cinema impopolare, che ancora si interroga sull’“infrazione del codice”, con riferimento ai film di Godard e a un recente lungometraggio di Jean-Marie Straub (Othon, o Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer, o Peut-être qu'un jour Rome se permettra de choisir à son tour):
Rigoroso e forte, l’intero Othon è stato pensato ‘metalinguisticamente’: il pensiero-guida era: fare un film recitato come una pièce teatrale, dalla prima parola all’ultima, proprio come non deve essere un film. […] Al montaggio, Straub non ha lavorato: l’autopunizione sadomasochistica (eccomi, spettatore, a torturarti; eccomi, spettatore, a farmi torturare) Straub l’ha tutta delibata nel pensare e nel girare il film, fatto di una serie di elementari piani-sequenza, attaccati semplicemente in moviola l’uno all’altro. L’assenza di montaggio è un elemento appunto provocatorio: la libertà dal codice cinematografico ottenuta, col sacrificio di se stessi, col dare se stessi in pasto alle belve, col rendere se stessi dei “mostri”, provocatori e martiri, civette e vittime – tende dunque verso la negazione del cinema […] (Pasolini [1969] 1999, 1607).
Ancora una volta, il ragazzo di Piacenza resta fermo sulle sue convinzioni:
Caro Pasolini,
non credo all’efficacia dello scandalo, come non credo che “lo scandalo abbia valore per quello che esso è, ricadendo sulla persona stessa dell’autore…” (Pasolini [1967b] 1999, 2809).
E aggiunge, riprendendo un saggio di Jules Feiffer (se ne era parlato sui “Quaderni piacentini” di recente, nel n. 25, del dicembre 1966), che l’artista ‘scandaloso’ corre un rischio: quello di fare la parte di un “sovversivo di corte”, che agisce “in ultima analisi, in favore del sistema”.
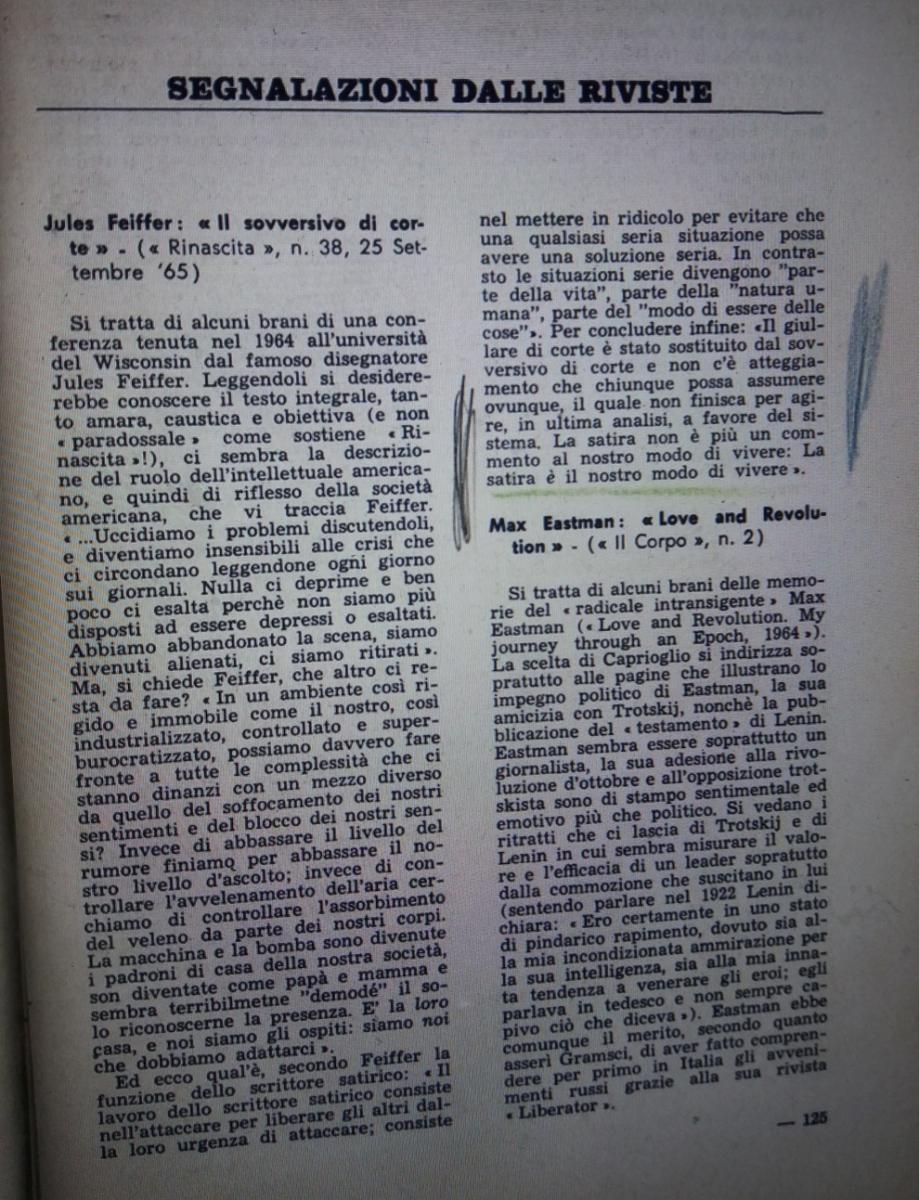
3 | Una pagina dei “Quaderni piacentini”, n. 25, dicembre 1966.
Un’osservazione acuta, che Pasolini non può accettare. La reazione è un’accusa di “moralismo ‘piacentino’”:
In lei, è la sua natura (almeno quale appare ne I pugni in tasca) che dà un certo scandalo: la sua natura di moralismo radicale. […] D’altra parte il suo moralismo le impedisce di apprezzare lo scandalo, perché ecc. ecc. Il suo moralismo “piacentino” (questa parola ha un senso per addetti ai lavori: ma inauguriamola pure, allo stesso modo con cui si usa la parola “cinese”, “albanese”) è dunque insieme la ragione per cui dà scandalo e la ragione per cui pone dei “veti” appunto moralistici al dare scandalo (Pasolini [1967b] 1999, 2811).
La risposta, fermissima:
Tra i borghesi marxisti non sono pochi quelli che hanno visto I pugni in tasca come un film “lirico”, trovando immature e rozze le parti scandalose (e qui equivocando, dato che io per primo non prendevo sul serio i beffardi furori di Alessandro contro patria Dio famiglia, ma li vedevo – l’ho ripetuto fino alla noia – come tipici dell’adolescenza).
Quanto poi al mio presunto porre veti al comportamento (“lo scandalo non va bene, perché…”), il mio era un giudizio di valore: trovo che certi comportamenti scandalosi sono fondamentalmente innocui e tradiscono più che altro un’impotenza anche al livello della stessa provocazione. L’accusa di moralismo, indirizzatami al riguardo, mi sembra un po’ generica (Pasolini [1967b] 1999, 2811).
L’anomalo carteggio si avvicina a chiudersi, ma comunque sia nato, suona autentica la formula che Pasolini sceglie per congedarsi:
Per finire questo nostro dialogo di isolati le auguro, come devono suonare le conclusioni, di turbare sempre più le coscienze dell’Esercito, della Magistratura, del Clero reazionario, e insomma della Piccola Borghesia italiana, a cui abbiamo il disonore di appartenere.
Saluti affettuosi dal suo
P.P. Pasolini (Pasolini [1967b] 1999, 2815)
Appendice*
Non farò un discorso particolare, sul film di Bellocchio, non ne farò una recensione, come del resto non l’ha fatta nemmeno Petri, perché di questo film si è, parlato, credo in questi mesi, in molte sedi: quindi credo sia inutile soffermarsi sul film in quanto opera particolare, tanto più che appunto non ho avuto il tempo di condurre un esame particolare, come a me piace, cioè filologico-stilistico sul testo. Farò dunque sul film di Bellocchio, e spero che questo interessi anche all’autore, un discorso più generale, cioè io inquadrerei il film in una situazione culturale che in qualche modo lo supera, lo trascende, lo include, e mi riallaccerò quindi a certi miei discorsi, a certi miei ragionamenti teorici fatti a più riprese e che hanno come centro l’individuazione della nascita del cosiddetto cinema di poesia. Lo riassumo proprio in due parole, proprio per intenderci: alle origini il cinema è stato una ‘lingua poetica’, voi sapete che in letteratura c’è contemporaneamente una lingua della poesia e una lingua della prosa; la lingua della poesia, mettiamo, in un dato momento storico usava le parole ‘fé’ o ‘speme’, che in prosa non si usavano: ora il cinema ci viene presentato come una lingua cinematografica se capisce di poesia.
Però, piano piano, le ragioni commerciali, le spese di cui diceva Petri, hanno fatto sì che il cinema prendesse una strada che in fondo è contraddittoria e cioè diventasse praticamente un cinema scritto nella lingua della prosa, diventasse un cinema della prosa. E si sono avuti dei capolavori in prosa, veri e propri romanzi, mettiamo da Ford a Bergman. In questi ultimi tempi si è presentata all’orizzonte europeo e mondiale una figura diciamo così internazionale: una internazionale stilistica di cinema di poesia.
Qual è la differenza fondamentale tra questi due tipi di cinema, il cinema di prosa e il cinema di poesia? Il cinema di prosa è un cinema in cui lo stile ha un valore non primario, non appariscente, non clamoroso: mentre lo stile del cinema di poesia è l’elemento centrale, fondamentale. In parole poverissime, nel cinema di prosa non si sente la macchina da presa e non si sente il montaggio, cioè non si sente la lingua; la lingua traspare sul contenuto e ciò che conta è quello che viene narrato. Nel cinema di poesia invece si sente fortemente la macchina da presa, si sente fortemente il montaggio.
Come esempio limite, vi faccio pensare ai film di Godard, in cui si sente continuamente la presenza della macchina da presa che lavora sui personaggi e si sentono continuamente gli strappi del montaggio che non sono mai in funzione di una narrazione quieta, piana, tranquilla, ecc. Pensate per esempio anche al film di un altro giovane, Bertolucci, Prima della rivoluzione. Il film di Bellocchio, a quali di questi due filoni appartiene?
Il cinema di prosa o il cinema di poesia? Prevale il racconto, il contenuto, il personaggio, la psicologia, la rivolta antiborghese, o prevale lo stile? Direi che il film di Bellocchio appartiene al cinema di prosa. Ma questo è il punto che mi sembra importante. È una prosa molto particolare, è una prosa che spesse volte sbava e sfuma quasi nella poesia – ricordo per esempio un recente libro di Roberto Roversi, in cui il tessuto narrativo ogni tanto sfociava in pezzi di vera e propria poesia, cioè la prosa si trasformava in frammenti di versi. Così, un po’, il Bellocchio. La sua è una prosa sì, ma una prosa che sfuma continuamente verso forme di espressione di tipo stilisticamente poetico, e cioè una prosa profondamente espressionistica. E questo è rivelazione e spia di un fatto estremamente importante nella sua ispirazione. Infatti – naturalmente, sto facendo uno schema – per voler riassumere e dire in una formula che cosa è questo film non saremmo soccorsi da nessuna delle formule che ci sono state care finora.
Potremmo parlare di neorealismo per il film di Bellocchio, potremmo dire che c’è del neorealismo, che in qualche modo il suo film è neorealistico? No: le situazioni umane, stilistiche, del film di Bellocchio non sono neorealistiche. Non si tratta nemmeno di un film che appartenga in qualche modo al realismo socialista, cioè non è nemmeno un film di denuncia sociale fatto da un punto di vista marxista, e non è nemmeno un film, per intenderci, fatto all’Antonioni, cioè un film di problematica neocapitalistica che si ponga quasi contemplativamente i problemi del mondo più strettamente contemporaneo, del mondo degli anni Sessanta.
Bellocchio è al di fuori di queste formule. Il nocciolo del suo film è una specie di esaltazione della abnormità e della anormalità contro la norma del vivere borghese, contro le istituzioni e contro il livello medio della vita borghese, familiare. È una rabbiosa rivolta dall’interno del mondo borghese. Per esprimermi vivacemente, potrei dire che il suo film è il film di un beat, cioè di un capellone. Mi ricorda in qualche modo la poesia di Ginsberg, cioè è estremamente al di fuori di tutte le scuole, le correnti poetiche, ideologiche ecc. ecc., che hanno caratterizzato il cinema italiano finora. È insieme, credo, con il film di Bertolucci, il primo caso di un film italiano che sia andato al di là del neorealismo, come sono andati al di là del neorealismo certi film francesi o certi film inglesi.
La rivolta irrazionalistica del film di Bellocchio solo superficialmente può sembrare in qualche modo un regresso – premetto che l’idea del regresso non può balenare nella testa di Bellocchio o di altri giovani come lui e viene in testa a me perché io già lavoravo dieci anni fa. Dieci, quindici anni fa, il tema più profondo, credo, per quanto detto schematicamente, della cultura italiana, era la lotta contro l’irrazionalismo borghese di tipo novecentesco. Ora questa lotta fatta da me e dai miei amici e compagni contro questa forma irrazionalistica si rivela in questo momento parziale e errata, perché la caratteristica del mondo borghese, come dice con grande chiarezza Goldmann sulla strada di Lukács, non era l’irrazionalismo, come noi credevamo, ma il razionalismo. È il razionalismo la caratteristica principale del mondo borghese, l’irrazionalismo era una forma di lotta antiborghese, di quelli che Lukács, e nella sua scia Goldmann, chiama gli individui problematici, cioè gli scrittori, i poeti. Ora, perché questa forma irrazionalistica di rivolta, di anormalità da capellone, di Bellocchio, non si presenta assolutamente come un regresso? Perché è chiaro che è passata attraverso tutte le esperienze culturali dei dieci-quindici anni che l’hanno preceduta; cioè tutta la definizione negativa che ho fatto all’inizio sul film di Bellocchio, in realtà però può essere ripresa, può essere riferita al suo film.
È vero, il film di Bellocchio non è un film realistico, però c’è l’esperienza neorealistica che non è affatto lasciata da parte, dimenticata; è assimilata; c’è un certo modo di vedere l’Appennino, un certo modo di vedere mettiamo la scena del ballo – i ragazzi che ballano in quel piccolo night-club di provincia, certe corse in macchina, la breve scena in cui i due fratelli, fratello e sorella, stanno a osservare delle prostitute ecc. ecc. Sono echi stilistici della esperienza neorealistica. E così c’è anche, non è assolutamente ignorata da Bellocchio, evidentemente, un tipo di denuncia critica di tipo marxista alla società. È chiaro che è presente, lui non la ignora; e c’è anche la problematica di tipo neocapitalistico all’Antonioni, questo mondo del benessere che arriva anche nella piccola frazione della provincia di Reggio, di Parma, di Piacenza. Dunque questi temi ci sono tutti.
Quindi l’irrazionalismo, la rivolta irrazionalistica di Bellocchio passa attraverso tutte queste fasi, quasi come una specie di lavacro attraverso cui si purifica delle sue origini oscuramente novecentesche. Dunque questa forma irrazionalistica di Bellocchio, questa sua rivolta dell’epilettico contro la società, del mostro contro le persone normali, non ha niente di quei vizi irrazionalistici delle persone borghesi contro cui noi abbiamo lottato per dieci anni.
Questo film pone dunque in discussione tutta una ideologia, tutta una impostazione ideologica, almeno per quel che mi riguarda. Cioè rimette in ballo la discussione dell’opposizione per impostare in altri termini il contrasto, l’opposizione fra ciò che credevamo razionale e ciò che noi credevamo irrazionale. Rimette in discussione la nostra delusione di questi dieci anni di lotta contro l’irrazionalismo borghese: una delusione, tutto sommato.
* Intervento di Pasolini al dibattito su I pugni in tasca organizzato dal Circolo Culturale Ludovisi, 6 marzo 1966, come è riprodotto su “Rinascita”, 2 aprile 1966.
Riferimenti bibliografici
- Agosti 2007
G. Agosti, Mantegna, I, Milano 2007. - Argento 1966 > Argento [1966] 2000
D. Argento, I pugni in tasca. Le reazioni di Pasolini e Petri. Le “spiegazioni” del regista, “Paese Sera”, 17 marzo 1966, poi in S. Della Casa, Dario Argento, il brivido della critica, Torino 2000, 6. - Barthes [1970] 1995
R. Barthes, Le troisième sens: notes de recherches sur quelques photogrammes de S. M. Eisenstein, “Cahiers du cinéma” 222 (1970), in Id., L’obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris 1982; trad. it. L’ovvio e l’ottuso, Torino 1985. - Bazzocchi 2013
M. A. Bazzocchi, La parte nascosta del mito, in A. Felice e G.P. Gri (a cura di) Pasolini e l’interrogazione del sacro, Casarsa della Delizia-Venezia 2013, 55-62. - Bellocchio 1967
M. Bellocchio, I pugni in tasca, Milano 1967. - Bellocchio 1995
Intervista rilasciata a A. De Tommasi, Marco Bellocchio. Ho sognato una farfalla, “Il Venerdì di Repubblica”, 16 giugno 1995, 71. - Bellocchio 2015
M. Bellocchio, I pugni in tasca, a cura di M. Ciment, Bologna 2015. - Bologna 2009
C. Bologna, Le cose e le creature. La divina e umana “Mimesis” di Pasolini, in Pasolini lettore di “Mimesis”, in “Mimesis”. L’eredità di Erich Auerbach, in Atti del XXV Convegno Interuniversitario (Bressanone-Innsbruck, 5-8 luglio 2007), a cura di I. Paccagnella e E. Gregori, Padova 2009, 445-466. - Cadoni 2015
A. Cadoni, Il segno della contaminazione. Il film tra critica e letteratura in Pasolini, Prefazione di H. Joubert-Laurencin, Milano-Udine 2015. - Calvino [1966] 1988
I. Calvino, Intervento su I pugni in tasca, “Rinascita”, 9 aprile 1966 (parzialmente anche in Marco Bellocchio. Catalogo ragionato, a cura di P. Malanga, Milano 1988, 226-227). - Cherchi [1966] 1988
G. Cerchi, Intervento su I pugni in tasca, “Giovane critica”, estate 1966 (parzialmente in Marco Bellocchio. Catalogo ragionato, a cura di P. Malanga, Milano 1988, p. 227). - Costa 2005
A. Costa, Marco Bellocchio. I pugni in tasca, Torino 2005 [2a ed. 2007]. - De Giusti 1979
L. De Giusti, Pier Paolo Pasolini. Il cinema in forma di poesia, a cura di L. De Giusti, Pordenone 1979. - De Laude 2009
S. De Laude, Pasolini lettore di “Mimesis”, in “Mimesis”. L’eredità di Erich Auerbach, Atti del XXV Convegno Interuniversitario (Bressanone-Innsbruck, 5-8 luglio 2007), a cura di I. Paccagnella e E. Gregori, Padova 2009, 467-482. - De Laude 2018
S. De Laude, La rondine di Pasolini, con lo scritto di A. Zaccuri Allodole e teologi, Milano 2018. - De Laude, Siti 1999
P.P. Pasolini, Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, con un saggio di C. Segre, 2 voll., Milano 1999. - Deleuze [1983] 1984
G. Deleuze, L’image-mouvement. Cinéma 1, Paris 1983, trad. it. L’immagine movimento. Cinema 1, Milano 1984. - Desogus 2017
P. Desogus, Pasolini, “L’abiura” e il “nuovo fascismo”. Rivoluzione passiva di Gramsci e stile indiretto libero attraverso “Il fiore” e “Salò”, “Allegoria” XXIX, 76 (2017), 7-24. - Desogus 2018
P. Desogus, Laboratorio Pasolini. Teoria del segno e del cinema, Macerata 2018, 77-85. - Fofi 1966 > Fofi [1966] 2005
G. Fofi, Les points sur les “i”, “Positif”, 76, giugno 1966, poi in Id., Capire con il cinema, Milano 1977, 36-38 e in A. Costa, Marco Bellocchio. I pugni in tasca, Torino, 2005, 149-151. - Gambetti 1967
G. Gambetti, Marco Bellocchio contro il “sentimento” [intervista al regista], in M. Bellocchio, I pugni in tasca, Milano 1967, 25-51. - Gelli 2010
P. Gelli, Introduzione a P.P. Pasolini, Poeta delle Ceneri, Milano 2010, 5-20. - Giammanco 1966
R. Giammanco, [intervento al dibattito sui pugni in tasca organizzato al Circolo culturale Ludovisi], “Rinascita”, 2 aprile 1966, 26-27. - Herczeg 1972
G. Herczeg, Saggi linguistici e stilistici, Firenze 1972. - Malanga 1998
P. Malanga (a cura di), Marco Bellocchio. Catalogo ragionato, Milano 1998. - Joubert-Laurencin 1995
H. Joubert-Laurencin, Pasolini, portrait du poète en cinéaste, Paris 1995. - Joubert-Laurencin 2007
H. Joubert-Laurencin, Pasolini-Barthes: engagement et suspension de sens, “Studi Pasoliniani” 1 (2007), 55–67. - Mancino 2018
A.G. Mancino, Da Bellocchio a Pasolini, e ritorno, “Uzak” IX (2018), 35. - Moravia 1966
A. Moravia, Il regista con la grammatica, “L’Espresso”, 3 aprile 1966. - Moravia [1966] 2005
A. Moravia, recensione a I pugni in tasca, “L’Espresso”, 2 gennaio 1966 (ora in A. Costa, Marco Bellocchio. I pugni in tasca, Torino 2005, 164-166). - Pasolini 1956 > Pasolini [1956] 1999
P.P. Pasolini, La confusione degli stili, “Ulisse” X, n. 24-25 (autunno-inverno 1956), poi [con la data 1957] in Passione e ideologia, Milano 1960, ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, con un saggio di C. Segre, 2 voll., Milano 1999, I, 1070-1088. - Pasolini [1957] 2003
P.P. Pasolini, Domenica all’Acqua Acetosa, [1957], ora in Tutte le poesie, a cura e con uno scritto di W. Siti, saggio introduttivo di F. Bandini, 2 voll., Milano 2003, I, 886-888. - Pasolini [1957] 1998
P.P. Pasolini, Diario al registratore, [1957], in Id., Romanzi e racconti, II, a cura di W. Siti e S. De Laude, Milano 1998, 1833-1851. - Pasolini [1963] 1999
P.P. Pasolini, Sottovoce a Moravia, “L’Espresso” 1963, ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, con un saggio di C. Segre, 2 voll., Milano 1999, II, 2770-2777. - Pasolini [1964] 2001
P.P. Pasolini, Una visione del mondo epico-religiosa, “Bianco e Nero” 6 (giugno 1964), ora in Id., Per il cinema, a cura di W. Siti e F. Zabagli, con due scritti di B. Bertolucci e M. Martone e un saggio introduttivo di V. Cerami, 2 voll., Milano 2001, II, 2844-2879. - Pasolini 1965
P.P. Pasolini, Il “cinema di poesia”, “Filmcritica”, aprile-maggio 1965. - Pasolini [1965a] 1999
P.P. Pasolini, [Risvolto di Alì dagli occhi azzurri], 1965, ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, con un saggio di C. Segre, 2 voll., Milano 1999, II, 2458-2459. - Pasolini [1965b] 1999
P.P. Pasolini, Intervento sul discorso libero indiretto, “Paragone” a. XV, n. 184 (1965), poi in Empirismo eretico, Milano 1972, e ora in Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, con un saggio di C. Segre, 2 voll., Milano 1999, I, 1345-1375. - Pasolini [1965c] 1999
P.P. Pasolini, La volontà di Dante a essere poeta, “Paragone” a. XV, n. 190 (1965), poi in Empirismo eretico, Milano 1972 e ora in Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, con un saggio di C. Segre, 2 voll., Milano 1999, I, 1376-1390. - Pasolini [1965d] 1999
P.P. Pasolini, Vanni Fucci, “Paragone” a. XVI, n. 194 (1965), poi col titolo La mala mimesi in Empirismo eretico, Milano 1972 e ora in Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, con un saggio di C. Segre, 2 voll., Milano 1999, I, 1391-1395. - Pasolini [1965] 2001
P.P. Pasolini, Il cinema secondo Pasolini, Intervista rilasciata a B. Bertolucci e J.L. Comolli, “Cahiers du Cinéma” 169 (agosto 1965), trad. it. in P.P. Pasolini, Per il cinema, a cura di W. Siti e F. Zabagli, con due scritti di B. Bertolucci e M. Martone e un saggio introduttivo di V. Cerami, 2 voll., Milano 2001, II, 2890-2907. - Pasolini 1966
P.P. Pasolini, Cinema di prosa e cinema di poesia, “Rinascita”, 2 aprile 1966, 26-27. - Pasolini [1966a] 1999
P.P. Pasolini, Il “cinema di poesia”, “Marcatré” 19-20-21-22 (aprile 1966), poi in Empirismo eretico, Milano 1972 e ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, con un saggio di C. Segre, 2 voll., Milano 1999, I, 1461-1488. - Pasolini [1966b] 1999
P.P. Pasolini, La fine dell’avanguardia [1966], poi in Empirismo eretico, Milano 1972 e ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, con un saggio di C. Segre, 2 voll., Milano 1999, I, 1400-1428. - Pasolini [1966c] 1999
P.P. Pasolini, Appendice Guerra civile, “Paese Sera”, 18 novembre 1966, poi in Empirismo eretico, Milano 1972 e ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, con un saggio di C. Segre, 2 voll., Milano 1999, I, 1429-1439. - Pasolini [1966a] 2001
P.P. Pasolini, Appendice a Uccellacci e uccellini, in P.P. Pasolini, Per il cinema, a cura di W. Siti e F. Zabagli, con due scritti di B. Bertolucci e M. Martone e un saggio introduttivo di V. Cerami, 2 voll., Milano 2001, I, 809-834. - Pasolini [1966b] 2001
P.P. Pasolini, Lettera aperta [agli “amici” e ai “critici milanesi” pubblicata sul dèpliant del Cinema Ritz di milano in occasione della prima del film], 1966, in Id., Per il cinema, a cura di W. Siti e F. Zabagli, con due scritti di B. Bertolucci e M. Martone e un saggio introduttivo di V. Cerami, 2 voll., Milano 2001, I, 830-831. - Pasolini [1967a] 1999
Lettura in forma di giornale del “Gazzarra”, “Nuovi argomenti” n.s. 5 (gennaio-marzo 1967), ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, con un saggio di C. Segre, 2 voll., Milano 1999, I, 1429-1439. - Pasolini [1967b] 1999
Uno scambio epistolare Pasolini-Bellocchio, [1967], in Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, con un saggio di C. Segre, 2 voll., Milano 1999, II, 2800-2815. - Pasolini [1967c] 1999
P.P. Pasolini, Lettura in forma di giornale del “Gazzarra”, su “Nuovi Argomenti” n.s. 5 (gennaio-marzo 1967), ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, con un saggio di C. Segre, 2 voll., Milano 1999, II, 2460-2480. - Pasolini [1967] 2003
P.P. Pasolini, Poeta delle Ceneri, [1967], in Id., Tutte le poesie, a cura e con uno scritto di W. Siti, saggio introduttivo di F. Bandini, 2 voll., Milano 2003, I, 1261-1288. - Pasolini [1969] 1999
P.P. Pasolini, Diario del “caso Lavorini” [1969] in Id., Saggi sulla politica e sulla società, a cura di W. Siti e S. De Laude, con un saggio di P. Bellocchio, Milano 1999, 181-197. - Pasolini [1970] 1999
P.P. Pasolini, Il cinema impopolare, “Nuovi Argomenti” 20 (ottobre-dicembre 1970), poi in Empirismo eretico, Milano 1972 e ora in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, con un saggio di C. Segre, 2 voll., Milano 1999, I, 1600-1610. - Pasolini 1972
P.P. Pasolini, Empirismo eretico, Milano 1972. - Pasolini [1955-1975] 1988
P.P. Pasolini, Lettere 1955-1975, a cura di N. Naldini, Torino 1988. - Schiaffini 1959
A. Schiaffini, Testimonianze sulla lingua della poesia che “si fa prosa senz’esser prosa”, in Id. (a cura di), Studi sulla letteratura dell’Ottocento in onore di Pietro Paolo Trompeo, Napoli 1959, 529-548 (con un altro titolo e alcune modifiche anche in Id., Mercanti, poeti, un maestro, Milano-Napoli 1969). - Siti 1981
W. Siti, P.P. Pasolini, in 10 poeti contemporanei, a cura di M. Martelli, Firenze 1981, 143-158. - Siti 1989
W. Siti, Il sole vero e il sole sulla pellicola, o sull’espressionismo di Pasolini, “Rivista di letteratura italiana” VII, 1 (1989), 97-131. - Siti 1998
W. Siti, Tracce scritte di un’opera vivente, in P.P. Pasolini, Romanzi e racconti, I, a cura di W. Siti e S. De Laude, 2 voll., Milano 1998, I, L-LI. - Siti et alii 2003
P.P. Pasolini, Tutte le poesie, a cura e con uno scritto di W. Siti et alii, saggio introduttivo di F. Bandini, 2 voll., Milano 2003, I, 1453-1774, II, 1507-1800. - Siti 2015
W. Siti, Pasolini e la paura del teatro, in Atti della giornata di studi Pasolini e il teatro, a cura di G. Manacorda, Roma 2015. - Siti, Zabagli 2011
P.P. Pasolini, Per il cinema, a cura di W. Siti e F. Zabagli, con due scritti di B. Bertolucci e M. Martone e un saggio introduttivo di V. Cerami, 2 voll., Milano 2011. - Šklovskij [1927] 1971
V. Šklovskij La poesia e la prosa al cinema, 1927, trad. it. in I formalisti russi nel cinema, a cura di G. Kraiski, Milano 1971. - Soldati 1966 > Soldati [1966] 2005
M. Soldati, Recensione a I pugni in tasca, in “Il Giorno”, 28 dicembre 1966 (ora anche parzialmente in A. Costa, Marco Bellocchio. I pugni in tasca, Torino 2005, 140-143). - Tiezzi 2012
F. Tiezzi, Il teatro di poesia, in S. Casi e G. Guccini (a cura di), Pasolini e il teatro, Venezia-Casarsa della Delizia 2012, 381-385.
English abstract
The opinion Pasolini had about I pugni in tasca, a “film of prose” flowing into “poetry”, has always been considered ad diminutionem, mainly towards the qualification of “prose movie” unreservedly ascribed to Bernardo Bertolucci’s Prima della rivoluzione, released the previous year. This paper tries to point out this is not at all true, and that I pugni in tasca is an example of the films Pasolini was much concerned with. To this end, it proposes a close reading of Pasolini’s letters and writings, not exclusively in cinematographic arguments.
keywords | Pier Paolo Pasolini; Marco Bellocchio; I pugni in tasca; Fists in the Pocket; 'prose' cinema; 'poetry' cinema.
La Redazione di Engramma è grata ai colleghi – amici e studiosi – che, seguendo la procedura peer review a doppio cieco, hanno sottoposto a lettura, revisione e giudizio questo saggio
(v. Albo dei referee di Engramma).
Per citare questo articolo / To cite this article: S. De Laude, “Cinema di prosa” e “cinema di poesia”, tertium datur. Su Pier Paolo Pasolini e I pugni in tasca di Marco Bellocchio, “La Rivista di Engramma” n. 172, marzo/aprile 2020, pp. 25-64 | PDF di questo articolo