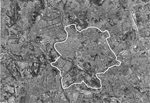L'arco trionfale e onorario romano
Vincenzo Fontana, Paolo Morachiello
Apparato iconografico a cura di Alessandra Pedersoli
La liturgia del trionfo
A Roma il trionfo (triumphus) costituiva il più solenne riconoscimento tributato a un condottiero che avesse riportato una schiacciante vittoria sul nemico. Le condizioni per ottenerlo erano vincolanti e precise. La celebrazione era legata a una delibera del Senato su richiesta dell’interessato. Per aspirare a un tale riconoscimento e a un tale onore, il condottiero doveva essere stato investito dell’imperium maius e aver esercitato, il giorno della battaglia, l’autorità suprema. Inoltre, la vittoria doveva essere stata riportata in una guerra contro un popolo straniero e non in una guerra civile, contro altri cives romani; dovevano essere stati uccisi in una sola battaglia non meno di cinquemila nemici e il successo doveva essere stato completo e decisivo. Le ingenti spese che la cerimonia del trionfo comportava venivano assunte dallo Stato a delibera senatoriale avvenuta.
In attesa della delibera, inoltre, il condottiero con il suo esercito, reduce dalla campagna vittoriosa ma macchiato di sangue e di morti, pena l’ignominia doveva attendere fuori dal pomerio, il recinto sacro dell’Urbe, non varcare questa fascia ritenuta sacra senza consenso, fino a che l’imperium non fosse stato rimesso nelle mani del Senato e riconsegnato ritualmente a Giove, nel suo tempio sul Campidoglio. Nella sosta, talvolta lunga, il candidato al trionfo e il suo esercito si accampavano nel Campo Marzio. Accordato il trionfo da parte del Senato, nel giorno stabilito veniva celebrata l’imponente cerimonia di carattere sacro e militare. Il corteo si formava nel Campo Marzio ed entrava in città dalla Porta Triumphalis, attraversava il Velabrum e il Circus Maximus, percorreva la Via Sacra e il Foro, ascendeva il Clivus Capitolinus e si fermava davanti al tempio di Giove.

Un trionfo ‘all’antica’ secondo la fantasia di Cecchino Salviati (Francesco de’ Rossi) nel Trionfo di Camillo, 1545 ca.,
Firenze, Palazzo Vecchio, Sala delle Udienze
Il Senato al completo guidava il corteo, seguivano i suonatori di corni e trombe che, a loro volta, precedevano i carri carichi delle spoglie del nemico e del bottino di guerra, i cui oggetti di maggior pregio e valore viaggiavano su apposite portantine; erano quindi condotti gli animali destinati al sacrificio. Dietro le vittime designate incedeva il gruppo dei sacerdoti pubblici del popolo romano con i suoi assistenti, seguivano i vessilli e i trofei composti con le armi sottratte al nemico, nonché i prìncipi e i notabili dei vinti con le loro famiglie e prigionieri di minor rango in catene. Preceduto dai littori con i fasci ornati da ghirlande di alloro, avanzava quindi il protagonista del giorno solenne, ritto sul carro trionfale. Il carro del trionfatore era del tipo a forma di tino, aperto sul retro, ed era trainato da quattro cavalli affiancati. Il trionfatore vestiva la ricca toga picta e aveva la fronte cinta di verde alloro mentre con la destra recava un ramoscello della stessa pianta. Dietro di lui un servo pubblico teneva sospesa sul suo capo una corona d’oro a foglie di lauro, ornata di gemme. I suoi figli minori potevano avere posto con lui sul carro, quelli più grandi seguivano subito dopo a cavallo.
Dietro al gruppo del trionfatore venivano gli ufficiali superiori, tutti a cavallo; il corteo trionfale era chiuso dall’interminabile sfilata dell’intero corpo delle legioni. I legionari, recando in mano un ramoscello e sul capo ghirlande di alloro, gridavano “iò triumpe!” – invocazione rituale per l’epifania della divinità, legata ai culti bacchici – o intonavano i carmi trionfali composti in onore del loro dux – e, di quando in quando, lanciavano frizzi, anche salaci, al suo indirizzo.
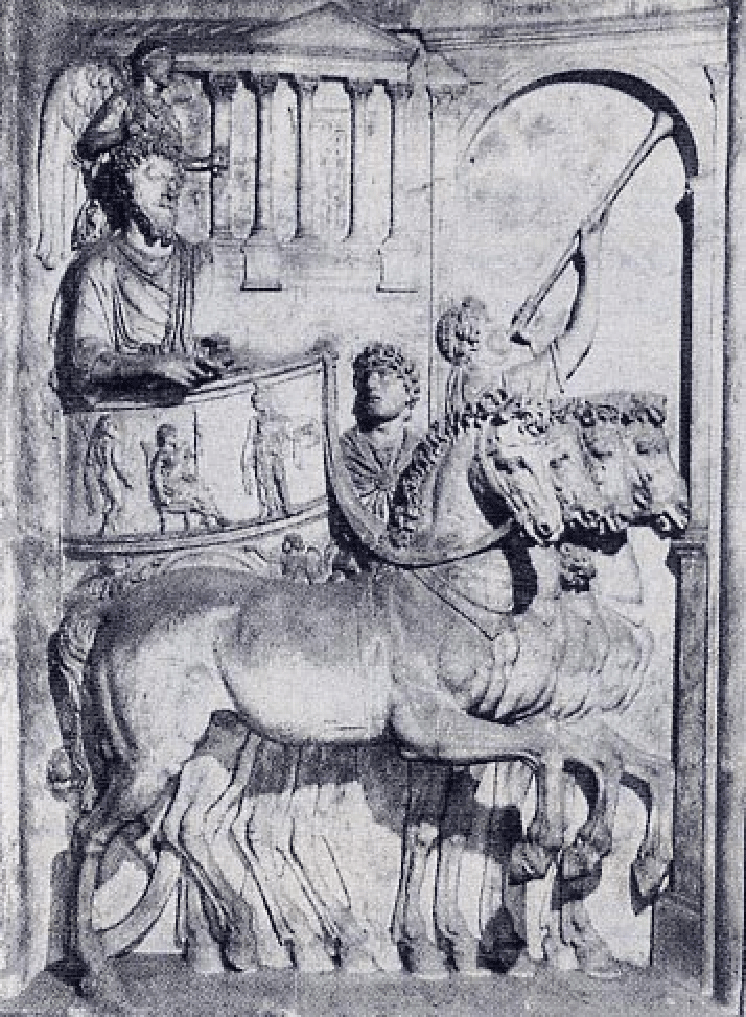
Marco Aurelio in trionfo su un rilievo lapideo, Roma, Palazzo dei Conservatori
Era uso che il trionfatore portasse al collo una bulla, un pendente con amuleti, per scongiuro. Si vuole infatti che il servo ritto dietro di lui sul carro trionfale ripetesse, con le acclamazioni più vive della folla, anche il monito "memento mori": il trionfatore era un uomo, e doveva ricordare la propria mortalità. Giunto infine al Campidoglio, il trionfatore rimetteva le insegne del potere offrendo a Giove Ottimo Massimo il ramoscello di alloro che teneva in mano e quelli che decoravano i fasci dei littori, quindi compiva il sacrificio. A chiusura dei festeggiamenti, un banchetto riuniva i magistrati e i senatori, mentre venivano distribuite cibarie ai soldati e al popolo.
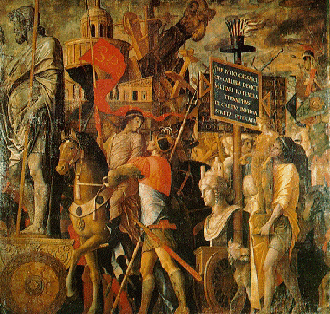
London, Hampton Court Palace, Il trionfo romano secondo l’interpretazione di Andrea Mantegna dalla serie dei Trionfi di Cesare, 1486 ca.,
Per una pompè tanto solenne ed elaborata i Romani idearono ed apprestarono un edificio in forma di porta di passaggio (portus e passus) che comportasse, come tutti i passaggi, un cambiamento di stato o di condizione: nel caso specifico, che preparasse per il trionfatore e il suo esercito il ritorno alla condizione di normalità dopo la guerra, e in particolare il ritorno all’innocenza e alla pietas dopo le uccisioni e le stragi compiute. Idearono e apprestarono, dunque, l’arco trionfale o onorario: il tipo monumentale dell’arco non si comprende senza l’immagine del trionfo e del corteo che lo avrebbe attraversato, ovvero senza tener conto del significato metaforicamente celebrativo non solo di una guerra vinta, ma anche di un’impresa civile condotta a buon esito.
La forma e il significato. Genealogia e tipologia dell’arco trionfale e dell’arco onorario
A differenza della porta di città, formalmente accostabile ad esso, l’arco è un monumento celebrativo e onorario, destinato a fissare per sempre il ricordo di un personaggio illustre della Repubblica, e in seguito dell’imperatore, in occasione di un particolare evento (sulla fortuna dell'arco romano come monumento genericamente trionfale nel Quattrocento vedi il contributo di Pisani e Pizzigoni in engramma).
In questo senso, nel suo esito formale più diffuso, l’arco onorario e trionfale è una creazione propria e originale dell’architettura romana, e ogni grande città dell’Impero ne fu dotata.
Se durante la Repubblica, stando alle testimonianze letterarie, epigrafiche e numismatiche, gli archi furono innalzati in onore dei generali vittoriosi, durante l’Impero l’arco diventa uno dei principali monumenti di celebrazione della gloria dell’imperatore, trionfatore con le proprie forze e per azione diretta, o attraverso quella dei generali che avevano combattuto in suo nome. In lettere di bronzo dorato, l’arco reca infatti la dedica del Senatus Populus Que Romanus all’imperator e l’allusione all’impresa. Molto più raramente, senza mutar forma e significato, archi furono dedicati a (o da) una comunità cittadina che ‘passava’ a un diverso stato giuridico o a un più alto rango. Non mancano infine esempi di archi onorari eretti in ricordo di una gens, di alti magistrati o delle alte virtù di cittadini benemeriti.
Nelle pagine degli storici e dei poeti e nelle epigrafi dedicatorie, un’opera di tal genere è detta arcus o fornix, più raramente ianus, con l’eventuale aggiunta di un aggettivo che ne specifica il materiale di costruzione o di rivestimento (per esempio, marmoreus), o di una locuzione che allude genericamente all’esistenza di decorazione architettonica e scultorea (cum ornamentis), o ancora di una locuzione che precisa le caratteristiche dell’ornamentazione (cum statuis, cum quadrigis, cum insignibus triumphorum) – sulle fonti relative all’arco onorario e trionfale romano vedi il contributo specifico pubblicato in questo numero di “Engramma”.
In termini generali, il tipo monumentale dell’arco onorario consiste di un corpo murario parallelepipedo isolato e indipendente, di notevole spessore e di limitata lunghezza, entro cui si aprono uno o tre passaggi coperti a volta, in casi rarissimi due. I passaggi risultano, di conseguenza, delimitati da robusti pilastri portanti sviluppati in profondità, con muratura piena che prosegue sopra gli estradossi dell’archivolto o degli archivolti (l’arco o gli archi con cui la volta si delinea sui fronti), fino a una trabeazione continua corrente lungo l’intero perimetro a una quota intermedia. La trabeazione è a sua volta sormontata da un blocco superiore in forma di attico, elevato per far da basamento a statue onorarie: quadrighe, trofei, sculture allegoriche scolpite nel marmo o fuse nel bronzo – quasi sempre di grandissimo pregio artistico e materiale, che risultano però sempre tolte dalla loro positura originale e, nel corso del tempo, riusate altrove, disperse, fuse.


Archi di Druso e di Tiberio con statua equestre, su monete di Tiberio e Claudio; archi trionfali con quadriga, su monete di Nerone
Dai fronti del blocco pieno sbalzano lesene o semicolonne, o avanzano colonne libere, semplici o doppie, poste su di uno zoccolo comune o su singoli piedestalli propri; ad esse corrispondono risalti delle sovrastrutture – trabeazione e attico – con infinite varianti di soluzioni: sbalzi in corrispondenza delle singole colonne o di gruppi di colonne, al centro o sui lati, con l’eventuale aggiunta di timpani triangolari o curvilinei. La volta, secondo la soluzione più diffusa, si imposta sopra una cornice che individua e stabilisce l’altezza dei pilastri o dei piloni veri e propri – sia all’esterno che all’interno del passaggio – e li distingue dalla muratura piena soprastante, delimitata dalla trabeazione. Con l’evolversi dell’uso delle membrature architettoniche, in direzione di una maggior ricchezza e libertà compositiva, non solo aumentarono da uno a tre i passaggi, ma si estesero in ogni parte le sculture. Nel disegno dell’arco, il passaggio centrale acquista una misura notevolmente maggiore dei laterali, e tra III e IV sec. d.C. l’arco a tre aperture diviene il tipo più diffuso, particolarmente nelle province orientali. Contemporaneamente, il rilievo si guadagna un ruolo centrale nella costruzione del significato celebrativo dell’arco, e sempre maggiore spazio sulle superfici delle facce principali e laterali dell’arco: sugli zoccoli delle colonne, sulle mensole delle chiavi degli archivolti – cui si prestano soprattutto teste e busti di divinità – sulle volte stesse, sugli spicchi al di sopra dell’archivolto (nei quali si dispiegano le figure di Vittorie alate in volo obliquo), e ancora sulle campiture libere dei pilastri tra archivolti e trabeazione, sulla trabeazione, talora sulle superfici dell’attico. Proprio l’uso libero degli ordini e dell’ornamentazione contribuisce a conferire autonomia e dignità di facciata anche ai lati brevi dell’arco.

L’arco di Settimio Severo e Caracalla tra i Rostra e la Curia del Foro, 203 d.C.
Poteva anche avvenire, soprattutto nelle colonie di nuova fondazione, che un arco fosse costruito all’incrocio di due strade di pari importanza: esso era allora quadrifronte o tetràpilo, ossia con un fronte su ciascuno dei quattro bracci del crocevia, e un passaggio per fronte compreso tra due pile (ciascuna sempre comune a due fronti contigui). Rari in occidente, più diffusi in Africa e nelle province orientali, i tetràpili presentano membrature e decorazioni simili a quelle degli archi bifronti. Nello spazio centrale le volte a botte, incrociandosi, generavano una crociera o sostenevano una cupola emisferica o cuspidata.
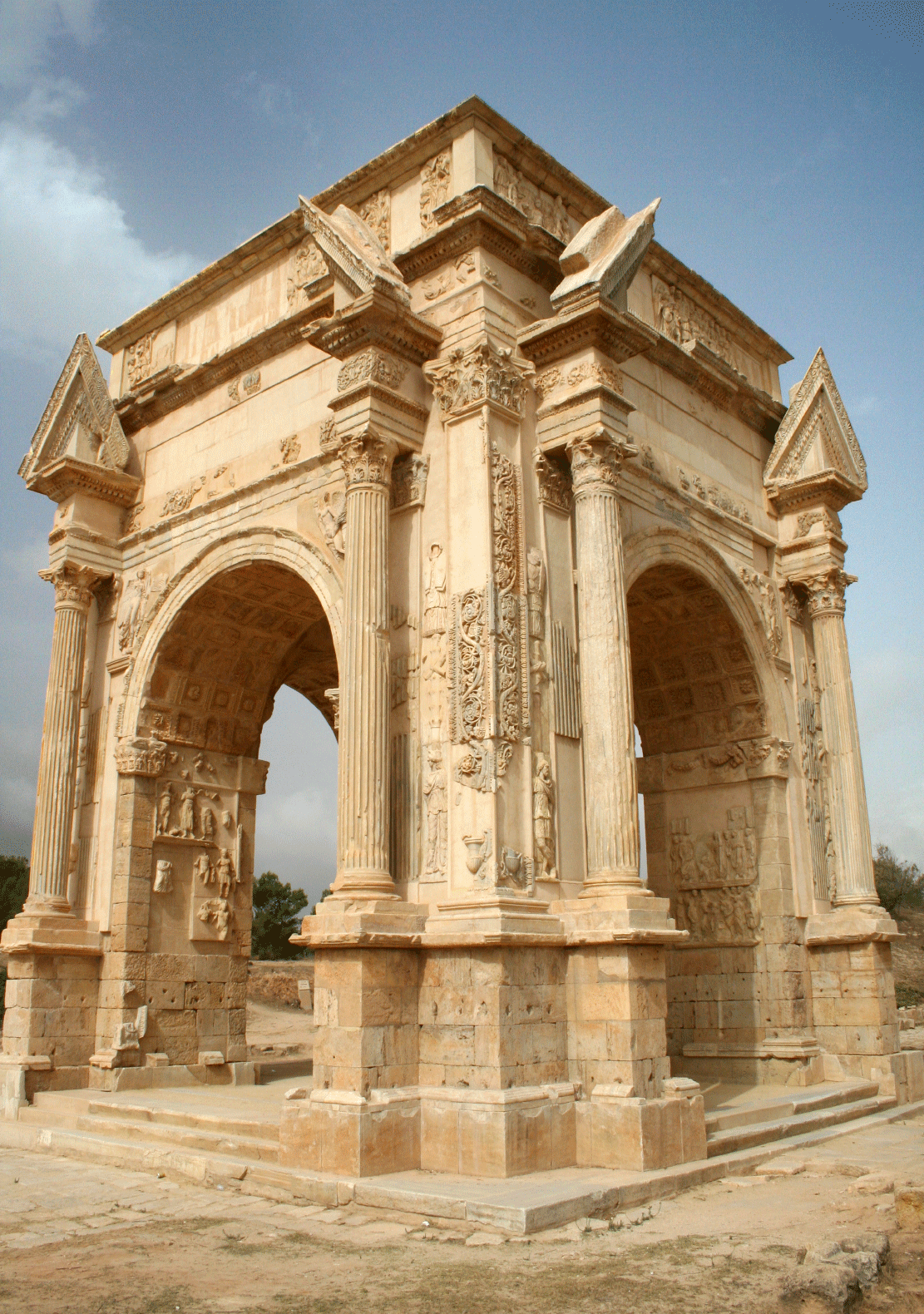
L’arco quadrifronte di Settimio Severo a Leptis Magna, 200 d.C.
A Roma e nella penisola italica, dalla Repubblica ai Giulio-Claudii
|
Roma |
Italia e province alpine |
La letteratura testimonia del contributo recato dai massimi condottieri alla definizione del modello architettonico dell’arco quando ne promossero essi stessi la costruzione: Livio e Cicerone, per esempio, raccontano, il primo, di un arco eretto da Scipione l’Africano nel 190 a.C. sul Campidoglio (Livio, XXXVII, 3,7); il secondo, di un arco fatto innalzare nel 120 a.C. nel Foro da Q. Fabio Massimo per celebrare la sua vittoria sugli Allobrogi (Cicerone, In Verrem, I, 1, 19). La posizione lungo la Via Sacra di quest’ultimo, induce a immaginarlo anche con funzione di propileo d’ingresso al Foro, ipotesi rafforzata indirettamente dal precedente arco a tre fornici di Cosa del 170 a.C. (di cui è conservato il basamento) che segnava l’entrata al centro cittadino civico e religioso; se risulta difficile definire, sia pur sommariamente, l’aspetto dei primi archi romani ricordati dalle fonti, si può verosimilmente ipotizzare, però, che essi non fossero strutture del tutto autonome e isolate, ma che, accogliendo statue-ritratto di bronzo o di marmo dei promotori e finanziatori, costituissero un varco monumentale entro un continuum di costruzioni adiacenti.
Il primo arco trionfale definito nella sua completezza e peculiarità apparve nel 40-30 a.C. ad Aquino, nel Lazio. In questo arco isolato, che precede l’accesso alla città, interamente costruito con cunei monolitici di travertino locale, l’archivolto cade su colonnine di genere ionico incassate nella massa muraria, gli spigoli dei piloni sono rafforzati da semicolonne binate di genere corinzio, oltre la cui trabeazione si elevava verosimilmente un attico (non conservato).

Con colonne o paraste minori a sostegno dell’archivolto che segna l’apertura di entrata, con paraste o semicolonne o colonne maggiori che la inquadrano e reggono la trabeazione oltre la quale si sviluppa il corpo pieno dell’attico o, in altri termini, con l’associazione o la compenetrazione di due sistemi di sostegni verticali di diverso spessore e diversa altezza, gli artefici della Repubblica fissarono un nuovo sintagma, un sintagma tutto romano proprio dell’arco e suscettibile di molte variazioni, ben trentaquattro schemi diversi individuati dagli archeologi.
Dal tramonto della Repubblica alla vigilia del Principato l’arco trionfale e l’arco onorario – come preconizzava il loro simile significato – si fusero o si confusero, divenendo o venendo via via sempre più considerati monumenta ufficiali per eccellenza a proposito dei quali solo il Senato poteva legiferare, anche entrando spesso (e volentieri) in merito all’iconografia da sviluppare. Una iscrizione in bronzo trovata nel sud della Spagna – la cosiddetta Tabula Siarensis – consiglia i soggetti da scolpire nei rilievi, il genere e la varietà delle figure dei gruppi statuari da posare sugli attici. Con l’avvento e l’affermazione universale del principato gli archi si proposero sempre più come testimonianze di vittorie che avrebbero indotto non sopraffazione e schiavitù, bensì pacificazione e benessere universali assicurate dalle virtù politiche, militari e morali del princeps e, per estensione, del popolo romano. Essi si moltiplicarono, come è stato detto con felice espressione, quali strumenti di diffusione di una “teologia della vittoria”: in un’era di assenza di guerre fratricide, un potere che perseguiva giustizia, magnanimità, accordo con gli dei, nella vastità di un immenso Impero.
Gli archi voluti personalmente da Augusto e di fatto costruiti in Roma nei luoghi da lui indicati sono scomparsi, né sono ricordati da iscrizioni o descrizioni ad essi contemporanee. Al silenzio delle fonti di età augustea suppliscono, tuttavia le notizie trasmesse più tardi da Dione Cassio (XLIX, 15, 1) che menziona sia un arco eretto in un luogo imprecisato dell’Urbe per celebrare la vittoria riportata nel 36 a.C. a Nauloco da Ottaviano su Sesto Pompeo, sia due archi innalzati nel Foro a nord e a sud del tempio del Divo Giulio: uno – precisa Dione – detto Arco ‘Aziaco’ per commemorare la vittoria di Azio del 31 a.C., uno detto ‘Arco Partico’ per immortalare l’atto di riconsegna nel 20 a.C. delle insegne che i Parti avevano sottratto alle legioni di Crasso (Dione Cassio LI, 19, 1; LIV, 8, 3-4).

Gli archi, però, furono verosimilmente soltanto due, poiché si è argomentato a ragione (Paul Zanker) che l’arco ‘Aziaco’ altro non fosse che la conversione del precedente ‘Naulochico’ costruito non in un luogo imprecisato ma nel Foro. Alle parole di Dione Cassio si possono fortunatamente accompagnare le immagini-messaggio impresse sulle monete contemporanee (sul rapporto tra gli archi onorari e le loro immagini numismatiche vedi il saggio di Giacomo Calandra in questo numero di "Engramma").
Dai rovesci dei denari di Augusto si può affermare che l’Arco di Nauloco era a un solo fornice decorato con clipei sui piloni e figure alate nelle cantoniere tra archivolto e trabeazione, sormontato da un attico con quadriga trionfale e dedica a Ottaviano Caesar e Imperator.
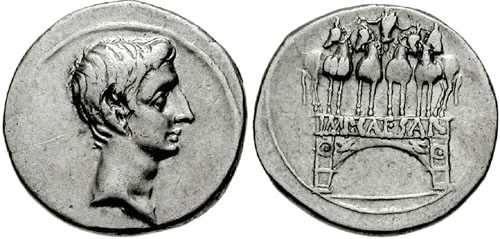
Alcune monete coniate in Spagna fra 18 e 17 a.C. raffigurano molto probabilmente l’ 'Arco Partico’ a tre fornici sostenuti da coppie di colonne doriche (un poderoso capitello con echino rigonfio decorato a ovuli giace oggi nel Foro): il fornice centrale sormontato da un attico su cui posavano la quadriga imperiale e guerrieri Parti in atto di restituire le insegne, i fornici laterali conclusi dalla sola trabeazione. Più difficile risulta l’individuazione di un terzo arco rappresentato sul rovescio di un denario coniato da L. Vinicio: tuttavia, grazie al confronto delle immagini con alcuni resti ritrovati nel Foro a sud del tempio del Divo Giulio, è lecito supporre che si tratti dell’arco ‘Aziaco’ (il ‘Naulochico’ modificato) a tre fornici, dei quali il centrale arcuato tra semicolonne, trabeazione, targa e attico, i laterali chiusi da semplici architravi retti da colonne e dotati di timpani con acroteri a guisa di arcieri. L’arco ‘Partico’ sarebbe stato in seguito convertito in un portico, collegato al Chalcidicum dedicato a Gaio e a Lucio.
Le province parteciparono con prontezza alla celebrazione del Principato e delle sue imprese pacifiche e guerriere, erigendo archi che poco ebbero da invidiare a quelli della capitale. Nel 27 a.C. a Rimini la porta di entrata orientale alla città fu sostituita da un arco commemorativo (non vi è infatti traccia alcuna di meccanismi di chiusura), il primo di tal genere dedicato dal Senato ad Augusto per aver promosso la sistemazione della via Flaminia che giungeva proprio in quel punto.
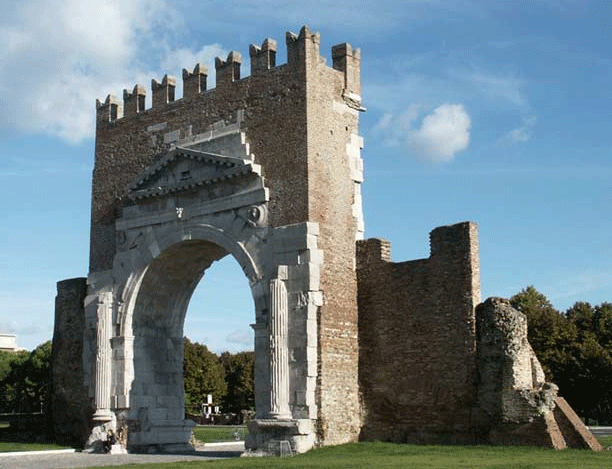
Fondato su piattaforma di calcestruzzo e inserito tra due torri quadrate, costruito in blocchi impeccabilmente scolpiti e connessi di pietra d’Istria, l’arco a unica apertura è inquadrato in entrambi i fronti da semicolonne scanalate di genere corinzio, ciascuna su proprio piedestallo, reggenti, tramite pulvino, una trabeazione continua sormontata da un timpano triangolare (tra i primi esempi di Theatermotiv applicato agli archi). L’archivolto è chiuso in chiave da una protome leonina, simbolo della città; nei pennacchi sono inseriti clipei con le teste delle divinità protettrici a conferma del carattere sacro della struttura e della volontà di sacralizzare il suo ‘augusto’ promotore.
L’arco a unico fornice o passaggio fu generalmente il preferito (forse per ragioni economiche) dai centri minori italici, nonostante l’incoraggiamento a favore dei tre fornici offerto dai monumenta celebrativi del Foro Romano. L’Arco di Aosta fu eretto dopo il 25 a.C. per decreto del Senato contemporaneamente alla fondazione della colonia e, come quello di Aquino, sorse dinnanzi alle mura urbane nel punto in cui iniziava la via che, attraverso le Alpi Graie, si dirigeva a Lione.

Di carattere celebrativo (la vittoria sui locali Salassi), l’arco valdostano dedicato ad Augusto si può considerare il capostipite degli archi onorari di età imperiale: l’unico, largo fornice dichiarato da un ampio archivolto posato su brevi parastine, si apre nel corpo costruito in blocchi di puddinga locale ed è serrato tra coppie di semicolonne di genere corinzio (ma con basi attiche) prive di scanalature, poste su di un alto podio continuo, che condividono con i tozzi supporti dell’archivolto. Le semicolonne più vicine reggono un tratto di trabeazione di genere dorico in risalto; le estreme, poste di 3/4 negli angoli, sostengono segmenti aggettanti della stessa, e sono accompagnate da semicolonne intermedie collocate anche sui fianchi. L’attico che quasi certamente lo coronava fu demolito in tempi moderni, e sostituito da un tetto a falde (dell'Arco di Aosta pubblichiamo in questo numero di engramma un rilievo grafico).
L’Arco di Susa, posto nel 9-8 a.C. dinnanzi alle mura della capitale di un piccolo regno ai piedi del Moncenisio, fu dedicato ad Augusto da Cozio, re dei Segusii, che divenne prefetto di molte città delle Alpi Cozie in seguito alla sottomissione a Roma. Incomparabilmente più elegante e raffinato di quello aostano, il corpo dell’arco segusino, slanciato, rivestito di marmo bianco di Foresto, si apre con unico fornice segnato da un archivolto posato su pilastri corinzi, lisci e incassati, con diretta partenza dalla piattaforma emergente di fondazione.

Dagli angoli dei piloni si distaccano per tre quarti colonne scanalate di genere corinzio, ciascuna su proprio piedestallo posato sulla stessa crepidine dei piedritti. La trabeazione, tangente all’archivolto, reca un fregio continuo a rilievo con scene del patto stipulato tra il re ed Augusto, e del sacrificio plurimo – di una scrofa, di una pecora e di un toro, chiamato suovetaurilia – che l’accompagnò, opera di artefici romani uniti a quelli locali. Un attico trabeato di coronamento tramanda con la sua estesa iscrizione i termini del patto facendo di quest’arco un eccezionale monumento alla politica di Augusto. Quest’arco valligiano sembra risolvere con apparente disinvoltura, accettandolo senza compromessi, il problema compositivo cruciale dell’arco, vale a dire la stretta vicinanza e l’appartenenza allo stesso volume di due membrature verticali necessariamente di grandezza e scopo diversi, le minori a segnare il cammino della componente verticale della sollecitazione all’imposta dell’archivolto, le maggiori a inquadrare il varco e gli spigoli angolari del corpo pieno, a reggere (in minima parte realmente) la trabeazione e a recare l’apporto del loro ornamento. Nel caso dell'arco di Susa, il calibrato crepidoma di comune appoggio e di ugual partenza delle membrature, proporzionando assai bene gli spazi che le separano e le altezze che le distinguono, crea una figura di misurata convivenza sullo stesso piano dei due sistemi.
In alcuni casi anche le casate patrizie delle città soggette, emulando la famiglia imperiale, vollero erigere un arco per commemorare il proprio nome. La gens Gavia edificò in età augustea un arco in pietra bianca nell’area cimiteriale di Verona, la propria città lungo la Via Postumia.

L' Arco dei Gavi (un contributo di approfondimento è pubblicato in questo stesso numero) èun vero tetrapilo con pianta e piloni rettangolari. Nei due fornici dei fronti maggiori gli archivolti cadono su corpose lesene, decorate da candelabre vegetali strette tra coppie di semicolonne interne e tre quarti di colonne angolari, tutte di genere corinzio, scanalate, posate ciascuna su proprio distinto piedestallo appena in risalto da un unico podio di unione; i fornici dei lati minori appaiono semplificati con archivolti più bassi, privi di lesene e racchiusi tra le due colonne angolari. Due timpani triangolari in corrispondenza degli archi sui fronti principali, aggettano lievemente dal corpo unificante dell’attico. I contratti intercolumni dei fronti serrano alte edicole destinate alle statue dei Gavi, la cui presenza, unita alla localizzazione, induce a ritenere l’arco un monumento che assunse anche valenze commemorativo-funerarie. La soluzione abbracciata della posa della partenza dei supporti – di genere, altezza e scopi diversi – è qui a favore (com’era stato accennato ad Aosta) della stretta compenetrazione dei due sistemi innalzati entrambi, però, da un podio comune e con la massima risolutezza dal suolo, con effetti conseguenti di massima imponenza nell’articolarsi dell’intero edificio a quota ben superiore del piano di attraversamento.
La famiglia istriana dei Sergii costruì sul finire del principato di Augusto il proprio arco in pietra d’Istria dinnanzi a una porta delle mura di Pola.

Sulle facce dei piloni, coppie formate ciascuna da una semicolonna e da una colonna angolare di tre quarti, di genere corinzio e scanalate, a stretto contatto con i piedritti di sostegno dell’archivolto da un podio comune di partenza, dominano con forza il varco, come a Verona, ben al di sopra del piano di attraversamento. Nei pennacchi, Vittorie alate recano serti di alloro; la soprastante trabeazione con bucrani e ghirlande segue risalti e rientranze sottostanti, alle quali fanno eco i tre piedestalli che ritmano l’attico con le iscrizioni e i gruppi statuari conclusivi, di un personaggio solitario al centro e personaggi coronati da Vittorie agli estremi, vero rovesciamento della tradizione.
A cominciare dal principato di Tiberio, nella penisola italica si innalzano archi nei Fori a lato dei templi, come a Spoleto fu l’arco a unico fornice dedicato a Germanico e a Druso Minore.

La sua architettura è molto semplice: un basso podio unisce, come ad Aosta, le paraste pseudocorinzie che inquadrano l’arco e segnano gli spigoli, sporgendo appena dai piloni costruiti con grandi blocchi di pietra squadrata.
A Carsule sorsero in età giulio-claudia due tetrapili, uno settentrionale e uno meridionale, in segno di raccordo tra la Via Æmilia e il Foro; i fornici di entrambi, costruiti di blocchi di pietra calcarea, erano privi su ogni faccia di membrature di inquadramento e sollevati dal piano plateale a mezzo di gradini che testimoniavano, pur nella ridotta dimensione, una qualche pretesa o ambizione trionfale.
Similmente a Ercolano, nel periodo compreso tra i principati di Tiberio e di Claudio, in occasione di interventi di rinnovo urbano, sorsero due archi tetrapili o quadrifronti: il primo nei pressi del Foro, il secondo sul decumano massimo; ciò non esclude che avessero anche significati celebrativi simili agli archi ufficiali della capitale, come testimonierebbero gli avanzi di una quadriga in bronzo ritrovati nella città.
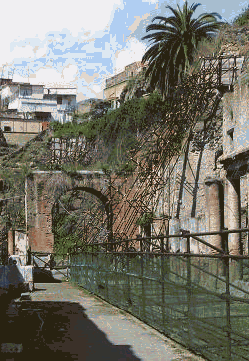

Nelle province occidentali, in età augustea e giulio-claudia
|
penisola iberica |
Gallia e Germania |
Il modello metropolitano dell’arco trionfale od onorario si diffuse, senza subire modifiche importanti, nelle Spagne e nelle Gallie soprattutto con l’intento di celebrare più stretti legami e connessioni fisiche permanenti tra le terre e le province dell’Impero e, di conseguenza, gli archi furono posti come segnali dell’espansione piena, ovunque accettata, della civiltà e della cultura di Roma.
Tra i primi, risalente agli ultimi due decenni del I sec. a.C., un arco lungo la via Augusta nei pressi di Tarragona

Si tratta di un corpo isolato a unico fornice, con piedritti di sostegno dell’archivolto nascenti dallo stesso podio, da cui nascono due coppie per banda di lesene corinzie scanalate d’inquadramento e a sostegno di una trabeazione a fregio liscio priva di risalti o rientranze; il passaggio si delinea spontaneamente e senza enfasi nel corpo pieno, accettando la nobilitazione dell’ornamento e creando in tal modo una figura o soluzione formale della compenetrazione e convivenza tra i due sistemi, archivolto e piedritti e lesene o semicolonne d’inquadramento, in cui il primo è dominato e tenuto dal secondo.
Nella stessa provincia, e quasi contemporaneo del precedente, è un altro arco terragonese dedicato alla memoria di Lucio Cesare, e quindi risalente al medio periodo augusteo, un arco montano posto all’ingresso di un villaggio sulla via che dalla costa conduceva all’interno è il più antico arco a tre fornici che si sia conservato fuori di Roma e d’Italia.

Il suo corpo in opus caementicium rivestito da blocchi di granito, lungo e stretto come una quinta, è suddiviso orizzontalmente in tre fasce: alla prima corrispondono i piedritti del varco centrale e i varchi laterali di minime dimensioni ma resi energici dai cunei dei loro archivolti; alla seconda corrispondono l’archivolto centrale dall’ampio respiro e, oltre il marcapiano creato dal prolungamento delle sue imposte, due edicole sormontate da timpani triangolari retti da lesene scanalate; la terza fascia, al di sopra di una prima cornice, altro non è che un attico di due soli filari di conci, recante l’iscrizione dedicatoria e coronato dalla seconda definitiva cornice di chiusura scolpita. La sovrapposizione di edicole agli archi laterali, che esalta il varco centrale ma articola e anima contemporaneamente i piloni laterali, riscuoterà successo e sarà ripetuta o reimmaginata in molti luoghi dell’Impero.
Gli archi onorari della provincia Narbonense spiccano per una particolare esuberanza decorativa, che li distingue dagli esempi laconici della Cisalpina (Aosta e Susa). A Saint-Remy l’arco fu costruito nel secondo decennio del I secolo d.C. per commemorare la fondazione della colonia da parte di soldati della II Legione di Augusto.

Il monumento sorge dinnanzi all’entrata della cinta settentrionale a cavallo della Via Domitia, in asse con il decumano massimo della città. L’archivolto si avvale di una densissima decorazione, composta da una ghirlanda di frutta e altri prodotti dei campi; i suoi piedritti nudi e levigati poggiano con base semplice liscia su di un crepidoma emergente con forza dal suolo, da cui si eleva ugualmente l’alto podio a tratti aggettante, per formare i piedestalli delle semicolonne scanalate che ornano e chiudono i piloni laterali. Nei quattro intercolumni così formati (una coppia per fronte) le sculture a grandezza naturale ricordano la conquista delle Gallie, con prigionieri seminudi legati a trofei, mentre Vittorie alate popolano le cantoniere. La volta interna è decorata a esagoni e rosoni, e vi era sicuramente l’attico di coronamento con la targa dedicatoria. La snellezza ricercata per le semicolonne ornamentali d’inquadramento, ciascuna su propri piedestalli legati ed emergenti da un podio comune di sfondo, esalta per contrasto la forza attribuita all’apertura del varco, al profilo dell’archivolto e ai piedritti di sostegno dichiaratamente indipendenti dal podio, mentre l’accentuato crepidoma comune di partenza crea una figura di stretta convivenza dei due sistemi, a favore della relativa preminenza del secondo.
Nell’arco di Orange i tre fornici sono inquadrati da semicolonne e tre quarti di colonna di genere corinzio su propri distinti alti piedistalli, mentre i loro piedritti sorgono direttamente da una base a quota del suolo; il tratto della trabeazione in lieve risalto in corrispondenza del fornice centrale è coronato da un timpano stagliato sul piano dell’attico soprastante, ugualmente movimentato.

In tempi successivi fu elevato un secondo attico articolato con forza da risalti in corrispondenza sia del fornice centrale sia dei fornici laterali. A tale movimentata composizione, basata su un crescendo di masse pesanti, si aggiunge una ricchissima decorazione, che invade gran parte delle superfici: girali vegetali negli stipiti, ghirlande negli archivolti, trofei di armi di ogni genere negli spazi soprastanti i fornici laterali e nelle ali corrispondenti del primo attico, i relitti accatastati di una vera e propria battaglia navale nel risalto centrale del secondo.
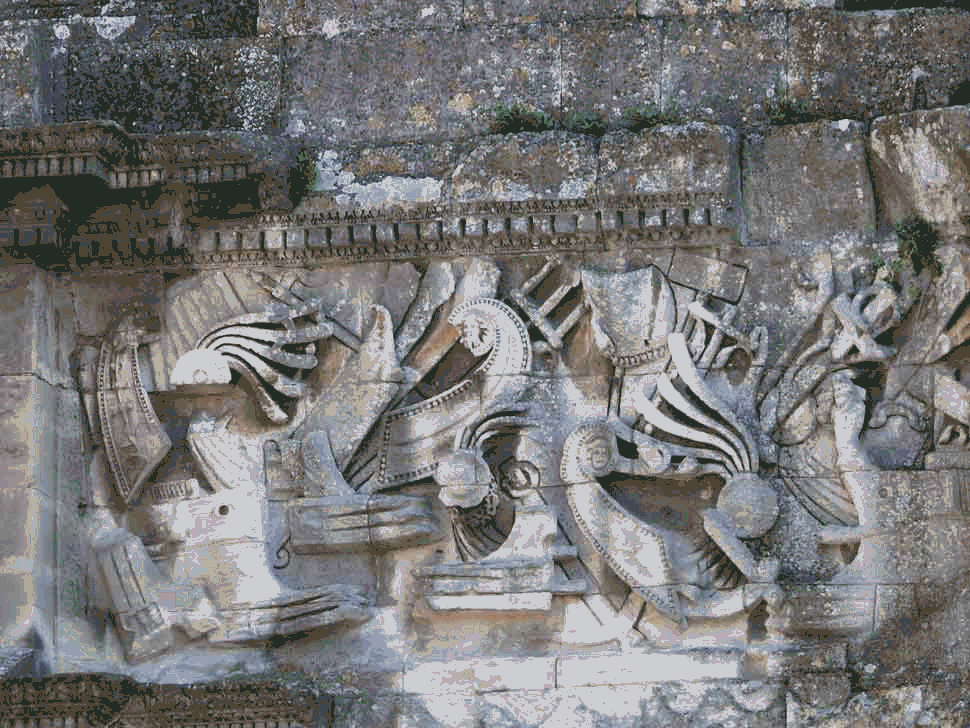

Anche i fianchi aquisirono dignità di facciata con la composizione tetrastila incassata nel piano e negli angoli, con la trabeazione interrotta e sormontata da un arco 'siriaco' che invade il timpano soprastante (questa particolare forma trae il nome dal primo esempio che è attestato nella città di Seia in Siria, in un edificio ellenistico innalzato sul finire del I secolo a.C.: nel tempio, dedicato alla divinità locale Dusharaa, la trabeazione conclusiva della recinzione si incurvava a perfetto semicerchio in corrispondenza delle due colonne libere centrali che, insieme a una coppia di semicolonne incorporate, suddividevano l'apertura).
In pittura l’arco interrotto era apparso a Pompei sulle pareti dell’oecus corinzio della Casa del Labirinto e riapparirà nelle tombe rupestri di Petra del II sec. d.C. Il fianco dell'Arco di Oranges e in particolare il modello dell'arco spezzato sarà diffuso tra gli architetti della Rinascita grazie a un noto disegno di Giuliano da Sangallo.

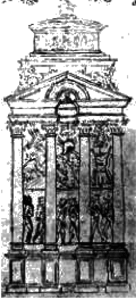


Giuliano da Sangallo, disegno del lato ovest dell'arco di Orange; Mantova, chiesa di San Sebastiano (1460 da un progetto di L.B. Alberti; Roma, Santa Maria della Pace (1442, Baccio Pontelli?)
Gruppi statuari coronavano probabilmente l’ultimo attico, e vari indizi fanno propendere per l’ipotesi che quest’arco narbonense rientrasse nella serie di realizzazioni commemorative per la morte di Germanico (19 d.C.) volute dal Senato secondo le prescrizioni della Tabula Siarensis.
Grazie all’equilibrio cercato dai costruttori (in chiaro contrasto con la sovrabbondanza della sculture) tra corpi pieni, leggeri risalti e membrature puntiformi slanciate, il sistema ornamentale colonnato e i piedritti d’inquadramento dei varchi convivono nel registro inferiore compenetrandosi pacificamente, senz’alcuna preminenza dell’uno sull’altro.
Simile all’arco di Saint-Remy è quello di Carpentras, nella stessa provincia, costruito negli anni 20 del I sec. d.C. durante il regno di Tiberio.
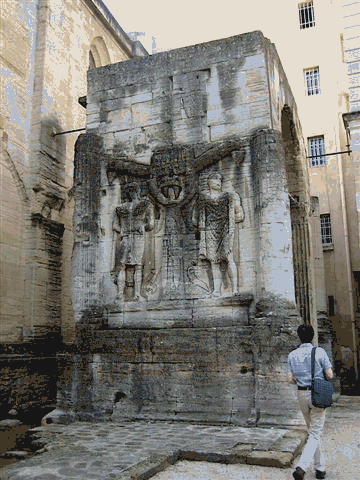
Anche nel caso di questo monumento le campate laterali dei piloni, chiuse tra semicolonne su piedestalli in rilievo su alto podio, furono occupate da figure a bassorilievo e a grandezza reale di prigionieri germani e orientali, rappresentati frontalmente nei loro corpi potenti costretti da legami.
L’impiego di motivi vegetali – girali sulle lesene e antemi sull’archivolto – raggiunge il proprio culmine nel tetrapilo di Cavaillon, risultato dell’unione, realizzata nel XIX secolo, di due archi di età tardo-augustea o tiberiana, originariamente disposti ai lati di un tempio.

Il montaggio non ha minimamente intaccato l’invadente decorazione che si unisce alla esecuzione piuttosto raffinata, con la presenza di motivi tardo-ellenistici riecheggiati in territorio romano. In tale apparato scultoreo si esplicita al contempo quel che è implicito nella presenza stessa del gran numero di archi del primo quarto del I sec. a.C. in queste regioni galliche meridionali: i vinti rappresentati indicano l’arcaico stato barbarico delle popolazioni locali, che si muta in civiltà grazie all’avvento dei Romani.
Non mancarono nelle province galliche, come nelle italiche, le iniziative di privati cittadini. In Aquitania un notabile di Saintes, fra 18 e 19 d.C. fece costruire, appena fuori della città, vicino al ponte sulla Charente, un arco a due fornici gemelli dedicato a Germanico e Druso Minore, eredi designati di Augusto.

I tre piloni di uguale altezza e quasi di uguale ampiezza sono ornati agli spigoli da lesene corinzie scanalate alquanto tozze su alti podi, unite a coppie da tratti di trabeazione; gli spessi archivolti invadono lo spazio di una fascia superiore, sviluppata oltre le cornici d’imposta che segnano il termine dei piloni, e inquadrata da lesene angolari con capitelli di genere composito (forse i più antichi apparsi nell’architettura romana) quali appoggi estremi della trabeazione con fregio liscio; il fregio, recante l’iscrizione dedicatoria, è sormontato da un basso attico spoglio e disadorno, concluso da una cornice a piccoli modioni. Quest’arco – eccezionale sia per tipo che per ubicazione – pur lontano dalla raffinatezza dei suoi compagni narbonensi, esercita nondimeno il fascino di una severa imponenza priva di eccessi, quasi un omaggio provinciale ai nuovi tempi augustei.
A Roma, dai Flavi ai Severi
|
Roma |
Alla fine del I sec. d.C. in Roma – a quanto testimoniano le fonti – già si contava un gran numero di archi trionfali distribuiti in ogni punto della città, dedicati agli imperatori a memoria delle loro vittorie, e più di uno dovette presentare alcune novità rispetto ai precedenti augustei e tiberiani.
Alla fine dell’età giulio-claudia l’arco a unico fornice di Nerone, eretto sul Campidoglio dopo il 58 d.C. per celebrare una temporanea vittoria sui Parti (Tacito, Annali, XV, 18,1), e che fu poi demolito a causa della damnatio memoriae del suo titolare, mostrava, secondo una ricostruzione basata sui rovesci di monete, una sola colonna libera per banda, su proprio piedestallo emergente dall’alto podio comune – le prime colonne libere ad apparire in un arco – elevata ciascuna alquanto prima dell’angolo del pilone, lasciando nell’insieme ampie superfici per una ricca decorazione scultorea, con figure di Vittorie alate e altre divinità.

Vittorie in gran quantità annunciavano la statua dell’imperatore montata sulla quadriga trionfale in bronzo dorato a coronamento dell’attico, con l’iscrizione dedicatoria, articolato in rientranze e risalti, come la sottostante trabeazione, comandate dalla presenza delle colonne libere in aggetto. La posa alla stessa quota, quella raggiunta dal podio, di piedritti e colonne, creano lo stesso effetto d’innalzamento monumentale già caratteristico dell'arco dei Gavii e dei Servii.
La ricchezza delle realizzazioni nella successiva età dei Flavi è annunciata dai tre archi rappresentati – ma non identificati – nel monumento funerario degli Haterii, famiglia d’imprenditori di opere pubbliche attiva sul finire del I secolo d.C. e specialmente durante il regno di Domiziano.
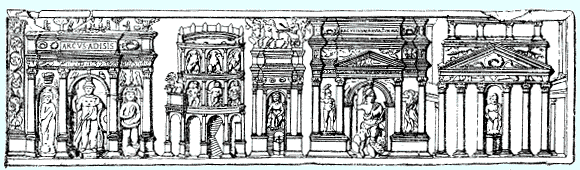
Ma l’opera più rappresentativa di questo periodo della storia imperiale è l’Arco di Tito, posto all’inizio del tratto della Via Sacra parallelo al Palatino, ed eretto da Domiziano nell’81 d.C., anno della divinizzazione del predecessore (oggi apprezzabile nella sua quasi interezza grazie ai restauri ottocenteschi di Giuseppe Valadier).
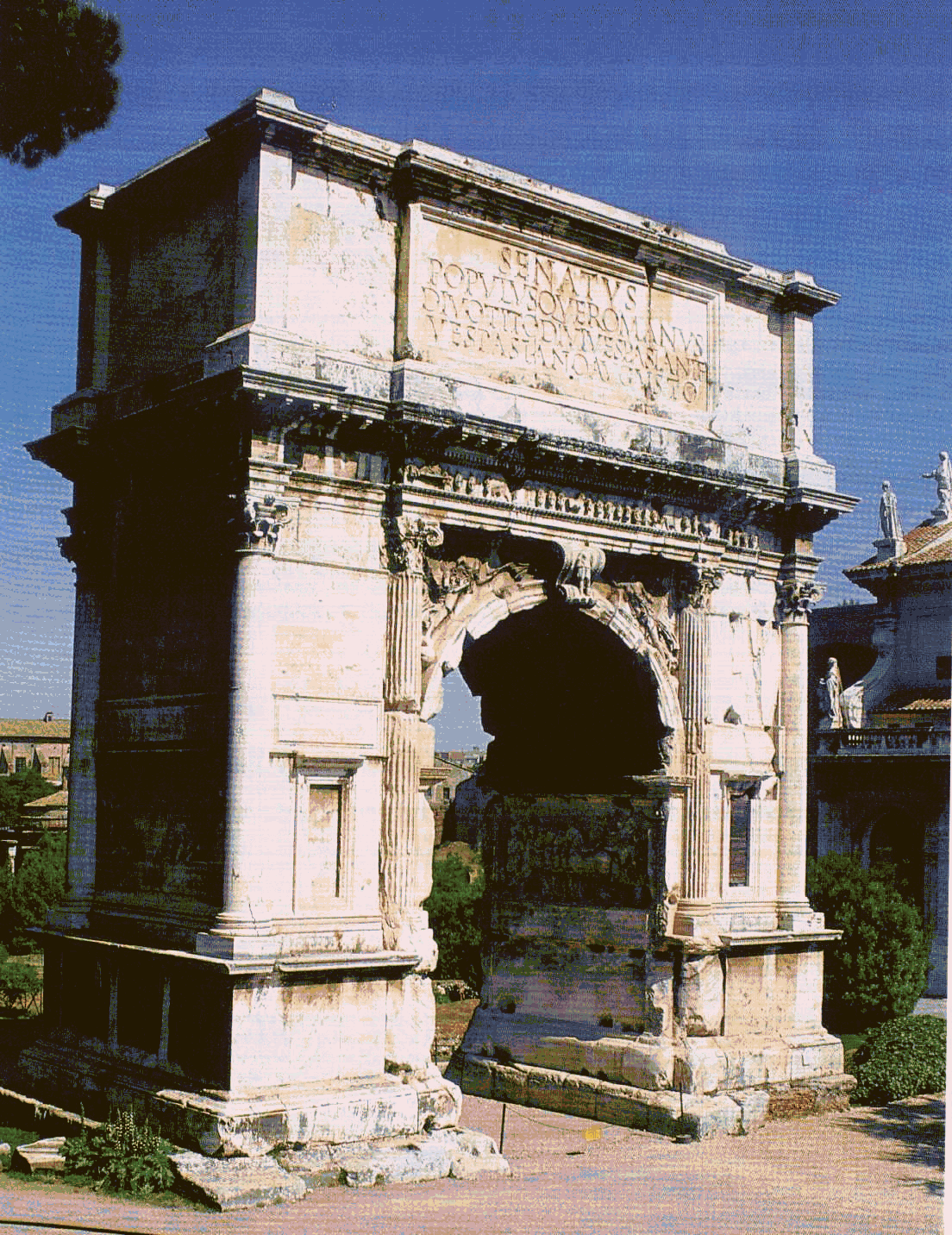
L’edificio encomiastico e celebrativo ripropone il modello, semplice e antico, dell’unico fornice inquadrato da coppie di semicolonne e colonne di tre quarti presso gli angoli interni e negli esterni e, perciò, conseguentemente dotato di specchi liberi per eventuali pannelli scultorei nei piloni, in tal caso tuttavia decorati solo da piccole nicchie trabeate. Il piano del fornice, ove si disegna l’archivolto con i relativi supporti, appare lievemente arretrato rispetto al gruppo tetrastilo entro cui è inserito, e figura raccordato alla trabeazione superiore mediante una robusta chiave a doppia voluta con funzione di mensola (seconda novità ad apparire nella configurazione degli archi), animata dalla presenza della personificazione di due virtù, che fanno corteggio all’imperatore trionfante: Honos e Virtus. L’alto, severo, attico, rivestito di marmo lunense, bilancia la sottostante composizione, articolato anch’esso in tre parti, con estesa targa dedicatoria in evidente risalto al centro. Il genere composito usato nell’arco di Tito – con l’aiuto portato, a dispetto dell’apparente semplicità, dalla ricca plastica dei capitelli; dei piedistalli delle semicolonne che articolano il podio in travertino dei piloni; della trabeazione con fregio raffigurante la processione sacrificale; della cornice di coronamento retta da modiglioni e, nondimeno, dal rivestimento del nucleo cementizio con lastre di marmo pentelico proprio dei monumenti ateniesi – assurse a una sorta di canonizzazione, preferibilmente associato, da allora in poi, ai successi e ai trionfi imperiali.
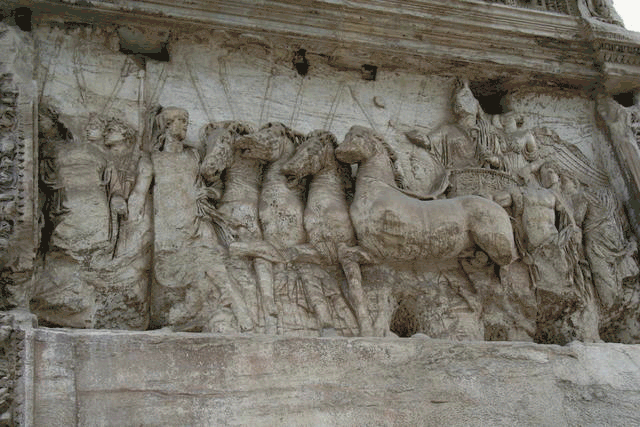
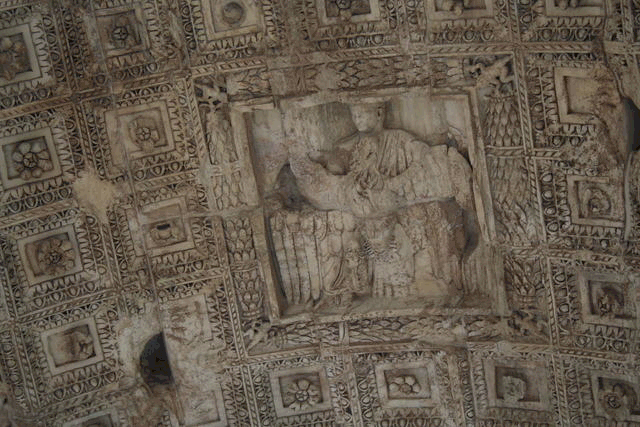

Le pareti all’interno del fornice recano bassorilievi raffiguranti il trionfo dell’imperatore dopo la vittoria riportata nel 71 d.C. sui Giudei: Tito giganteggia sulla propria quadriga al centro del corteo con le preziose spoglie tolte al Tempio di Gerusalemme; sui pennacchi sono scolpite due Vittorie, e sull’attico posava il gruppo in bronzo dorato raffigurante, ancora, Tito sulla quadriga. Al centro della volta cassettonata del fornice, l’imperatore è nuovamente rappresentato sul dorso di un’aquila che lo conduce al cielo, inaugurando la figura che diverrà topica nell’iconografia dell’apoteosi imperiale.
Un arco a tre fornici intercomunicanti mediante passaggi trasversali, e ricco sui fronti di una ornamentazione di quattro colonne libere in aggetto sulle due facce dei piloni, sorgeva accanto alla curva del Circo Massimo; un altro arco a tre fornici segnava l’ingresso al tempio di Iside in Campo Marzio, ove oggi si trova la basilica della Minerva. Tra il recinto della dea egiziana e gli antichi Saepta costruiti da Cesare, Adriano pose una ulteriore struttura celebrativa somigliante, priva com’era di qualsiasi decorazione scultorea, più che a un arco trionfale a un propileo d’ingresso, alla maniera delle città ellenistiche dell’Asia Minore. Arco o porta urbana interna, l’edificio fu comunque distrutto fra il XVI e il XVII secolo: ma i disegni di Antonio da Sangallo il Giovane lo documenterebbero composto da un gigantesco fornice centrale affiancato da due fornici minori, sormontati da corrispondenti nicchioni tra coppie di colonne che, facenti parte quelle inferiori di un lungo portico trabeato, creavano un’indissolubile continuità tra un alto corpo centrale e le sue basse ali.
Un arco quadrifronte, forse coincidente con quello ricordato in un epigramma di Marziale (VIII, 65) datato al 93 d.C., è documentato da alcune monete di Domiziano.

Le arcate risultano inquadrate da coppie di colonne libere in aggetto, mentre l’attico appare sormontato da due quadrighe trainate da elefanti: non si potrebbe fare a meno, in tal caso, di identificarlo con la versione tardo-flavia della Porta Triumphalis posta lungo il percorso ufficiale dei cortei, il che spiegherebbe la sopravvivenza alle demolizioni conseguenti alla damnatio memoriae dell’imperatore.
Durante il principato di Marco Aurelio fu costruito un altro arco quadrifronte, per celebrare le vittorie riportate dall’imperatore sui Germani negli anni 169-175 d.C.

Completamente persa la sua struttura, di esso si sono salvati numerosi pannelli riutilizzati nell’arco di Costantino o esposti ai Musei Capitolini, che raffigurano tòpoi della clemenza, della vittoria e della devozione agli dei degli imperatori, nelle scene della sottomissione, del trionfo e del sacrificio dinnanzi al tempio di Giove Capitolino.
I due archi di età severiana, costruiti durante il principato del princeps originario di Leptis, si presentano ancor oggi in ottimo stato di conservazione. Il più importante è l'Arco di Settimio Severo a tre fornici con passaggi interni trasversali, costruito nel 202-203 d.C. presso la Curia e i Rostra al termine della via Sacra: esso completava il lato del Foro Romano ai piedi del Campidoglio, contrapponendosi spazialmente e riferendosi idealmente agli archi di Augusto ai lati del tempio del Divo Cesare. E alla corrispondenza richiamata dalla posizione topografica si aggiungeva quella storico-celebrativa poiché, dedicato anche ai figli Caracalla e Geta per celebrare le vittorie ottenute sui Parti nel 195 e 198 d.C., l’arco rammentava implicitamente la restituzione da parte di costoro delle insegne romane nelle mani di Augusto, avvenuta circa due secoli prima.

Tutta l’area pianeggiante di Roma a partire dal Foro era ormai punteggiata da strutture esaltanti la gloria dell’Impero, e l’imponente arco di Settimio Severo, dal nucleo in laterizio e travertino e dal rivestimento marmoreo, pare concludere una tradizione rinverdendo contemporaneamente eco remote: su ognuno dei due fronti, i tre fornici sono incorniciati da quattro colonne libere, antistanti i piloni, con capitelli di genere composito poggiate su alti piedistalli; la trabeazione segue gli aggetti con rispettivi risalti; gli archivolti poggiano su imposte particolarmente evidenti e si chiudono con chiavi a volute; l’attico, amplissimo (parzialmente cavo) è continuo e chiuso da due risalti laterali che, corrispondendo alle colonne esterne sottostanti, incorniciano l’iscrizione dedicatoria. Il fornice centrale era riservato al passaggio dei carri; quelli laterali, come dimostra l’esistenza di gradini, erano esclusivamente pedonali. Quasi ignorando le composizioni del secolo precedente, l’arco sembra ispirarsi alle realizzazioni di età neroniana e flavia, con una decorazione scultorea che occupa ogni possibile spazio: le facce dei piedestalli con figure di soldati Romani e prigionieri Parti; divinità fluviali e Vittorie con trofei negli spicchi sopra gli archi; divinità maschili e femminili nelle chiavi degli archivolti; scene di trionfo nei brevi tratti di trabeazione sopra i fornici minori; infine, l’animata raffigurazione sincronica della guerra contro i Parti in tre fasce sovrapposte, con tutte le fasi e le operazioni della campagna sull’esempio delle colonne istoriate di Traiano e di Marco Aurelio. Una moneta del 204 d.C. ci assicura che era stata quanto meno prevista la collocazione di una quadriga imperiale a coronamento dell’attico.

Il secondo arco di età severiana (ma forse sarebbe più corretto considerarlo una specie di tetrapilo o una porta monumentale) è un’opera di importanza minore rispetto al contemporaneo arco imperiale: detto Arco degli Argentari perché offerto alla famiglia imperiale nel 204 d. C. dai banchieri (argentarii) uniti ai mercanti di buoi (negotiantes boarii), fu eretto proprio all’entrata del Forum Boarium entro la zona allora popolarissima e densa di botteghe del Velabrum, ai confini di tre regiones augustee.


Due pilastri quadrangoli in opera a sacco rivestita di marmo greco, poggiati su basi di travertino (di cui uno successivamente inglobato nella chiesa di San Giorgio), reggono un architrave marmoreo quasi interamente assimilato (o se si vuole ridotto) all’iscrizione dedicatoria, seguendo un modello destinato a gran fortuna, specialmente nelle province, introdotto qualche anno prima nel propileo di accesso alla Porticus Octaviae. Una esuberante decorazione vegetale occupa le superfici dei pilastri e dell’architrave lasciate libere dalle sculture figurate e dalla iscrizione dedicatoria: le lesene appena in rilievo, scolpite con girali in luogo delle più consuete scanalature, sono coronate da capitelli di tipo composito, e inquadrano fregi con scene di sacrificio e pannelli con personaggi della famiglia imperiale, legionari, barbari prigionieri, come nei massimi archi onorari. L’intero apparato ornamentale, teso a ottenere effetti pittorici piuttosto che a perseguire evidenza plastica, denotato da ambizione, spirito imitativo e ingenuità, dichiara l’intervento di una bottega estranea ai massimi incarichi, che si impegnò, forse per la prima volta, ad affrontare una impresa di tal genere (ottenendo risultati certo non eccellenti, e tuttavia dotati di fascino nel loro registro popolare).
Nella penisola italica dai Flavi ai Severi
|
Italia e province alpine |
Dopo gli anni della dinastia giulio-claudia e la rapida diffusione dei monumenti celebrativi per suggellare l’avvenuta romanizzazione di molti popoli e regioni, l’arco trionfale e onorario diviene più raro ma contemporaneamente più ambizioso, nella ricerca di dimensioni imponenti o nella ricchezza dei programmi scultorei.
Gli archi di Ancona e di Benevento, entrambi in ottimo stato di conservazione, costituiscono le migliori testimonianze della nuova situazione. Coevi, entrambi furono voluti dal Senato, non per celebrare vittorie militari bensì il compimento di infrastrutture necessarie a tutto l’Impero sia in pace che in guerra. Il loro modello fu l’arco di Tito: ampio attico aggettante nella parte centrale corrispondente all’unico fornice con iscrizione dedicatoria; risalti della trabeazione per ogni colonna libera e semicolonna imprigionata, tutte su propri piedestalli indipendenti. Le proporzioni dei nuovi archi, però, sono varie: singolarmente slanciato quello di Ancona, singolarmente tozzo l’arco di Benevento.
L’Arco di Ancona, per il quale si fa il nome dell’architetto Apollodoro di Damasco, è un’opera di pace, una ‘porta marittima’ costruita in grandi blocchi di marmo nel 114-115 d.C., collocata, con effetti di massima suggestione, su un alto podio accessibile mediante scalinata (rifatta in età moderna) dal piano del nuovo molo del porto restaurato da Traiano (e a lui dedicato), in modo da essere visibile dal mare e rassicurare i naviganti del loro imminente approdo in terra italica.

Esso si distingue per i suoi piloni privi di decorazioni intermedie, a esclusione di quattro prore di bronzo incastonate (oggi scomparse), che valorizzavano per contrasto il risalto delle semicolonne di genere corinzio poste su piedistalli incorporati nel podio dei piloni.
Votato nel 114 d.C. dal Senato in occasione dell’apertura della nuova Via Appia Traiana, che rendeva più rapido il viaggio da Roma a Brindisi e di lì alla Grecia e alle metropoli dell’Asia Minore e del Vicino Oriente, l’Arco di Benevento fu terminato al tempo di Adriano, come dimostra il trattamento dei rilievi che ornano l’attico ai lati della grande iscrizione dedicatoria.

I bassorilievi sui larghi piloni sono suddivisi in quattro fasce o registri di altezze alternate, conseguendo l’effetto di attenuare alquanto l’aggetto delle semicolonne scanalate arricchite da capitelli di genere composito. Le sculture non riproducono avvenimenti storici, ma rappresentano simboli delle virtù imperiali, come la pietas espressa dalle Vittorie impegnate a sacrificare un toro ai lati di un candelabro. Nei rilievi interni al fornice è celebrata la institutio alimentaria (prestiti dello Stato ai piccoli agricoltori, i cui interessi venivano ridestinati alla educazione tanto dei figli che dei genitori): dinnanzi a Traiano si assiepano figure di contadini, unite a raffigurazioni allegoriche.
In Puglia, a Canosa, lungo un tratto dell’Appia Traiana in mezzo ad alcune sepolture, si eleva un arco a unico fornice con nucleo interno in calcestruzzo e mattoni e rivestimento marmoreo (non più esistente): chiuso e ritmato da lesene poste agli angoli e al centro dei piloni, la sua destinazione è incerta – onoraria o commemorativa – a causa della perdita di tutta la parte superiore, iscrizione compresa.

Nelle province occidentali e settentrionali, dai Flavi ai Severi
Anche nelle province occidentali l’arco trionfale, celebrativo od onorario, fu segno importante se non essenziale a suggello dell’immagine di una città e, contemporaneamente, e del suo grado d’integrazione all’Impero.
In Spagna presso il foro di Caparra si eleva il tetrapilo che, sul finire del I sec. d.C., un certo M. Fidius Macer fece costruire a proprie spese: i suoi piloni, conservati fino all’altezza degli archivolti o poco più, sono delimitati da lesene angolari poggiate su alto piedistallo, come posano su piedistalli i piedritti di genere corinzio dei quattro archi.

La costruzione, di pianta pressoché quadrata con vano centrale voltato a crociera, presentava inoltre piedistalli avanzati ai lati della facciata principale, probabilmente allo scopo di reggere statue equestri del tutto libere anziché incorniciate da edicole, secondo una soluzione piuttosto rara ma adottata in età giulio-claudia nell’arco quadrifronte lungo il decumano massimo di Ercolano, e riscontrabile successivamente, nel III secolo d.C., nell’arco di Bosra.
In Britannia, dell’arco di Richborough, eretto fra 80 e 90 d.C. nelle adiacenze del porto, si può ipotizzare, in virtù della sua posizione, un significato emblematico analogo a quello di Ancona.

Invece dell’arco a tre fornici di Saint-Albans possiamo solo affermare ch’esso risale agli anni 250-275 d.C. in coincidenza con la ricostruzione delle mura.
Poiché nella Gallia Narbonense il processo di romanizzazione si era compiuto in età giulio-claudia, l’interesse delle popolazioni e dei reggitori locali agli inizi dell’età flavia fu attratto principalmente dagli edifici per spettacoli e per balnea termali, con l’eccezione di alcuni centri della provincia in cui furono eretti alcuni archi di modeste dimensioni, fra i quali il tetrapilo di Vienne posto a reggere un obelisco nella spina del circo. Non accadde altrettanto nelle Gallie più settentrionali, le cui città proseguirono nella costruzione di archi. La cosiddetta 'Porte de Mars' a Reims fu eretta nel terzo quarto del II sec. d.C. e poi inserita nelle mura – come a Rimini due secoli prima – per segnare un caposaldo importante del perimetro del centro urbano.

Essa è un arco a tre fornici, in cui le semicolonne di genere corinzio, raddoppiate nei cantonali estremi, inquadrano i piloni incavati da nicchie sormontate da timpani triangolari e clipei soprastanti, componendo una lontana variazione del Theatermotiv caratterizzata da incavi, pur ciechi, compresi entro membrature verticali trabeate.
La cosiddetta 'Porte Noire' di Besançon, anch’essa inserita nell’antica cinta difensiva, risale allo stesso periodo: il suo unico fornice è inquadrato da due registri sovrapposti di semicolonne di tipo composito, con partenza da un basso podio unitario; le corrispondenti trabeazioni seguono con altrettanti risalti l’aggetto delle membrature verticali, risalti che, per l’intera ampiezza del fornice, si raccordano in un unico tratto di trabeazione sostenuto in mezzeria dalla possente chiave dell’archivolto.

Un’ornamentazione ricchissima copre ogni superficie disponibile, compresi i fusti delle colonne, con un horror vacui proprio di quest’architettura gallo-romana, in cui Vittorie e simboli pagani illustrano la virtù della pietas ritenuta prerogativa degli imperatori, la condizione della felicitas che questi pretendevano di garantire, e le continue vittorie da questi riportate come trionfo della civiltà sulla barbarie.
I due archi di Reims e Besançon, entrambi risalenti al periodo compreso tra 150 e 175 d.C., costituiscono svolgimenti di due modelli diversi: il primo è un propileo urbano concepito come fondale della scena cittadina, simile agli archi romani in Campo Marzio, il secondo è un arco istoriato, uno degli ultimi anelli di una catena che da Saint-Remy a Benevento si avvale della composizione architettonica come supporto e inquadramento di un eloquente e insistente ciclo scultoreo.
In Asia Minore e Grecia, dai Giulio-Claudii ai Severi
|
Grecia |
Asia Minore e Cipro |
Gli architetti ellenici del VI-IV secolo a.C. avevano prevalentemente evitato l’uso dell’arco – non tanto come utile espediente strutturale da tener celato ma come nobile forma architettonica da esibire – probabilmente perché ritenevano che esso, pur assicurando continuità di cammino alla forza del peso, non esprimesse, come la chiarezza logica richiedeva, l’antitesi naturale tra membrature sostenute e membrature di sostegno; né sembra che gli Elleni avessero mai concepito magniloquenti strutture ‘di passaggio’ se non per predisporre l’animo alla diversa natura dei luoghi che si abbandonavano e di quelli a cui si accedeva (si pensi solo al significato iniziatico, se non catartico delle cinque porte nei Propilei ateniesi) e tanto meno che ne avessero approfittato per rammentare avvenimenti o personaggi storici contemporanei, senza ricorso all’intermediazione del mito. Si conosce una sola eccezione a tale comportamento (Pausania, I, 15, 1): quello di una porta presso la Stoà Poikìle nell’agorà di Atene, sormontata da trofei di armi a ricordo della vittoria riportata su Plistarco tra IV e III secolo a.C.
Poco prima del passaggio della loro città ai Romani, gli abitanti di Priene costruirono nel 150 a.C. una porta maestosa quale ingresso a una delle due agorài: ma essa non era isolata e non si distaccava in sostanza dalla tradizione ellenistica dei propilei monumentali, come non isolata e assimilabile a un propileo fu la la porta a tre fornici priva di qualsiasi elemento decorativo costruita nella seconda metà del I secolo a.C., dopo la conquista romana, all’ingresso del santuario panellenico di Poseidone a Istmia, sull’Istmo di Corinto.
Funzione di propileo e presenza costante di tratti importanti di trabeazione furono le caratteristiche degli archi costruiti nelle antiche pòleis greche o città ellenistiche: mai, però, introdotti come invadente ed estraneo segno di conquista, ma sempre con rispetto per le tradizioni culturali dei luoghi.
All’agorà inferiore di Efeso risistemata da Augusto si poteva accedere da tre porte: quella meridionale segnava il passaggio proveniente dalla piazza antistante la Biblioteca di Celso e fu eretta nel 4-3 a.C. da Mazzeo e Mitridate, due liberti greci affrancati dallo stesso Ottaviano. In essa i tre fornici di uguale ampiezza che componevano la porta-propileo si disponevano, animandola, su piani verticali diversi: quello al centro, arretrato, quelli ai lati, avanzati, in modo da creare uno spazio d’invito a cielo aperto centrale, e due vere e proprie gallerie laterali voltate a botte con nicchie profonde negli spessi muri dei fianchi, e porte trabeate nei setti intermedi di comunicazione con il vano centrale. L’articolazione dei volumi coniugava il propileo ellenistico alle volte dei passaggi interni e alla decorazione dei fronti propria dell’arco trionfale romano: gli archivolti impostati su propri pilastri erano inquadrati da piatte lesene di genere dorico, ma con echino sostituito da kymàtia vegetali, reggenti trabeazioni miste con fregio e cornice di genere ionico e corinzio, sormontate da attici delimitati da cordoni ritorti, nei cui specchi si leggevano le iscrizioni dedicatorie ad Augusto, Livia, Agrippa e Giulia nella più pura tradizione protoimperiale romana.
Qualche decennio più tardi, ad Antiochia in Pisidia, nel propileo di accesso all’ampia spianata dedicata ad Augusto sull’acropoli, riappare l’assetto tripartito riprodotto quasi fedelmente anche negli ornamenti, sul modello della realizzazione efesina. In tal caso, però, il fronte di accesso si svolgeva su di un unico piano architettonico e l’esteso attico che ne conseguiva esponeva il testo latino delle Res Gestae di Augusto (il cosiddetto Monumentum Antiochenum), incise anche sul Mausoleo del Princeps a Roma.

Un aereo diaframma fu il propileo a tre passaggi innalzato ad Afrodisia tra il 20 e il 60 d.C. per introdurre alla via porticata che conduceva al Sebastéion della città, vale a dire al santuario di tutti gli imperatori divinizzati.

In due registri sovrapposti ventiquattro colonne libere di genere ionico e corinzio, posate su piedestalli nascenti quasi come scogli dalla scalinata che raggiungeva la quota della via, si univano in coppie o in edicole tetrastile, ricche di trabeazioni con fregi punteggiati da protomi leonine e con cornici rette da mensole sinuose che reggevano anche, in corrispondenza dei gruppetti tetrastili centrali, le estremità laterali di un timpano triangolare interrotto.
All’incrocio delle due vie porticate di Perge, tra 81 e 83 d.C. due facoltosi cittadini, Demetrio e Apollonio, ricordati nell’iscrizione commemorativa, fecero innalzare un arco a unico fornice di contenute dimensioni ma di ricercata fattura: dedicato ad Artemide, ad Apollo e alla dinastia Flavia, esso costituisce un esempio eloquente della libertà compositiva con la quale furono articolati i vari elementi architettonici di un tipo edilizio non certo votato a concreta utilità. Al di sopra di due coppie di tozze e appiattite lesene di genere dorico, molto ravvicinate, posate su brevi tratti di comune crepidoma, corrono due tratti di corrispondente trabeazione la cui cornice appartiene contemporaneamente a quella di due elementi angolari di un timpano interrotto (il primo esempio conosciuto in Asia Minore): dietro i segmenti delle cornici inclinate sembrano nascere (come se questi ne nascondessero le imposte), l’archivolto e i suoi estradossi, chiusi tra esili semicolonne angolari, appoggi estremi della trabeazione conclusiva a dentelli di genere ionico-attico.
Il frontone spezzato è un elemento decorativo presente in queste regioni dalla fine del periodo ellenistico, come testimonia Vitruvio usando per tale forma il termine di semifastigium (De Arch., VII, 5, 5), parlando delle pitture che decoravano in Lidia la scena del teatro di Tralles dipinta da Apaturio.
La cosiddetta ‘Porta di Adriano’ a Efeso appartiene in realtà, come testimonia una lacunosa iscrizione dedicatoria, agli ultimi anni del principato di Traiano: posta nei pressi della Biblioteca di Celso e dell’agorà inferiore, lungo la via processionale che conduceva a un presunto luogo di nascita di Apollo e di Artemide, assolve alla funzione di propileo, consistendo di una quinta trasparente di tre registri di colonne e pilastri sovrapposti.
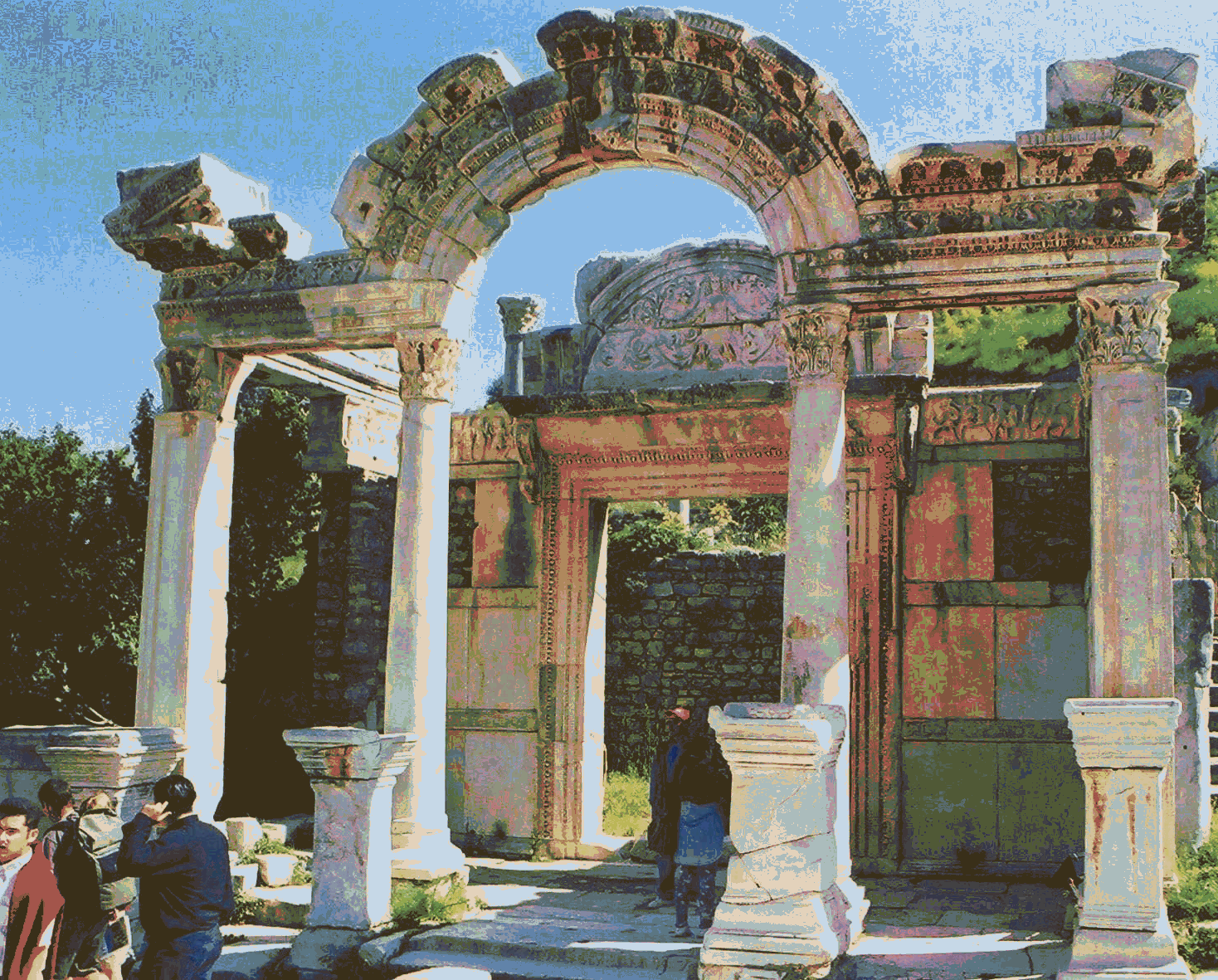
Il registro inferiore è costituito da due coppie di snelle colonne distanziate con basi approssimativamente attiche e capitelli di genere composito, a sostegno di elaborati tratti di trabeazione di genere attico; l’intermedio introduce la sezione quadrangola nei pilastri estremi e nelle lesene – fuori asse rispetto alla membratura sottostante – che delimitano il setto murario entro cui si apre il maestoso archivolto, scaturito dagli estremi dei tratti sottostanti di trabeazione, e culminante in tangenza a una fascia di congiunzione in un continuum decorativo con i capitelli delle lesene, prima che una seconda trabeazione di genere attico concluda la composizione. Il registro superiore è formato da una loggia di sei esili colonne di genere corinzio, lievemente diminuite in altezza e poste a definire cinque campate disuguali con un ulteriore fuori asse. Queste, dilatate le due estreme e contratte le tre interne dominate dalla centrale lievemente più distesa, danno appoggio alla terza trabeazione di genere corinzio che avanza lievemente in accordo con le isolate colonne estreme e con le coppie intermedie, per interrompersi in corrispondenza della campata centrale, dando appoggio a un arco insinuato nel timpano triangolare che abbraccia e corona l’intero quartetto centrale e sembra precedere il fronte del vicino cosiddetto ‘Tempio o Tempietto di Adriano’. Somiglianza apparente tuttavia, poiché entrambi gli archi della porta-propileo non sono propriamente siriaci – ove è la stessa trabeazione ad incurvarsi uguale a se stessa – ma ribadiscono con una propria modanatura semplificata la loro diversità dalla trabeazione su cui si impostano.
Nel contesto del rinnovamento dell’amata Atene che Adriano promosse nel II secolo d.C., un arco segnò – come rammentano le iscrizioni che esso reca incise – il confine tra l’antico nucleo e l’estensione romana, fra la ‘città di Teseo’ e la ‘città di Adriano’.

L’arco con funzione di porta di separazione e di passaggio tra luoghi distinti, tanto ben conservato da suscitare l’ammirazione dei più tardi visitatori, si compone di due registri sovrapposti: l’inferiore presenta un unico fornice particolarmente dilatato, insinuato con l’archivolto nella trabeazione, impostato su pilastri di genere corinzio appartenenti a piloni chiusi alle estremità da alte lesene, e arricchiti nel mezzo da colonne libere su propri distaccati piedestalli, con corrispondenti risalti di trabeazione; il superiore consiste di un diaframma di esili supporti di pianta quadrangola, isolati agli estremi ma abbinati a una edicola piena, coronata da un timpano nella zona centrale.



Le due repliche dell’arco adrianeo elevate in età antoniniana agli ingressi sud-orientale e sud-occidentale dei propilei nel santuario di Eleusi dimostrano il successo riscosso dalla porta ateniese, i cui architetti, in realtà, avevano introdotto ben poco di Roma, essendosi per lo più ispirati alle sovrapposizioni di colonne libere e di edicole in aggetto di alcuni propilei e ninfei ellenistici di importanti agorài (si pensi a Mileto), o alle facciate di alcune residenze dei successori di Alessandro, come ad esempio il cosiddetto ‘Palazzo delle colonne’ a Tolemaide in Egitto. Anche se fosse vera l’improbabile ipotesi che nelle campate si affacciassero statue, in questi archi medio-imperiali di Efeso e di Atene l’architettura avrebbe comunque predominato di per sé con proprie valenze decorative, tanto lontane dai pieni scultorei celebrativi dell’Arco di Benevento.
La Porta di Adriano ad Antalya in Panfilia, che ci è giunta priva del registro superiore, fu realizzata in occasione di una visita dell’impertore, inserita tra due torri lungo un tratto orientale della cinta romana: assimilabile a un vero e proprio propileo, essa presenta, nella ben conservata zona inferiore, tre fornici di uguali dimensioni con volte a botte – decorate a cassettoni e rosette – impostate su massicci piloni dinnanzi ai quali, per contrasto, quattro slanciate colonne libere di genere composito avanzano verso la città con i loro piedestalli indipendenti, e sormontate dai lunghi risalti della trabeazione ricca di girali di acanto, fiori, ovuli e protomi leonine.

Nell’agorà meridionale di Mileto, disegnata nel V sec. a.C. dal celebre Ippodamo, un ricchissimo propileo (ricomposto al Pergamon Museum di Berlino) si apriva sul lato nord: tre fornici varcavano un muro lasciato intravvedere nella sua nudità dietro un castello antistante di due registri di colonne binate.

Ogni coppia del registro inferiore, di genere composito, era riunita da un comune piedestallo, quelle estreme avanzate per inquadrare con maggior forza la composizione; il secondo registro di genere corinzio ripeteva o seguiva la disposizione sottostante, con l’aggiunta di un frontone spezzato sulla verticale dell’ingresso. Sono pochi i frammenti superstiti dell’apparato statuario che un tempo posava sulle trabeazioni ornate da girali e ghirlande, ma sufficienti a datare la porta in coincidenza con una visita alla città dell’imperatore Marco Aurelio (162-165 d.C.): gli architetti che la innalzarono dimostrano di essere stati meno preoccupati di celebrare un particolare evento di quanto lo fossero di segnare il passaggio tra la grande agorà sud e la piazza in cui sfociava il cosiddetto 'Viale delle Processioni', fiancheggiato da alcuni dei maggiori edifici pubblici milesi.
In capo alla strada porticata che attraversava da nord a sud la loro città, intorno alla metà del II secolo d.C., gli abitanti di Rodi eressero un arco lapideo quadrifronte che segnasse l’incontro della via con la scalinata che saliva all’acropoli, e che servisse anche da guida ai naviganti che imboccavano il porto. Fu uno strano ma ben riuscito connubio tra un tetrapilo romano e un tempietto ellenico: i quattro piloni di pianta quadrata sui quali si impostavano gli archi erano ornati sulle facce esterne da coppie di alte paraste di genere corinzio posate su unico podio, e unite da un timpano in sommità a guisa di due edicole allungate; gli archivolti toccavano di tangenza un’alta fascia, sormontata da due timpani sulle facce volte a nord e a sud e di appoggio alle falde spioventi del tetto che scendevano verso le facce volte a est e a ovest. La copertura a capanna proteggeva e celava la cupola costruita in pietra da taglio che, con l’evidente raccordo di pennacchi, concludeva maestosamente il pur misurato vano interno.
Un arco a tre fornici fu innalzato nel 212 d.C. ad Antiochia in Pisidia con dedica a Settimio Severo per ulteriori vittorie riportate sui Parti, mai del tutto sconfitti: dai frammenti delle sculture che lo decoravano – poco d’altro è rimasto – si potrebbe dedurre che esso emulava i contemporanei archi celebrativi delle imprese severiane eretti a Roma stessa e in altri luoghi, con figure di barbari in ginocchio e in ceppi, di Vittorie e di Geni alati.

Nella Penisola Arabica, dai Giulio-Claudii ai Severi
|
Siria, Palestina e Arabia |
Nelle province della penisola arabica che si affacciavano al Mediterraneo, gli archi assunsero configurazioni e dimensioni più imponenti, incoraggiate, forse, dalle loro ubicazioni all’inizio, al termine o nel mezzo – a inquadramento, a sfondo o a raccordo – di lunghe vie ampie e regolari, spesso colonnate.
In queste regioni dell’Asia mediterranea il primo esempio di arco ispirato per forma e concetto agli archi romani può essere considerata la cosiddetta ‘Porta Nabatea’ di Bosra, eretta in età augustea al termine orientale del decumano massimo per segnare il passaggio – analogamente a quanto avvenne ad Atene in età adrianea – fra gli antichi quartieri orientali nabatei e i nuovi quartieri romani.

L’unico ampio fornice si imposta su forti piloni, scanditi lungo le verticali da nicchie sovrapposte, precedendo in tal soluzione, sia pur di poco e in scala minore, l’arco veronese dei Gavi.
Verso occidente, sullo stesso decumano, nel punto ove questo incrociava la via colonnata proveniente dalla cittadella e dal teatro, fu costruito in età antoniniana un secondo arco, imponente, a tre fornici, di cui restano solo poche vestigia.
A Gerasa-Antiochia sul Chrysoròhas, sulla via che conduceva a Gerusalemme, l’arco di Adriano, eretto tra 129 e 130 d.C., avrebbe dovuto costituire, sull’esempio ateniese, l’ingresso maestoso a un nuovo quartiere che non fu mai condotto a termine. Il suo imponente aspetto si affidava non solo alle ragguardevoli dimensioni ma anche, e soprattutto, alla pura composizione architettonica, priva di elementi scultorei su membrature e superfici a eccezione di basi, capitelli e trabeazione.

In un fronte quasi quadrato rivestito di lastre lapidee, affiancato da due ali minori, si aprono tre fornici, vastissimo il centrale, contenuti (meno della metà) i laterali: l’uno e gli altri entro campate definite da membrature ‘giganti’ (comprendenti due o più registri) di colonne di genere corinzio, con fasce decorate sopra le basi e innalzate su propri distinti piedestalli. Il fornice centrale occupa quasi l’intera campata all’infuori di un contenuto estradosso; i fornici laterali sono sormontati da larghe nicchie, sorrette da mensole e comprese tra colonnine libere e timpani triangolari. Oltre la lunga trabeazione dal fregio decorato, ritmata da quattro risalti, si elevava un altissimo attico a due registri, separato in campate da pilastrini ‘astratti’ (privi di basi e capitelli) sul cui sfondo si stagliava il profilo di un timpano triangolare per l’intera ampiezza della campata centrale.
Ancora nella Porta settentrionale di Gerasa-Antiochia, a cinquecento metri di distanza, l’imponente divenne soggiogante, non per le dimensioni del manufatto (che rimasero analoghe al primo) ma per la forza del dialogo tra i suoi elementi architettonici: possente quanto i pilastri su cui si imposta, l’archivolto si equilibria alla perfezione con l’estradosso sovrastante, segnato da una spoglia trabeazione e da una minima targa; ai lati aggettano, vicine, con incontenibile forza, coppie di semicolonne giganti che, sormontate da timpani sollevati, racchiudono oblunghe campate entro cui si addentrano nicchie semicilindriche sovrapposte, voltate a catino.

A Palmira, in corrispondenza dell’angolo creato dal cambiamento di direzione della grande via colonnata, fu eretto in età antoniniana (212-215 d.C.), quale raccordo o cerniera, un arco trasversale a tre fornici di pianta triangolare, con apertura tra i lati di trenta gradi. Nei due fronti, nati dallo stesso vertice ma via via divergenti per disporsi trasversalmente e perpendicolarmente agli assi ruotati della strada, le aperture minori riservate ai pedoni si inserivano nei portici d’ambo le parti, mentre il passaggio centrale dominava con la singolare altezza del proprio fornice il traffico dei carri.

I quattro piloni per fronte, svettanti sui portici e sul tracciato carrabile sottostante (altri due si innalzavano all’interno alla base del triangolo), erano articolati in identico modo da paraste di genere corinzio di granito locale, interamente occupate da una raffinata (quasi esasperata) decorazione di motivi vegetali, contenuta ai bordi da lisce cornici, come se la composizione di parti sull’uno si fosse trasferita con una traslazione obliqua sulla faccia dell’altro, secondo la ben più tarda prassi delle proiezioni ortogonali. Al di sopra degli archivolti ugualmente decorati posavano gli alti estradossi di blocchi squadrati: spoglio quello centrale, parzialmente occupati da nicchie chiuse tra paraste sostenute da mensole e coperte da frontoni quelli laterali.

L'arco di Palmira in Robert Wood's, The Ruins of Palmyra, London 1753
Al centro di una piazza ovale che segnava l’innesto della via colonnata principale con una secondaria che giungeva dalla tomba della regina Zenobia, si trovava un particolare edificio simile a un arco tetrapilo, ma che arco non era:

Agli angoli di un comune podio quadrato, quattro massicci piedestalli reggevano ciascuno quattro colonne di granito egiziano (delle sedici una sola fu rimontata intatta, le altre sono ‘controfigure’, in cemento colorato, delle originali perdute) sormontate in quota da una spessa lastra quadrata dalle facce trattate come segmenti di trabeazione, con architrave a tre fasce, fregio a motivi vegetali, cornice aggettante. In quest’edificio definibile come tetrakiònion – letteralmente "a quattro colonnette" – gli aerei gruppi tetrastili non sostenevano alcunché, ma ciascuno accoglieva al centro una statua. Introvabile in Occidente questo tipo edilizio, pur raro, fu proprio dell’Oriente romano, elevato al centro della piazza ovale di Gerasa, ad Antiochia sul Chrysoròhas, e ad Anjar in Libano.
In Africa, dai Flavi ai Severi
|
Africa |
A partire dal II sec. d.C., per culminare nei primi decenni del III, gli abitanti delle province africane innalzarono numerosi archi onorari (allo stesso modo, contemporaneamente, si diffondevano le riproduzioni di Capitolia). Varie furono le ragioni delle singole imprese: le consistenti espansioni delle città, l’importanza attribuita agli archi quali segni di romanizzazione e di pacificazione dei territori circostanti e, soprattutto, lo stanziamento di numerose guarnigioni militari. Gli archi africani si distinguono, in generale, per la ricerca di magnificenza affidata a volumi e a colonne imponenti, nonché, contemporaneamente, per un controllato proporzionamento delle parti; per la varietà delle soluzioni angolari; per l’effetto di movimento raggiunto mediante membrature aggettanti, risalti, timpani triangolari e curvilinei; per la presenza frequente di preziose edicole; mentre manca quasi sempre di un vero, coerente programma scultoreo. In più, essi svolgono spesso un importante ruolo urbano quali termini o snodi delle vie principali, nonché quali ingressi enfatici agli spazi pubblici delle città.
Il tetrapilo di Traiano a Leptis, costruito nel 109-110 d.C. sul cardo principale della città, aveva una pianta quadrata; a ognuno dei pilastri angolari formati da tozzi e spessi setti murari uniti ad angolo retto si addossano tre colonne a tutto tondo, due a stretto affiancamento degli spigoli esterni, una entro il seno dell’angolo interno. Le prime, con piedestalli e fusti di maggior altezza, inquadravano, quale puro ornamento, gli archivolti in facciata, le seconde con piedestalli e fusti minori, vere strutture portanti, reggevano (senza capitello) gli arconi e la volta a crociera del vano interno.

A Maktar, ora in Tunisia, un arco a un solo fornice dalle forme architettoniche semplici e solenni fu eretto nel 116 d.C. in onore di Traiano, ma anche per celebrare il cambiamento di statuto della città e la contemporanea costruzione di un nuovo quartiere.

Una coppia di semicolonne corinzie su piedestallo inquadrano da vicino l’apertura, reggendo una trabeazione dal fregio iscritto e dilatato, sormontata da un timpano triangolare; presso gli spigoli esterni dei piloni, una seconda coppia di possenti semicolonne di maggior diametro e maggior altezza, su proprio distinto piedestallo anch’esse, affianca la composizione timpanata elevandosi a reggere, con soli dadi o residui di architrave sopra i capitelli, una cornice sporgente, oltre la quale si eleva un attico spoglio di contenuta altezza. Con partenza dalla medesima quota, una colonna minore si affianca e si accompagna ad una maggiore, idealmente legate da una contratta cornice che, prolungando l’imposta dell’archivolto, gira tutt’intorno ai piloni: fu questo un sintagma destinato a una grande fortuna nei secoli successivi, quasi d’obbligo per inquadrare un registro minore entro uno ‘gigante’ o a tutt’altezza.
l termine occidentale del decumano massimo porticato di Timgad fu elevato un arco a tre fornici d’ingannevole età: poiché, se da un lato l’iscrizione dedicatoria ricorda Traiano vivente, considerazioni formali inducono a datarlo al regno di Antonino o all’inizio del III secolo d.C.

L’arco oggi visibile, organicamente legato alla via porticata e quindi ad essa necessariamente successivo, potrebbe essere facilmente una ricostruzione che ripropone (il caso non è nuovo) la dedica originaria di circa un secolo prima. Attraverso il fornice centrale correva la via carrabile lastricata, nei fornici laterali si prolungavano gli impiantiti dei portici appena sopraelevati e pedonali, come nelle città del Mediterraneo orientale. L’archivolto centrale appare forte e imponente con il proprio disegno sullo sfondo del vasto orizzonte; gli archivolti laterali, quasi di metà altezza, condividono, invece, l’alzato dei piloni con nicchie rettangolari, dotate di propria trabeazione e proprie colonnine d’inquadramento poste su mensole sporgenti, destinate ad accogliere statue dinnanzi all’ultimo dei piani evidenziati entro lo spessore della costruzione. Archi e nicchie insieme sono a loro volta compresi – a stento contenuti – entro una coppia di colonne corinzie giganti, avanzate su alti piedestalli: scanalate, con capitelli decorati a forme vegetali e animali, coronate a coppie da un frontone curvilineo posato sul fregio appartenente alla trabeazione, che corre staccata sopra l’archivolto del fornice principale. Le gigantesche edicole sporgenti così formate, catturando e disperdendo nei labirinti dell’eccesso lo sguardo, arrestano energicamente la prospettiva dei portici a cui fanno da sfondo, e introducono anche in terra africana – e in forme più intricate e complesse – composizioni di colonne e trabeazioni ornamentali proiettate innanzi sullo sfondo di corpi strutturali: composizioni già sperimentate in Oriente e in particolar modo a Gerasa-Antiochia sul Chrysoròhas; già apparse nella decorazione interna del tempio di Diana a Nîmes e del tempio di Bacco a Heliopolis pressappoco contemporanei; ma anche nei falsi portici del Foro Transitorio di Roma, in un trionfo dell’enfasi, dell’ambiguità e con esse dell’inquietudine che, tra gli altri sentimenti, può infondere l’architettura. All’attico, unitario e continuo, era affidato il compito di rasserenare e di sostenere il gruppo scultoreo in bronzo dorato, con il trionfo dell’imperatore sul carro incoronato dalla Vittoria e accompagnato da prigionieri e trofei.
I corpi colonnati in aggetto e distaccati riappaiono presto nell’arco di entrata al foro di Djemila, costruito nel 216 d.C. e dedicato a Caracalla (oggi restituito quasi integralmente).

L'unico fornice è inquadrato da coppie di colonne corinzie, le quali, posate ciascuna su proprio piedestallo sporgente da un podio comune e accompagnate da paraste retrostanti, reggono tratti di trabeazione in aggetto, quali basi di due edicole gemelle con timpano triangolare alle estremità dell’attico, ove corrono le iscrizioni dedicatorie di rito, pensate al di sotto di statue stagliate liberamente sullo sfondo del cielo e di cui restano le basi.
Il tetrapilo di Tripoli in Libia, dedicato nel 163 d.C. a Marco Aurelio e a Lucio Vero, segnava nei pressi del foro l’incrocio del decumano con il cardo, e creava un ordine gerarchico fra i due assi: solo il primo, infatti, era carrabile, e perciò i suoi arconi di entrata erano entrambi affiancati da colonne con paraste ribattute, e decorati a motivi vegetali su piedestalli sporgenti dal comune podio di base; il secondo, invece, era pedonale, e pertanto gli archi corrispondenti erano inquadrati da semplici lesene.

La costruzione era costituita da blocchi di marmo greco ("marmore solido", specifica l’iscrizione dedicatoria) e il vano centrale era coperto da una cupola ottagonale, raccordata alla pianta rettangolare mediante il raddoppio dell’architrave dei lati minori e l’inserimento di lastroni triangolari a riempimento degli angoli del quadrato. Le nicchie delle facciate principali erano occupate da sculture a tutto tondo degli imperatori, e quasi tutte le superfici piane erano scolpite a rilievo con prigionieri e trofei.
Il tetrapilo più regolare è forse quello innalzato nel 214 d. C. in onore di Caracalla a Tebessa, città militare sede della III Legione augustea, situato originariamente all’incrocio del cardo e del decumano, ma in seguito ingolobato nelle mura bizantine.

Coppie di colonne libere corinzie, posate su di un podio continuo ritmato dalle sporgenze dei piedestalli incorporati avanzano, quali altrettanti avancorpi, dinnanzi a ciascuna delle otto facce dei quattro piloni quadrati, ove si rispecchiano in altrettante paraste. La piatta membratura che le riunisce, una trabeazione priva di architrave, sovrasta anche i due archivolti e funge d’appoggio alle facce e ai risalti corrispondenti dell’attico con le iscrizioni dedicatorie, il quale, a sua volta, regge quattro edicole timpanate con statue in perfetto allineamento con gli assi di simmetria dei fornici sottostanti.
A Volubilis, al termine della dolce discesa del decumano massimo, l’arco di Caracalla torna a una semplicità quasi primitiva, spalancandosi al paesaggio lontano con l’unico fornice a tutto sesto.

I piloni laterali che lo reggono e lo affiancano, bipartiti orizzontalmente dai prolungamenti delle imposte dell’archivolto, si animano appena di nicchie cuspidate e di esili colonne corinzie, libere, avanzate e poste su alti piedestalli che chiudono lateralmente le vasche di due fontane. I resti centrali di un attico testimoniano la presenza di gruppi scultorei sovrapposti, oggi scomparsi.
La serie degli archi africani può chiudersi con il tetrapilo del tutto particolare di Leptis, costruito nel primo decennio del III secolo d.C., forse in occasione di un’annunciata visita di Settimio Severo e dedicato, comunque, ai suoi trionfi (ricomposto nel XX secolo da archeologi italiani).
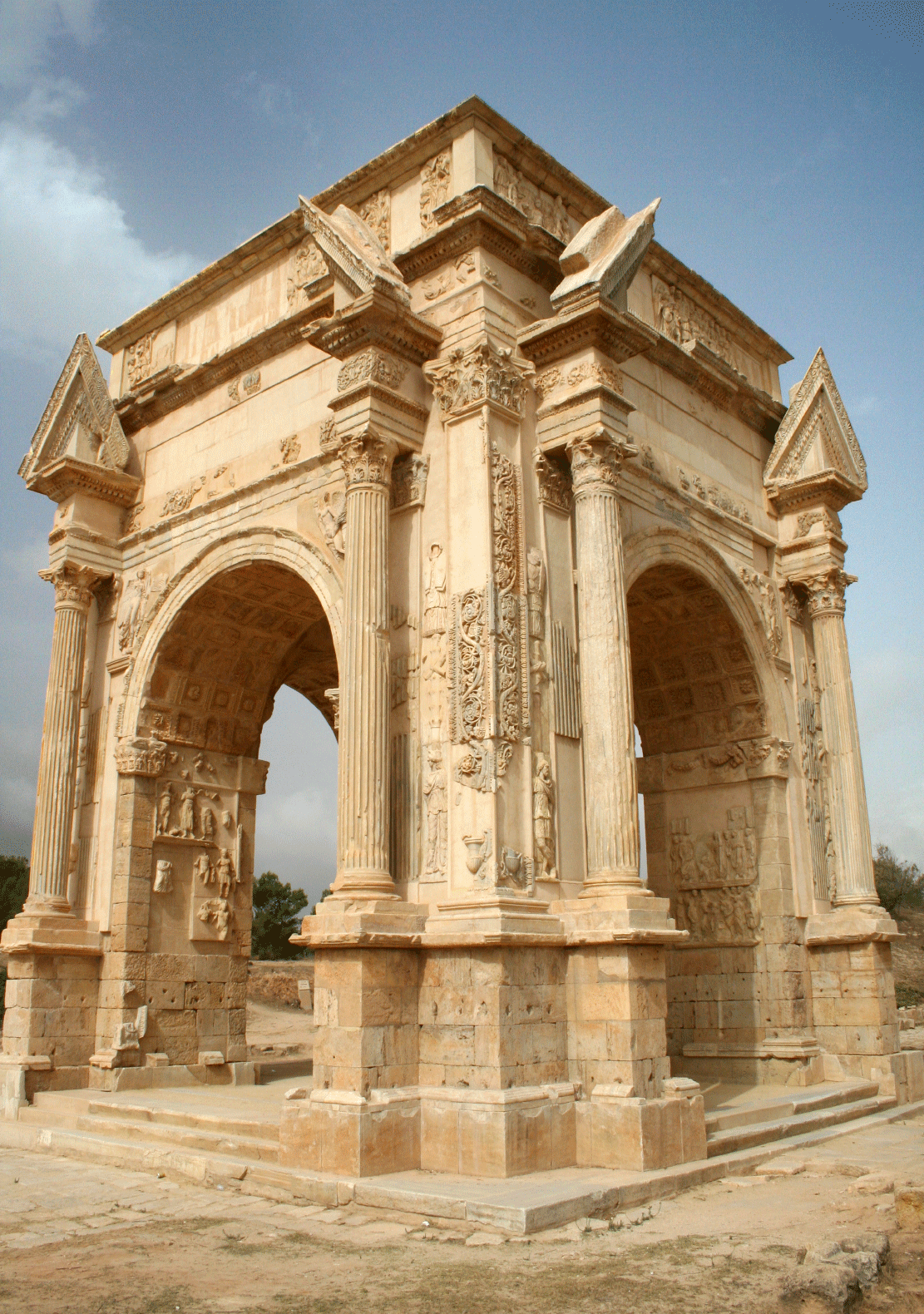
Elevato all’incrocio tra cardo e decumano, esso succedeva agli archi minori di Tiberio e di Traiano nonché a quelli di Marco Aurelio e di Antonino Pio, disposti rispettivamente sulle due vie. Sopraelevato di tre gradini sul piano stradale, e quindi inaccessibile ai carri, più che nodo di transito e di passaggio costituiva un vero e proprio monumentum urbano. A fianco di ogni fornice, colonne libere corinzie, su alti piedestalli, si staccano dai piloni segnati e rinforzati negli angoli da pilastri anch’essi corinzi ma di maggiore altezza, mentre al di sopra dei capitelli è un rincorrersi e un nascondersi reciproco di membrature: sulle colonne la cornice della ricca trabeazione dal fregio pulvinato, scolpito a girali di acanto, si riduce a due spezzoni in risalto, sui quali poggiano quarti di piramide, introducendo un motivo a frontone spezzato drammatico e suggestivo; la trabeazione sostenuta dai pilastri, forse ancor più ricca ed elaborata, sembra insinuarsi con architrave e fregio dietro la composizione timpanata, riapparendo con la cornice completa a reggere l’attico popolato da immagini di cortei trionfali, di sacrifici, di cerimonie con scene di battaglie, di incoronazioni (di Caracalla e di Geta), divinità e Vittorie nelle parti inferiori, figure allegoriche poste ad esaltare Virtus, Pietas e Concordia, tutte opere di alta qualità eseguite da scultori provenienti da Afrodisia attivi in quel tempo nella città. Regnava sul tutto l’attico quadrifronte: sostegno di potenti gruppi scultorei, e a un tempo maschera dell’estradosso della cupola impostata sulla crociera interna. Con simili tagli, riapparizioni, inserti, sconcertanti a prima vista, ma non difficili da seguire con un poco più di impegno, si erano raggiunti effetti ricercati, forse voluti per calamitare (e sorprendere) l’attenzione dei passanti in siti paesisticamente monotoni e monocromi, ove mai nessun trionfo si sarebbe realmente celebrato.
L’Arco di Costantino e gli ultimi archi di Roma
|
Roma |
Con l’intuito e la sensibilità per il mondo delle forme che pochi letterati nella storia condivisero con lui, nella celeberrima lettera sulle antichità di Roma redatta per Raffaello Sanzio e a nome dell’amico inviata a papa Leone X, Baldassarre Castiglione colse e descrisse i caratteri salienti dell’Arco di Costantino: un arco a tre fornici eretto sulla via dei cortei trionfali nel tratto che dal Circo Massimo giungeva alla Velia, decretato dal Senato in onore dell’Augustus vittorioso a Ponte Milvio (28 ottobre 312 d.C.) sul rivale Massenzio, che annegò nel Tevere con gran parte del proprio esercito.
Terminato tre anni dopo l’evento, fu dedicato a Costantino per le celebrazioni dei suoi decennali il 25 luglio 315 d.C., come ricordano due iscrizioni sul lato del Colosseo:
IMP[ERATORI] CAES[ARI] FL[AVIO] COSTANTINO MAXIMO / P[IO] F[ELICI] AUGUSTO S[ENATUS] P[OPULUS]Q[UE] R[OMANUS] / QUOD INSTINCTU DIVINITATIS MENTIS / MAGNITUDINE CUM EXERCITU SUO / TAM DE TYRANNO QUAM DE OMNI EIUS / FACTIONE UNO TEMPORE IUSTIS / REM PUBLICAM ULTUS EST ARMIS / ARCUM TRIUMPHIS INSIGNEM DICAVIT.
"All’imperatore Cesare Flavio Costantino Massimo, Pio, Felice, Augusto, il Senato e il popolo romano, poiché per ispirazione della divinità e per la grandezza del suo spirito con il suo esercito vendicò a un tempo lo stato su un tiranno e su tutta la sua fazione con giuste armi, dedicarono quest’arco insigne per trionfi".
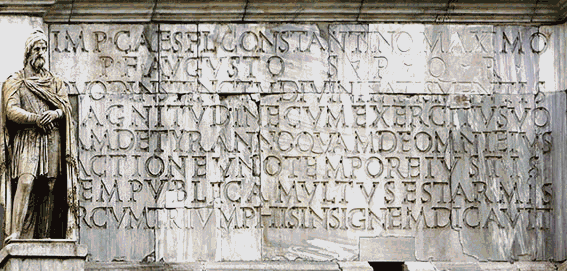
Com’è noto l’ambigua espressione "instinctu divinitatis" sarà interpretata come una dichiarazione da parte di Costantino di un impulso all’impresa vittoriosa conferitogli dalla protezione del nuovo, unico Dio che, proprio in quegli anni, andava affermandosi non soltanto a Roma ma in tutti i territori dell’Impero.
Nello scritto di Castiglione e Raffaello si distingue tra forma architettonica e decorazione scultorea: giudicata la prima ben ordinata e proporzionata, la seconda ridondante, affollata di figure scomposte, animate di un pathos eccessivo. Senza essere storici o archeologi, gli autori della lettera non si ingannavano: della difformità e dello scontro tra diversi sistemi figurativi diedero poi ragione gli studi accurati e comparativi degli storici e archeologi del XIX e XX secolo. Non solo le membrature architettoniche furono modellate e poste in opera a imitazione di quelle del I e del II secolo d.C. (età di Traiano, di Adriano, di Settimio Severo) ma la decorazione scultorea risultò essere un montaggio di materiali di spoglio di epoca diversa e, quelli coevi all’arco, decisamente lontani dalla tradizione nobile e aulica di ascendenza o ispirazione ellenistica.
L’Arco di Costantino è il più imponente per dimensioni degli archi rimasti: alquanto più tozzo ma del tutto simile all’arco di Settimio Severo, esso raggiunge quasi i venticinque metri in altezza.

Quattro colonne corinzie per fronte – otto in totale – poste su alti piedestalli, a cui fanno riscontro altrettante paraste scanalate retrostanti, inquadrano i fornici, i sovrastanti blocchi a rilievo, gli spicchi sopra gli archivolti. L’aggetto delle colonne comporta quello dei corrispondenti segmenti della sovrastante trabeazione e, superata quest’ultima, dei pilastrini nell’attico, a riquadro dei pannelli scolpiti a bassorilievo e dell’iscrizione dedicatoria centrale; sulle sporgenze al termine delle membrature verticali posano e si erigono innanzi figure di barbari prigionieri (Daci in vincoli, presi dal Foro di Traiano) pur se la battaglia celebrata era contro altri Romani (ma contava, evidentemente, trasmettere l’idea della sconfitta subita dai nemici).


Diversamente dagli archi che lo precedettero, non vi erano gruppi statuari sull’attico, che era decorato soltanto da una semplice modanatura rientrante, a chiusura di un podio liscio squadrato.
Gli elementi architettonici costituiscono un intenzionale, deciso ritorno alle forme del passato, confermato dall’uso del materiale di spoglio. Alcune membrature e molte parti della decorazione risultano, infatti, da un assemblaggio di parti provenienti da vari monumenti dell’Urbe, anche se ‘forzati’ alla celebrazione del vincitore mediante tòpoi che esprimevano universalmente e immediatamente l’insieme di valore militare e di virtù civili-religiose, retaggio proprio di un imperatore.
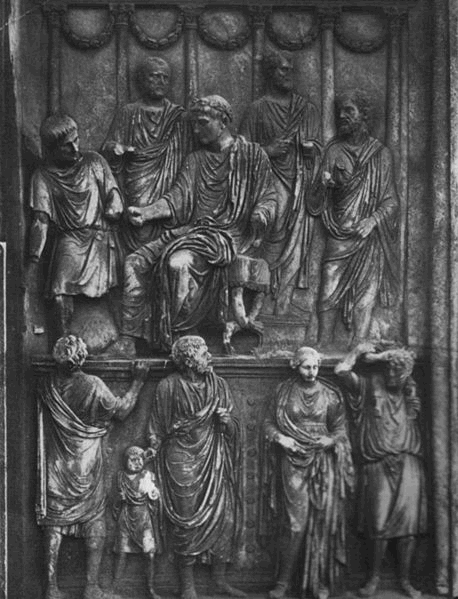
Il cornicione sotto l’attico è di età antoniniana, i capitelli e i fusti delle colonne sono tratti da un edificio del II secolo d.C.; a segnare l’imposta dell’archivolto e della volta del fornice maggiore, corre la cornice di un monumento del secolo successivo; le restanti membrature architettoniche sono coeve all’età di Costantino, riconoscibili per la tecnica scultorea e la tendenza a trasformare gli elementi vegetali in un astratto ornato.

Sui piedestalli delle colonne, scolpite sulle tre facce, sono Vittorie stanti accompagnate da trofei e barbari prigionieri; nei timpani semicircolari del fornice centrale stanno Vittorie alate e le figure allegoriche di due stagioni, mentre in quelli dei fornici minori appaiono varie divinità fluviali; in tutte le chiavi di volta sono scolpite figure allegoriche quasi del tutto distrutte.

Tali rilievi sono coevi all’arco, e coevi sono anche i fregi lunghi e stretti scolpiti a rilievo subito al di sopra dei fornici che, prolungandosi anche sui lati brevi, cingono l’intero monumento, rappresentando in sequenza temporale le vicende salienti della campagna di Costantino contro Massenzio e del suo rientro o adventus in Roma, l’oratio (il discorso), il congiarium e la largitio (le donazioni) che lo seguirono. Si riconoscono i teatri urbani delle nobili azioni imperiali: le colonne onorarie di Diocleziano, l’arco di Settimio Severo, l’arco di Tiberio e la basilica Giulia, il Foro di Cesare.
Nei rilievi eseguiti appositamente per l’arco trionfa il pieno e il concitato, è scomparso ogni suggerimento di profondità spaziale, riempita da una quantità di corpi le cui proporzioni sono alterate in favore dell’accentuazione delle espressioni o dei movimenti; le botteghe che li eseguirono erano verosimilmente soprattutto legate alla tradizione che viveva e si tramandava nei sarcofagi meno aulici e più popolari.
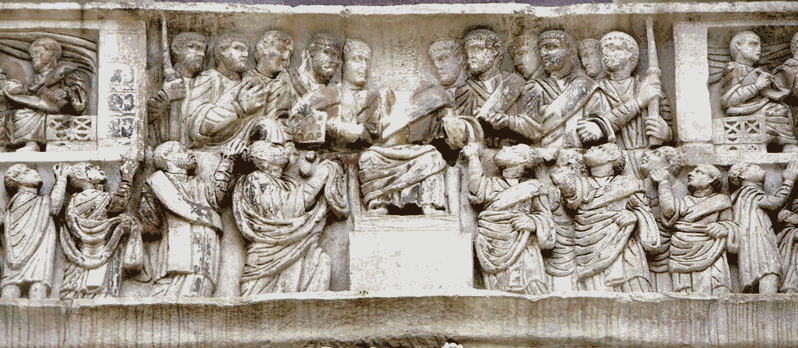
Gli otto tondi sopra il fregio, quattro per banda, di quasi due metri di diametro, sono di età adrianea – provenenienti probabilmente da un arco a tre fornici dinnanzi a un tempio in seguito dedicato a Eliogabalo – e rappresentano momenti della vita dello stesso Adriano e del favorito Antinoo: le partenze per la caccia, la sfida, il coraggio e la forza giovanile, l’intimità cercata con le forze della natura e delle divinità silvane; le teste di Adriano sono state riscolpite e trasformate in quelle di Licinio e di Costantino, divenendo ritratti di altissima qualità, tra i migliori di tutto il IV secolo d.C. e per accompagnare i tondi adrianei sui lati brevi furono apposti due tondi costantiniani con le rappresentazioni della Luna (ovest) e del Sole (est) dalle vesti fluttuanti nei loro carri in corsa.


Al di sopra del cornicione, sulle facciate meridionale e settentrionale, ai lati delle targhe con le iscrizioni dedicatorie furono collocati otto grandi pannelli (quattro per fronte, alti più di tre metri) appartenuti probabilmente a un arco quadrifronte dedicato da Commodo al padre Marco Aurelio: rilievi sfumati di magnifica fattura, che rappresentano episodi bellici contro Quadi e Marcomanni, e che ripropongono tòpoi connessi all’estrinsecazione delle virtù imperiali assai simili a quelli della Colonna Traiana.
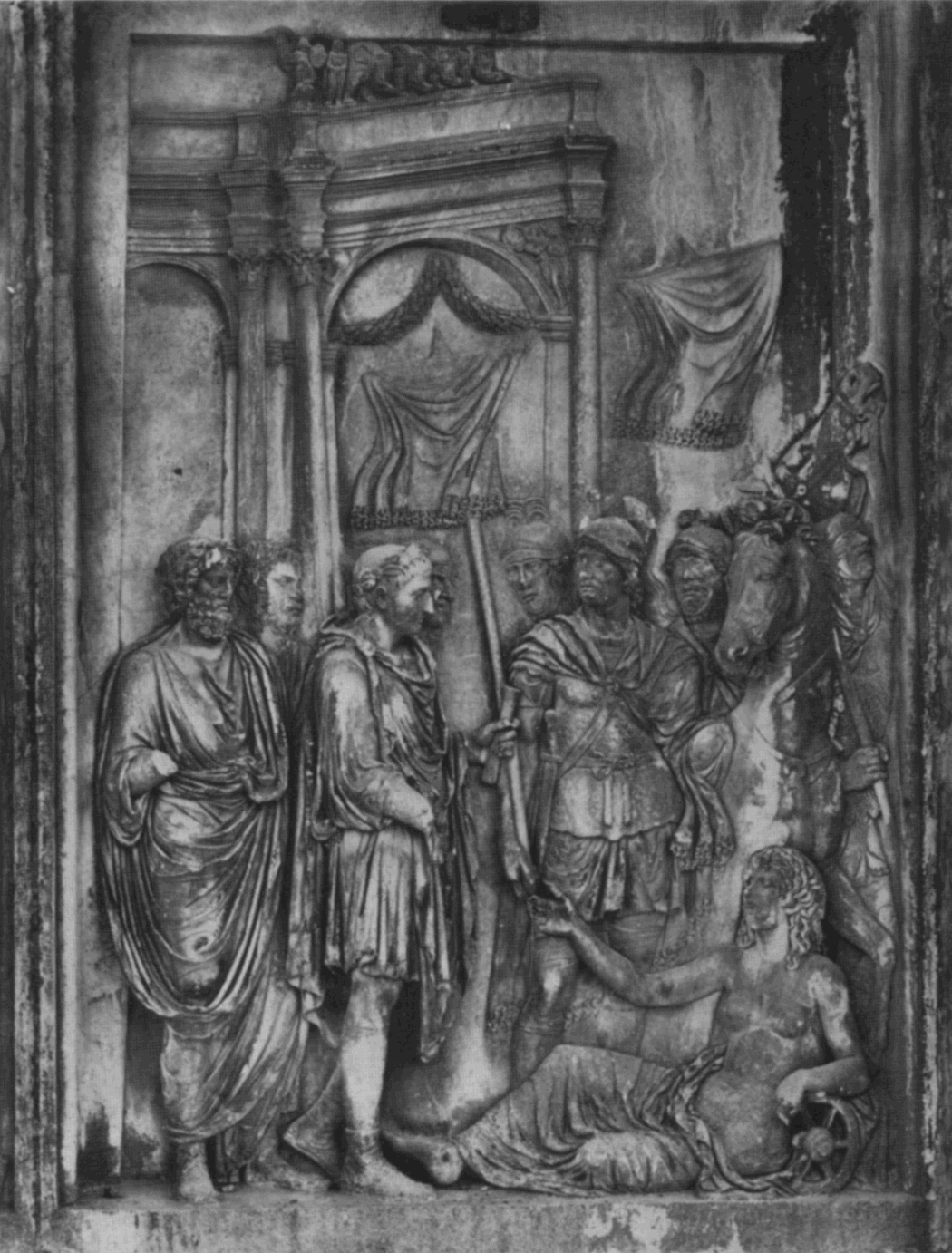
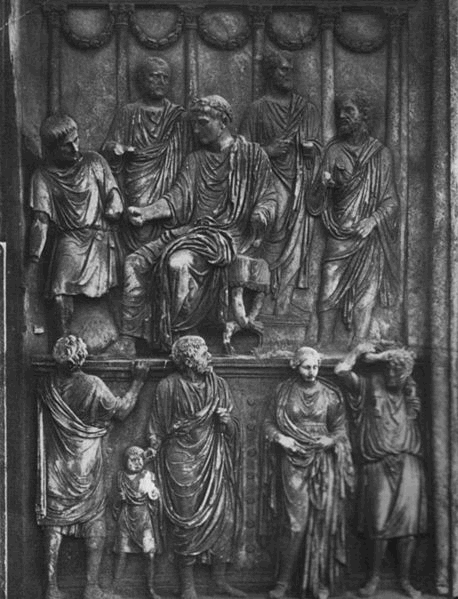

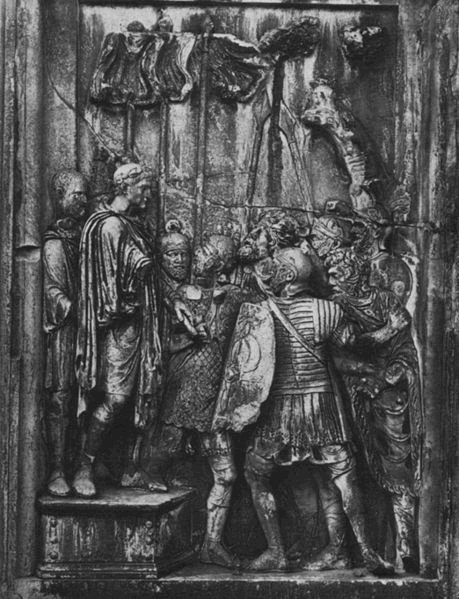

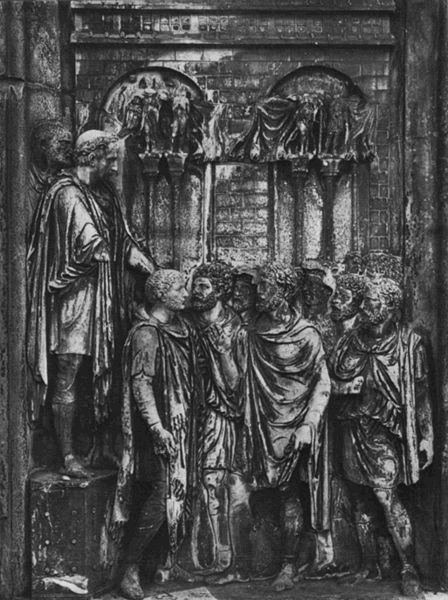

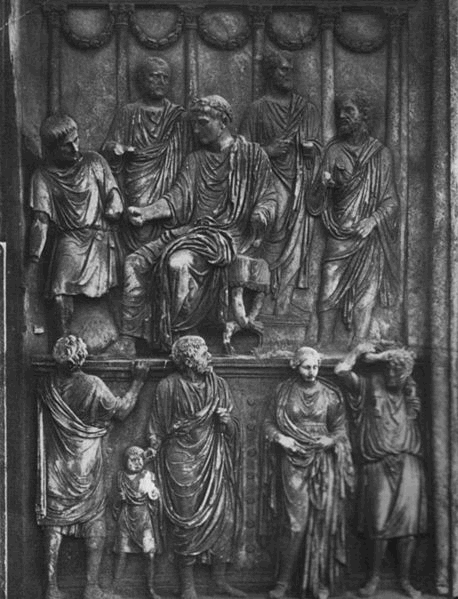
Per completare il ciclo, sui fianchi occidentale e orientale dell’attico furono apposti due rilievi con episodi bellici di età traianea (alti circa tre metri), che si collegavano con altri due collocati sui lati interni del fornice maggiore: erano tutti segmenti di un grande rilievo storico (lungo una ventina di metri) che proveniva dal Foro di Traiano, e il cui autore fu verosimilmente lo stesso della colonna (dallo stesso Foro di Traiano, come si è visto, provengono anche gli otto Daci stanti prigionieri, posati sui tratti a risalto della cornice).
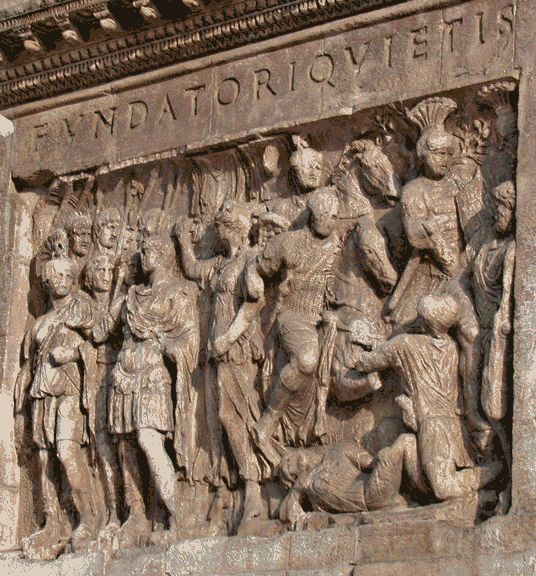
Scavi e studi recenti (1992) hanno evidenziato due fasi nella costruzione dell’arco: una prima, con muratura molto accurata, sarebbe giunta fino al grande cornicione marcapiano di marmo preconnesio, una seconda, caratterizzata da lavoro più grossolano, avrebbe realizzato l’attico poi rivestito dalle lastre scolpite di riporto e spoglio e dalla iscrizione dedicatoria. Sarebbe pertanto avvalorata, ma ancora lontana dall’essere confermata, l’ipotesi che l’arco di Costantino sia stato generato dall’ampliamento di resti o nuclei di due precedenti strutture: l’una facente parte della Domus Transitoria neroniana, l’altra appartenente a un arco a unico fornice dell’età di Domiziano.
Per celebrare la vittoria di Costantino su Massenzio si costruirono a Roma altri due tetrapili. L’arco quadrifronte cosiddetto ‘di Giano’ al Foro Boario risale alla prima metà del IV secolo d.C. ed è tributato non solo all’imperatore vittorioso ma anche a suo figlio Costanzo II: i suoi quattro massicci piloni sono costruiti in muratura a sacco e rivestiti da lastre di marmo di recupero; le volte a botte dei fornici si raccordano al centro con volta a crociera.

Due registri di nicchie con semicalotta in forma di conchiglia rovesciata articolano le masse dei piloni e le chiavi degli archivolti recano scolpite le figure (in realtà ora appena percettibili) della dea Roma e di Giunone sedute, di Minerva e di Cerere stanti. Il corpo stesso dei quattro fornici era sormontato da un alto attico in laterizio rivestito da lastre di marmo recanti l’iscrizione dedicatoria, distrutto nel 1830 perché ritenuto un’aggiunta medievale (per un approfondimento sull'arco di Giano vedi il contributo di Marco Paronuzzi, Laura Zanchetta in questo numero di "Engramma").
Il secondo tetrapilo sorge sulla via Flaminia inglobato nelle strutture di un casale medievale nell’attuale località di Malborghetto: la pianta è rettangolare e l’alzato in laterizio a sacco è scandito da fasce di rivestimento di travertino, un tempo decorato da coppie di colonne libere sui lati maggiori e da lesene sui minori. I fornici proseguivano voltati a botte inoltrandosi nella massa, al cui centro formavano una crociera.

L’arco trionfale, nonostante le lontane suggestioni che provenivano dalle porte delle agorài ellenistiche o dalle porte urbane delle città etrusche, fu certamente un manufatto d’invenzione romana e rimase sempre un segno distintivo e peculiare delle città appartenenti all’Impero, poiché conservò la sua funzione purificatorio-espiatoria di segnale di un rito di passaggio, ma assunse anche fini celebrativi-commemorativi (e spesso propagandistici) che serbavano vivi i momenti cruciali della storia di Roma al popolo romano, e rammentavano l’ineluttabilità del dominio universale dell’Urbe anche ai nemici e ai barbari di un tempo. E certo, oltrepassando i limiti del proprio tempo, gli archi romani costituirono, specialmente per l’età moderna, un repertorio generoso di suggerimenti e ricco di variazioni sulle varie forme di connubio tra sistemi arcuati e trabeati, e di accostamento di sistemi trabeati di altezze diverse.
Epilogo narrativo: le origini dell’arco
Pur essendo nella forma realizzata e nei significati assunti una creazione propriamente romana, il suggerimento della forma e della tecnica costruttiva dell’arco potrebbe essere giunto ai Romani dai loro vicini Etruschi o Greco-italici. Tesi contrapposte dividono gli studiosi al riguardo: per alcuni l’arco – o l’idea dell’arco – deriva direttamente dai propilei delle acropoli e dei santuari greci, o dalle porte monumentali delle città e delle agorài ellenistiche (ricordiamo, per tutte, la Porta di Mileto); per altri, esso costituisce l’esito dello sviluppo autoctono della porta triumphalis o di altri passaggi connessi con la pompa triumphalis, la quale nei tempi più antichi prevedeva all’inizio della cerimonia il passaggio attraverso una porta simbolica, probabilmente un’architettura effimera.
Porta e passaggio – portus e passus – sono in realtà sinonimi: l’attraversare un passaggio assumeva un significato catartico di purificazione dalle passioni; il trionfatore accompagnato dal suo corteo si portava lungo la Via Sacra al Tempio di Giove Capitolino, dinnanzi al quale scioglieva i voti contratti all’inizio della spedizione, e si purificava dalle azioni sanguinose compiute.

Oswald Achenbach, Passaggio sulla via Sacra sotto l’Arco di Tito, 1890 ca., collezione privata
Valgono le ragioni dell’uno e dell’altro versante critico-interpretativo. Alla nascita dell’arco, del suo significato e della sua forma, presiedono culture diverse; vi concorsero, verosimilmente, la tradizione greco-ellenistica del propileo, quella etrusco-italica della porta urbana arcuata, la tradizione della colonna votiva e onoraria innalzata su basamento – talvolta duplicata nei monumenti funebri e onorari – il cerimoniale del trionfo e, con questo, la concezione dell’arco come monumentale basamento per la scultura celebrativa del triumphator e assieme come soglia rituale.
Sostiene Plinio il Vecchio che l’arco, al pari della colonna onoraria, era una struttura deputata ad elevare un mortale dalla terra al cielo che, facendo proprie le forme ellenistiche, arricchì e complicò l’originale significato della porta urbica italica, al punto da apparire quasi una fabbrica nuova novicio inventu (Naturalis Historia, XXXIV, 27): una fabbrica “di nuova invenzione”, tutta romana.
English abstract
Since the Republican age, the honorary arch and the ceremony of triumph are the highest honor granted by the Senate to the leader invested with the imperium maius, who won a crushing victory against a foreign enemy. In this essay by Paolo Morachiello and Vincenzo Fontana (taken from the volume L'architettura del mondo romano) it is emphasized that the triumphal arch is a monument destined to fix forever – thanks to its architectural typology – the memory of an illustrious person – l 'imperator or, more rarely, a gens or a worthy magistrate. In an exciting journey through time (from the late Hellenistic age to the 4th century AD) and in space (across the borders of the Roman provinces) - the two authors guide the reader to learn about some of the most famous honorary and triumphal arches that dot the territory of the Empire.
keywords | Roman triumphal arch; Roman Empire; thriumphal ceremony; triumphal arch morphology; triumphal arch genealogy.
Per citare questo articolo / To cite this article: V. Fontana, P. Morachiello, L'arco trionfale e onorario romano. Apparato iconografico (a cura di) A. Pedersoli, “La Rivista di Engramma” n. 66, settembre/ottobre 2008, pp. 11-73 | PDF